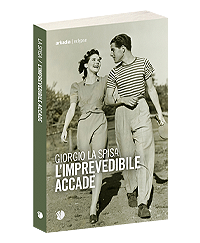Il bel viaggio
IL PAESE
Il paese è una riscoperta e un mistero, ovvero l’incrocio fra ricordi sfrangiati dall’usura dei giorni e degli anni e l’ignoto dell’oggi. Poche strade, case, cortili, rare persone, qualche auto.
Incontro brandelli di memoria sfumati più che dal tempo dall’incuria, dall’averli considerati, nel tempo, irrilevanti.
Poi, come per una messa a fuoco graduale e sempre più precisa, le forme e le memorie assumono lineamenti netti e riconoscibilità inattese.
Già da quel che resta dell’antico, quello che non è stato rifatto e reso banalmente attuale, ricavi l’idea del vivere così come è stato in un’epoca nella quale la modernità non era ancora pervenuta.
La pochezza delle costruzioni sembra richiamarne la funzione di riparo essenziale, dell’essere cioè quelle case, prossime all’idea di un semplice rifugio.
Sembrano, nel loro disegno elementare, talvolta con tratti di irregolarità, raccontare la quotidiana fatica di chi c’è vissuto. Come se, attraverso muri rugginosi di muschi e finestre sconnesse e cadenti, potessi percepire fisicamente l’odore del fumo e del sudore accumulati in giornate di manovalanza, il sentore del poco insufficiente a sopperire alla povertà. Come se l’aspetto dei piccoli portoni rinforzati da lamiere di zinco inchiodate al legno dichiarasse la separatezza di ciascuna famiglia dal resto della comunità.
I segni del vissuto raccontano le storie di donne e uomini costretti a restare parte negletta delle vicende più grandi finché queste ultime non li chiameranno in causa come insieme, come massa, mucchio, esercito. Più numero che singole persone a sostenere il protagonismo di altri.
Ce ne sono, di case, che hanno conservato, almeno in parte, il segno della loro storia. Che tu puoi cogliere con diversi sensi. Nell’entrarvi ti muovi su antiche lastre di ardesia mal connesse fra loro, tanto che il passo deve essere, se non guardingo, attento. C’è un’aria, in giro, che è l’insieme di tanti odori prodotti dalle stagioni trascorse.
Sentore del grano raccolto nei sacchi tessuti a mano, profumo del granturco accumulato dopo il lavaggio e l’asciugatura al Sole, delle mele cotogne o dei meloni, conservati nelle soffitte per l’inverno.
Talvolta sono essenze inebrianti come quella del mosto che in tempo di vendemmia sconfinava dall’uno all’altro cortile.
Vedi qualche antica pala da forno liscia e lucida per l’usura, avverti con il palmo della mano la calda consistenza della coperta di lana grezza intessuta nel telaio domestico.
Le case parlano e dicono più di quel che non sappiano i loro abitatori, timidi e quasi vergognosi del loro essere sopravvissuti in un borgo probabilmente senza futuro.
***
Fin da bambini, le forme delle case ci sorpresero, per la loro diversità, rispetto a quelle cittadine.
Da Cagliari ci eravamo allontanati precipitosamente in un cupo settembre del Quarantadue, come migliaia di cagliaritani, già stremati da due anni di guerra e di patimenti, e che dalla città cercavano nei paesi, quelli di origine soprattutto, una via di scampo dal terrore dei bombardamenti che, a ondate, si rovesciavano sul capoluogo sardo.
Mio padre aveva organizzato l’esodo portando via tutto quel che riempiva il nostro appartamento nella via Manno. Era riuscito, con tenacia e senza risparmio di energie, a mettere ogni suppellettile e mobile su un vagone merci delle Ferrovie dello Stato e a indirizzarlo al paese natio. La famiglia seguì lo stesso percorso, in treno fino a Giave poi su un carro, una tumbarella, fino a Cheremule.
Il paese ci apparve adagiato sul costone di una collina di pietra vulcanica, a cinquecento metri d’altitudine. Sovrastato dalla mole del Monte Mannu, che chiudeva l’orizzonte a nord-ovest, si affacciava a meridione su una vallata ampia e solatia, definita, sul versante opposto, da colline di calcare che ne esaltavano la luminosità.
Dove la valle si allargava a levante, verso la pianura, era coperta da un grande bosco di querce, ricco di sorgenti e di vestigia di antichi insediamenti.
L’abitato era disposto sul fianco della collina e si sviluppava lungo la sua strada principale come un festone al quale erano collegati diversi viottoli in discesa, alcuni dei quali convergenti sulla piazza principale, dominata dall’antica chiesa medioevale. A occidente incombeva invece il Monte, in gran parte coperto da una pineta adulta.
Il borgo contava quasi mille anime. Di cosa vivessero è facile immaginare. Meglio forse dire di cosa sopravvivessero, considerate le condizioni dell’agricoltura praticata nei declivi verso valle e l’esigua attività pastorale nella quale era impegnata una parte dei paesani.
Allora, come oggi, le case furono l’oggetto della curiosità e della meraviglia di quel nostro primo arrivo.
Costruzioni modeste e primitive messe su con pietra lavica, e organizzate su uno schema essenziale incentrato sul focolare posto nelmezzo dell’unica stanza che fungeva da soggiorno, da cucina e da luogo di produzione, nel quale si quagliava il latte da trasformare in formaggio. Il fumo del focolare s’innalzava nel locale per trovare sfogo attraverso le fessure appositamente praticate fra le canne del tetto.
In noi bambini, cresciuti in città, suscitava meraviglia la convivenza delle persone e degli animali: le galline razzolavano all’esterno come dentro le case, nelle quali talvolta era possibile trovare alloggiata la capra che forniva il latte per il consumo familiare.
Nel villaggio si trovavano anche abitazioni di minor disagio e di miglior decoro. Erano le case dei pochi benestanti, dei proprietari dei più consistenti patrimoni terrieri, del mugnaio, del medico e del parroco. Erano quelle abitazioni sistemate in maniera, diciamo così, più consona al vivere civile e alla modernità.
Dopo il nostro arrivo trovammo ospitalità, per intercessione di alcuni parenti, presso un’anziana signora che disponeva di una camera da letto sufficientemente attrezzata da poterla concedere in affitto e comprensiva di uso della cucina.
Vi soggiornammo per quasi due anni, mamma e noi due bambini, mentre nostro padre, militare in servizio, sia pure non lontano, veniva a trovarci di tanto in tanto, quando gli era consentito.
La cucina era costituita da uno stanzone rustico, con al centro il focolare e su un lato la cupola del grande forno per la cottura del pane. Le pareti e il sottotetto di canne erano laccati da una compatta patina nera di fuliggine. Dalla cucina si accedeva al cortile, che svolgeva diverse funzioni, dove tra l’altro si allevavano le galline e il maiale, in attesa di immolarlo a novembre in occasione della festa di Sant’Andrea.
Nell’angolo più riposto del cortile, a ridosso dell’alto muro di cinta, vi era uno spazio per i bisogni corporali, l’assolvimento dei quali era non raramente disturbato dall’invasivo grugnire del suino.
Quel muro rappresentò per me, fin dal primo momento, una ragione di curiosità e un incombente mistero da svelare. Cosa si trovava al di là? Si intuiva che non dovessero esserci altre abitazioni perché non se ne avvertivano i rumori e il normale vociare delle persone che vi avrebbero vissuto. Forse una campagna, forse una pietraia?
Appresi che il sito si chiamava S’oltu ’e nanti, quindi doveva trattarsi con tutta probabilità di un terreno coltivato. Nelle esplorazioni, caute, che svolgemmo noi bambini, quello spazio restò, per un certo tempo, l’area della curiosità inappagata, del mistero.