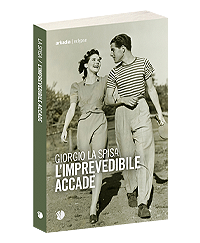Il parruccaio di Maria Antonietta
1
La Capitale de la Nation Françoise est regardée depuis long-tems, comme la source & le modèle du goût dans
les Arts d’agrément & d’utilité, comme dans les productions de l’esprit chez tous les Peuples de l’Europe…
“Le Cabinet des Modes”, Paris 17**
Il Tribunale Speciale Rivoluzionario impose di chiudere in fretta il fascicolo, classificando l’imbarazzante caso come quello di un semplice alienato con i nervi consumati dall’oppio. Charles-Henri Sanson, Provveditore alle Alte Opere di Parigi, grazie alla sua influenza e all’amicizia con diversi magistrati che avevano presieduto il vecchio tribunale dello Châtelet, ottenne da uno di questi che le indagini proseguissero in maniera riservata. Due funzionari di polizia furono spediti nella città nativa del condannato e interrogarono i pochi anziani che conservavano memoria del soggetto: si trattava di un caso fuori dal comune. Quanto scoperto fu trascritto in un verbale confidenziale ritrovato casualmente negli archivi della Conciergerie e costituisce sommaria ma verosimile ricostruzione di una vicenda che nessun cronista aveva riportato.
Pare avessero iniziato a chiamarlo Salamandre a quattro anni perché sul viso gli era scurita una sinuosa voglia purpurea che, appena percettibile alla nascita, si era intensificata fino a diventare di uno sgargiante color vinaccia. La macchia partiva dal naso e attraverso le tempie strisciava fino al sommo del capo. Le orecchie sproporzionate germogliavano come petali cartilaginosi dalla corolla ossea del cranio e ai coetanei ricordavano le branchie dei girini di salamandra che si pescavano negli stagni.
Quando un soprannome è azzeccato ti si attacca addosso come la rogna e non c’è verso di grattarlo via.
Come non fosse bastato, Jules-Henri Salamon, figlio di François, pettinatore di lana e stimato membro della corporazione dei cardatori del comune di Saint-Denis, poche leghe a nord di Parigi, aveva capelli fini, delicati e biondissimi, come fili di bava di ragno. Quella seta impalpabile luccicava al sole come oro e non dissimulava il nastro violaceo che gli percorreva il viso fin sotto la cute, lo faceva piuttosto risaltare come un rubino incastonato nell’oro.
Se il sole evidenziava il suo marchio, gli occhi del ragazzo si vendicavano rifuggendone i raggi: l’iride azzurra con screziature viola, mal sopportava la luce e per questo poteva uscire solo all’alba o al tramonto. Come l’anfibio alchemico.
Chi ne parlava non lo trovava brutto; era strano, indefinibile. Se bello fosse stato, sarebbe stato di un’avvenenza esotica che pochi avrebbero riconosciuto come certe nuove infiorescenze provenienti dalle colonie oltreoceano del Regno di Francia: la Martinica, la Guadalupa o la Louisiana.
Col tempo imparò a infilarsi un berretto di lana per coprire quell’impronta d’infamia ma i suoi coetanei, è risaputo che i mar- mocchi non hanno pietà per chi è diverso da loro, si divertivano a rubarglielo e a passarselo tra loro.
Jules-Henri non ci pensava su molto: si ribellava, li rincorreva, li graffiava e li mordeva poi si buttava per terra a quattro zampe raccogliendo il berretto sporco e impolverato. Sollevandosi sulle ginocchia, lo infilava in testa. Si calmava quando lo aveva calcato fino agli occhi come se il celarsi fosse stato risarcimento, un indennizzo per quelle umiliazioni. Allora i suoi compagni iniziavano a ridere e a urlare: «Salamon Salamandre… Salamon Salamandre!» Afferravano scope di saggina sottratte alle massaie e gliele fracassavano sulla testa. Non contenti, lo acchiappavano per braccia e gambe e lo trascinavano fino alla riva di un basso canale che attraversava il borgo. Puntellati i piedi lo facevano oscillare ritmicamente come un’altalena e, guadagnato lo slancio sufficiente lo gettavano nel punto dove l’acqua era più alta e la corrente più forte.
Jules-Henri era pacifico e meditativo per natura ma non remissivo; quando doveva si ribellava e si faceva rispettare, tuttavia, se i suoi seviziatori erano troppo numerosi, non gli rimaneva che soccombere.
Ai coetanei non badava: per lui erano solo i cuccioli delle bestie selvatiche che popolavano il borgo di Saint-Denis. Riguadagnata la riva, si incamminava verso casa grondante acqua e, quando era a distanza di sicurezza, si voltava e li guardava come non capisse. Li vedeva agire sempre in gruppo, sempre in sintonia come se le loro azioni, le loro persone, fossero state guidate da una sola testa. Lui no. Lui non aveva amici.
Avvertiva la costante sensazione di camminare in direzione opposta a chi lo circondava. Quello che faceva sembrava sempre sbagliato agli occhi del suo prossimo.
Da quale travaglio era stato espulso alla luce di un mondo che gli era così ostile ed estraneo? Il ventre che lo aveva generato non c’era più. Della madre talvolta gli appariva uno sfolgorio, come un’istantanea rifrazione di luce. Il barbaglio si palesava con l’immagine sfocata di una donna sofisticata ma semplice, regale ma estatica e con un’espressione di impotenza. Un’icona bionda e slavata come una regina normanna che rivedeva sempre attraverso un vetro spruzzato di gocce d’acqua in una giornata piovosa mentre seduta su una seggiola rattoppava dei calzini bucati dentro cui faceva scivolare un uovo di legno. Jules-Henri si sforzava di ricostruirne i tratti ma non riusciva a eliminare lo schermo che si frapponeva tra sé e quel ricordo. Solo l’espressione era chiara: un’impotente richiesta di aiuto di fronte al peso di una vita cui non riusciva a dare un senso o uno scopo. Quando scoppiava un temporale Jules- Henri, usciva nella corte paterna e si piantava davanti alla finestra, trapassando con lo sguardo l’impannata per vedere se la madre si delineasse sulla sedia.
Quando il padre se ne accorgeva, si avvicinava, gli mollava una sberla e lo ricacciava in casa ancora fradicio e tremante. Giunse alla conclusione che alla gente desse fastidio che pensasse. Forse riflettere troppo era sbagliato.
Certo per il suo vecchio era così.
Non sapeva se lo amasse o meno. A dire la verità, non sarebbe stato in grado di definire l’amore. Udiva gli adulti parlarne in relazione al cuore. Aveva osservato Marie-Rose, un’alsaziana dai capelli fulvi, seni prosperosi e la faccia piena di efelidi che il padre si era portato in casa per le faccende domestiche, sventrare le galline e le capre. Non riusciva a capacitarsi di come quei piccoli muscoli rosso-scuro avrebbero potuto ospitare sentimenti. Alla prima occasione, aveva sottratto i cuoricini dei polli e dei conigli, li aveva sezionati con attenzione e scrupolo. Dentro non ci aveva trovato nulla.
Disperato e rabbioso, con le mani rosse di sangue, aveva lanciato i brandelli di carne contro un muro: gli adulti mentivano, parlavano per ammazzare il tempo o per mettersi in mostra.
Quanto al vecchio, non parlava proprio.
Una sera, poche settimane dopo la morte di sua madre, lo aveva visto trascinarsi in camera Marie-Rose. L’aveva sposata il mese successivo. Non avevano perso tempo; poco dopo era arrivato un altro figlio: il fratellastro di Jules-Henri. Dopo il parto la servente si era trasformata nella padrona di tutto. In qualche modo doveva averli infastiditi perché gli sposi avevano deciso di mandarlo a dormire in una stanza, un ripostiglio, sopra la stalla delle capre. Nella sua vecchia cameretta avevano piazzato la culla del neonato: una sorta di cesta ovale di vimini dal cui manico scendevano veli di mussola.
Il giorno del trasloco avvertì un sentimento, non al cuore, ma nell’intrico delle budella, acquattato come un verme solitario che gli sottraesse sostanze vitali. Attendendo che venisse buio accese una candela di sego e scese dalla scala a pioli per andare a dormire con le capre. Gli fecero migliore compagnia degli uomini e si beò della loro mansuetudine e del loro calore.
L’odore delle bestie gli divenne presto famigliare come quello della paglia, dei finimenti di cuoio e dell’olio usato per ammorbidire le pelli. Parlava con loro mentre si stendeva a dormire sulle balle di crine di cavallo su cui aveva allargato uno strato di lana di capra: «Vorrei vedere il suo. Il cuore del piccolo bastardo.» Lo diceva passando la punta di un coltellaccio per raschiare il nero sotto le unghie.
All’alba si alzava per dare il fieno agli animali, poi si recava prima di tutti in laboratorio e sfilava le sbarre di ferro dalle porte e dalle finestre di legno.
«Siamo cardatori da generazioni», diceva con orgoglio il padre François.
Il procedimento per la lavorazione della lana era lungo e complesso. Le fibre arrivavano legate e compresse in balle enormi, su carri trainati da bestiame. Dopo i giorni in cui veniva effettuata la cernita e la divisione per spessore e finezza iniziava il lavaggio in grosse vasche piene di urina animale. Terminata l’asciugatura, iniziava la fase sfiancante della battitura.
Veniva fatto tutto a mano; un lavoro di braccia molto faticoso necessario a liberare le fibre dalle impurità e dai corpi estranei. Seguiva quello lungo e paziente della cardatura in cui si univa ai venti operai che lavoravano per suo padre.
Salamandre afferrava con le piccole mani le impugnature di due assi di legno irte di chiodi e le sfregava una contro l’altra. Poco alla volta l’ammasso di fibre si districava e si separava in mezzo a nuvole di polvere che gli ricoprivano il corpo e la testa bionda; gli otturavano bocca e naso. Macchinari ne esistevano ma non potevano essere usati per ottenere fibre destinate alla filatura perché possedevano denti grossolani e un’azione troppo energica le avrebbe gonfiate, rompendo e tranciando i filamenti.
La fatica era un po’ lenita solo durante la scardassatura delle imbottiture destinate ai materassi; in quel caso era permesso ricorrere alle macchine.
Le lane cardate dalla ditta Salamon venivano vendute a tessitori, tappezzieri e materassai ma il padre ci teneva a riservare le più fini ai parruccai di Parigi che le usavano per le creazioni alla moda.
«È questione di prestigio», gli ripeteva.
Si usava indifferentemente il crine di cavallo o la lana poiché i capelli umani costavano molto.
A dieci anni, Jules-Henri lavorava più di suo padre: dalle sei del mattino fino a quando suonava l’Ave Maria dalle campane della cattedrale di Saint-Denis. I rintocchi bronzei annunciavano che la giornata era terminata.
Il più delle volte, spossato, si sedeva a mangiare un po’ di pane nero, fagioli stantii bevendo latte di capra, addormentandosi con il capo reclinato sul tavolo. Nemmeno il vecchio sapeva cosa combinasse la notte, trafficando tra mille attrezzi e materiali e, a dirla tutta, non gli importava proprio. Gli bastava che il giorno successivo fosse fresco e riposato.
Ma puntualmente Jules-Henri al mattino lavorava come un somaro senza bisogno di essere bastonato. Con una pervicacia demoniaca e con un’energia che l’età non bastava a spiegare.
Il lavoro era la sua droga, la fatica il suo anestetico; la mancata considerazione da parte del prossimo faceva parte della sua vita come il respiro al punto che, anche nei giorni di festa, non tollerava riposo.
La continua attività, il furioso occupare ogni minuto dell’esistenza non calmavano tuttavia il turbinio della sua mente; malamente lo rallentavano.
Osservava tutte le forme di vita, animali e vegetali e quello studio stimolava pensieri che vagavano come cani randagi in meandri, corridoi e anfratti della mente. Esplorava ogni stanzetta delle idee, apriva cassetti inesplorati e la fantasia gli regalava un mondo fatto a misura dei suoi desideri. Il confronto tra il suo stato reale e quello che avrebbe auspicato lo rendeva furioso. Il paragone generava desiderio, il desiderio frustrazione e la frustrazione uno stato di perenne insoddisfazione e malinconia.
La domenica tutti cercavano di dimenticare la propria vita: gli operai di suo padre la trascorrevano dilapidando i magri guadagni nelle taverne di Saint-Denis. Bevevano e si ubriacavano. Litigavano e venivano alle mani. Era il giorno delle sfuriate in famiglia e delle violenze.
Era stato proprio di domenica che un operaio che lavorava con lui aveva picchiato suo padre. Un’altra domenica uno stipettaio ebanista si era impiccato a una corda all’insegna del Drago Rosso.
Avvertiva l’urgenza di evadere. Non suonavano ancora le campane della prima messa che già vagava attraverso prati grassi e gonfi di rugiada o appiattiti dagli sfalci. Si lordava i piedi di fango saltando fossi e canali; s’infiltrava nei boschetti cedui che circondavano Saint- Denis.
Gli odori di aprile e maggio lo eccitavano all’amplesso con la natura. Come un segugio spronato alla caccia girava per i sentieri dove proliferavano essenze e fiori e si fermava a osservare tutto: una pianta di lavanda dalle infiorescenze assediate da insetti, una talpa sbudellata dalla pala di un contadino, una lucertola immobile su un muro ad assorbire i raggi del sole, ma anche gli orbettini d’argento o i colubri neri che i contadini ammazzavano schiacciandoli con il tallone pensando di fare bene.
Indugiava a studiare i piumosi cadaverini dei passeri e dei merli che una pioggia violenta o colpi di vento facevano cadere a terra. Era lì, dove la natura, come una Parca crudele, aveva misteriosamente e spietatamente tranciato il filo di quelle vite, che trovava la sua pace. I “piccoli regni” li chiamava.
Da lì non riusciva a muoversi: si sfilava un sacco dalle spalle e si stendeva sul terreno in modo che i suoi occhi potessero osservare da vicino il brulicare di insetti richiamati dall’odore della decomposizione. Sollevava delicatamente quei leggeri corpi e provocava un terremoto.
Era un tumulto, un’esplosione di minuscole vite. Le silfe, con le loro ampie elitre di colore cupo fuggivano infilandosi nelle fessure del suolo. I saprini, dal dorso lucido color ebano trottavano via abbandonando il cantiere; i dermesti dalla livrea rossa punteggiata di nero tentavano di prendere il volo, ma ubriachi del putridume ingurgitato, si rovesciavano sul dorso esponendo il candore immacolato del ventre.
La caotica frenesia lo ipnotizzava e lo incatenava alla visione di centinaia di bestioline che dissodavano la morte a favore della vita in una misteriosa e incessante offerta alla Creazione. Non si sarebbe pasciuto di quelle osservazioni se altre meno ripugnanti non lo avessero distolto e sviato.
Un ronzio sordo lo faceva voltare verso i fiori dai caldi colori e si deliziava del volo goffo di coleotteri che si infiltravano facendosi strada nel morbido spazio tra un petalo e l’altro inebriandosi di sostanze zuccherine senza conoscere il significato della temperanza ma ingozzandosi come se quella fosse stata l’unica giornata della loro vita.
Solo il venire meno della luce, l’umidità della rugiada e il dolore alla schiena riuscivano a staccarlo dall’universo alchemico dominato da leggi immutabili dove non trovavano posto passioni o vizi ma solo il costante ripetersi di riti e liturgie crudeli. Sapeva allora che doveva riguadagnare il posto tra gli uomini che, soli, conoscevano l’arte spietata di farlo soffrire.
La giornata terminava sul sagrato della cattedrale; si sedeva sotto guglie e statue e dagli scalini osservava passare le carrozze da cui scendevano ricchi borghesi o aristocratici. Erano vestiti con marsine di velluto o raso ricamate con alamari a filo d’oro e indossavano tricorni bordati con piume di struzzo. Anche loro avevano livree diverse a seconda delle specie e dei ruoli che ricoprivano, ma non obbedivano a leggi immutabili quanto all’arbitrio della superbia.
I sogni di Jules-Henri scomparivano col buio, quando dopo cena i ragazzini di Saint-Denis uscivano sulla piazza a giocare. Gli pas- savano accanto e gli urlavano: «Salamon… Salamandre! Salamon… Salamandre!»
2
Saint-Denis e Parigi, 10 maggio 1774
Gli operai avevano terminato di stivare le balle di lana sul barcone e coprivano il carico con teloni cerati che assicuravano ai bordi con corde annodate saldamente ad anelli di metallo.
Nubi scure si addensavano da nord: non si poteva mai sapere. E poi il vecchio François Salamon li aveva minacciati che se la merce si fosse deteriorata non avrebbe dato loro un soldo per il trasporto.
Un paio di barcaioli avevano terminato e, accesa la pipa, inveivano contro i ragazzini che salivano e scendevano dalla chiatta rincorrendosi. Poco oltre, un nugolo di mocciosi stava ripescando dalla Senna la carcassa di un gatto dopo che un paio di loro si erano divertiti ad annegarlo dentro un sacco riempito di sassi.
Gracchianti massaie inginocchiate e curve sopra lavatoi dimenavano opulenti posteriori su e giù sfregando i panni sulle tavole marce e scivolose. Di tanto in tanto sollevavano la biancheria fradicia per sbatterla con forza. A intervalli intonavano antiche canzoni e scoppiavano in allegre risate.
Due pontili più in là, un paio di borghesi e un prete stavano contrattando servizi particolari con giovani marinai desiderosi di arrotondare la paga.
Un bastardino con la zampa rotta, passò incespicando. Urinò su un ammasso di corde e qualcuno gli assestò un calcio.
Jules-Henri udì un guaito mentre si sedeva. Lasciò pencolare i piedi dall’orlo della barca, infilò una canna nello specchio d’acqua e iniziò a rimestare sulla superficie componendo cerchi concentrici.
Marie-Rose gli aveva fatto il bagno in un mastello, lo aveva strigliato con una spazzola di crine e lavato con un mattoncino di sa- pone. Dopo averlo asciugato gli aveva infilato una camicia pulita di suo padre: gli stava larga, quindi l’aveva fatta passare sotto le brache rabboccandone le maniche. Jules-Henri passava e ripassava il tessuto sul naso fiutando sentori di lavanda.
Calzava scarpe di cuoio con grosse fibbie in similoro sopra calze di cotone. La giovane matrigna gli aveva anche calcato un tricorno sulla testa. «Così non spaventerai Monsieur Vaubert», aveva riso.
Di solito la merce veniva spedita senza controlli ma, dal momento che i Vaubert gestivano la migliore bottega di parrucche di Parigi, dove vendevano anche profumi e ciprie, nastri e fazzoletti, Salamon padre aveva ritenuto opportuno far scortare la lana da suo figlio.
Salamandre era eccitato ed emozionato.
La navigazione fluviale scivolò senza intoppi e prestissimo furono in vista della capitale del regno. Procedendo placidamente controcorrente passarono sotto il Pont Royal e il Pont Neuf al cui lato era addossata la mole della Samaritaine un volume su cui si arrampicavano titanici condotti di metallo attraverso i quali si pompava l’acqua per i parigini.
La chiatta fu ancorata sotto i fornici del ponte di Notre-Dame: una borgata sospesa sopra arcate di pietra su cui restavano aggrappate come per miracolo abitazioni a quattro o cinque piani, le une addossate alle altre.
Vista dal basso, dalla Senna, la città accentuava la sua verticalità: era un intrico di torri, torrioni, cupole e campanili, guglie, contrafforti, archi e archetti, cuspidi e tetti crivellati da milioni di camini. Aghi e spilli che pungolavano il cielo e sembravano volersi unire a esso tramite i fumi che ascendevano dai comignoli come filo per imbastire.
Al di sotto di quel labirinto, le rive del fiume brulicavano di una vita propria. Nel pieno centro della città più grande d’Europa, casupole fatiscenti si protendevano su spiaggette fangose su cui crescevano moli e porticcioli suddivisi da pali e banchine di un verde-viscido, assaliti da migliaia di imbarcazioni di tutte le misure. Fogne, discariche e canali riversavano liquami neri, rossi e marroni nella Senna, intorbidandone l’acqua e ammorbando l’aria.
Cumuli di rifiuti stratificati accanto a depositi di legna, calce, mattoni, marmi ma anche uova, carni, verdure e merci deperibili di ogni tipo attiravano milioni di ratti e gabbiani accanto a cui convivevano i parigini del fiume. Era un’esplosione di vita nei suoi aspetti più fetidi e rivoltanti.
Il sole era tramontato e l’umidità della sera entrava nelle ossa.
Jules-Henri guardò all’insù provando un capogiro. Al di sopra delle titaniche arcate vedeva le case i cui piani, appoggiati uno sopra l’altro come strati di una torta troppo ardita, parevano sul punto di franare; incombevano con l’arroganza di cattedrali di marzapane. Abbaini, balconi e poggioli sporgevano sul fiume con equilibrio instabile e incosciente. Il corso dell’acqua rifletteva quei giochi statici rattoppati da antiche facciate a graticcio.
Uno dei marinai lanciò un urlo. Qualche istante di attesa e un’imposta a livello della seconda arcata si aprì lasciando intravedere delle luci. Da una carrucola cigolante fu calata una corda da cui pendeva un gancio di ferro e i barcaioli cominciarono ad attaccarvi le prime balle di lana che venivano sollevate e sparivano dentro il ventre sospeso su pilastri. Dopo due ore di lavoro durissimo, senza preavvertirlo, i barcaioli infilarono a tradimento Salamandre dentro una grande cesta e tirarono la corda per far ascendere anche lui.
Le sue urla di paura e sorpresa non intenerirono nessuno tanto che per divertirsi un po’ lo lasciarono penzolare dal ponte, tirando e lasciando andare ritmicamente la corda. Quando ne ebbero abbastanza era buio: lo issarono per l’ultimo tratto, fino in cima, dopodiché sparirono sotto i fornici per ormeggiare la chiatta al porto di Saint-Paul e andare a ubriacarsi in qualche taverna.
Jules-Henri riuscì a riaprire gli occhi solo quando sentì la cesta sbattere contro la parete dell’edificio, si aggrappò all’imposta dell’apertura e saltò dentro. Cadde su qualcosa di morbido dove rimase immobile per riaversi dal terrore.
Si trovava in un magazzino dove alcuni operai stavano finendo di sistemare i colli alla luce di poche lampade. Dal lato opposto al suo, al vertice di una scala di pietra, un uomo in vestaglia di lana si sgolava dando ordini brandendo un fanale di latta come fosse uno scettro. Si volse verso di lui.
«Dunque voi sareste il giovane Salamon!» Jules-Henri annuì.
«Stanotte dormirete qui, sulla lana: vi da noia?»
«No, Monsieur Vaubert.»
«Lì c’è una coperta. Domattina controllerò la merce e, se tutto va bene, ve ne pagherò la metà. Direte a vostro padre che il resto lo salderò alla prossima consegna… sono tempi difficili. Ah, rientrerete domani con quegli ubriaconi di Saint-Denis che fanno volentieri consegne a Parigi solo per le puttane che pullulano come scarafaggi nelle stamberghe di Saint-Paul.»
Fece per andare via, poi si voltò e aggiunse: «Vedete di non spendere i soldi che vi darò anche voi con le donne, per poi raccontare che vi ho pagato meno.»
Il piccolo rise.
L’uomo si avvicinò a lui strascicando ciabatte di velluto damascate in filo d’oro; quando fu a un palmo lo esaminò. «Che mi pigli un accidente! Che avete sul viso? Vi hanno fatto un occhio nero?»
«È una voglia, Monsieur…»
«Mmh… Così pare.» Poi, cambiando argomento, disse: «Avete portato la fattura?»
Anche Jules-Henri lo fissò, concentrandosi su particolari del suo volto; sembrava che ne stesse enumerando i porri del naso.
Gli consegnò un foglio senza distogliere lo sguardo dai lineamenti marcati da rughe e incorniciato da cascami di pelle.
L’uomo se ne accorse. «Che avete da guardare? Siete forse stupido oltre che sfregiato?»
Vaubert afferrò il foglio poi appoggiò una mano sul petto che gli doleva. Gridò congedando gli operai. Risalì la scala a fatica. «Ho perso troppo tempo ed è già buio… Vi lascio una candela, cercate di non consumarla tutta. Lì troverete un po’ di pane bianco e del brodo che credo sia ancora caldo.»
Scomparve dietro una massiccia porta. Salamandre udì un clangore metallico di chiavistello e un rumore di passi.
Era solo.
Esaminò le pareti di pietra e la volta a crociera di mattoni realizzata come usava ai tempi della Pulzella d’Orleans. Il magazzino traboccava di vasi di vetro che contenevano polveri ciprie, spezie e aromi in grani. Accatastate su scaffali stavano fiale di essenze e profumi accanto a enormi rocchetti di legno con nastri di velluto, raso, seta, cotone e lino.
Appoggiati a una parete umida languivano manichini e fantocci di legno e cartapesta con addosso vestiti sbrindellati e coperti di polvere; nel disordine spiccava una montagnola di teste impilate accanto a sfere di sughero, di legno, di corno, tartaruga e avorio.
Sollevò delle gabbiette in filo di ferro dalla forma ovoidale. Ce n’erano ovunque. Sapeva benissimo che non erano trappole, né uccelliere ma intelaiature per parrucche. A Saint-Denis ne aveva viste di alte ed elaborate al punto che si chiedeva come facessero le donne a sopportarne il peso. Appoggiò gli avambracci su una balla di lana e il suo sguardo vagò pieno di meraviglia.
Quel magazzino si rivelò un inatteso paradiso, come il laboratorio del farmacista e speziale fiorentino Bechi in cui trascorreva pomeriggi interi.
Si stese sulla lana e pensò a quello che i barcaioli gli avevano detto durante il viaggio sul fiume. «Tutti i maestri, tutti i membri di corporazione sono dei ladri e degli sfruttatori. Trattano noi operai come degli schiavi e ci pagano una miseria. Le corporazioni sono un’ingiustizia che impedisce ai più bravi di mettere su bottega. Ma tu non sembri figlio di tuo padre. Sappiamo che ti picchia e ti fa lavorare come un somaro…»
Ma lui non condivideva alcun tipo di rancore, anzi chiuso a chiave dentro un magazzino umido sospeso sulla Senna, si sentiva libero come non era mai stato. Essere a Parigi gli sembrava un sogno; sapeva che non sarebbe riuscito a chiudere occhio.
La candela era rimasta sempre accesa; stava per esaurirsi. Doveva trovare un’altra fonte di illuminazione. Cominciò a frugare tra gli scaffali, scavò tra pile e cumuli di materiali di ogni tipo fino a quando trovò una lampada ancora piena di olio. Intrecciò alcuni fili di lino e li usò come stoppino a cui trasferì la fiamma della candela morente.
Sepolta sotto una montagna di pezzi di sughero scoprì una botola di pietra da cui promanava un odore nauseabondo.
Una catena fuoriusciva attraverso un foro ritagliato nella lastra calcarea. Ci pensò e ripensò ma alla fine non trattenne il suo impulso. Iniziò a tirare senza riuscire a spostarla. Intestarditosi, appoggiò entrambi i piedi allo zoccolo di mattoni che la contornava e fece leva con le gambe. Riprese a tirare con tutta la forza fino a quando la catena subì un improvviso scatto all’indietro e si ritrasse facendolo cadere sulla schiena. Un potente risucchio fu seguito dal gorgoglio di un vortice come se una massa liquida sotto il pavimento fosse stata aspirata da una pressione.
Aveva fatto qualcosa che non doveva. Sperando che il rumore non avesse svegliato il vecchio Vaubert, rilasciò la catena e ricoprì nuovamente il portello con i trucioli di sughero.
Riprese a esplorare il deposito fino a quando accanto a un secchio di legno legato a una lunga corda riconobbe un’altra botola, questa volta di legno. La sollevò e una folata di vento lo investì riempiendo il fondaco di aria fresca e umida.
Calò la testa nel pozzetto e poco a poco la vista si abituò al buio. Vide allora l’impetuoso corso della Senna che correva in fondo all’apertura ricavata nello spessore del ponte. Tutti i piani interrati erano stati dotati, fin dalla loro realizzazione, di queste cavità per la raccolta dell’acqua.
Gettò il secchio nel vuoto e quando, tirando, avvertì che era pieno d’acqua iniziò a farlo risalire. Riempì un mastello con l’acqua e poi estrasse il contenuto della sua sacca. Lavorò tutta la notte fino all’alba quando si addormentò esausto.
Erano trascorse un paio di ore quando si svegliò e trovò la porta della cantina aperta. Salì ma non gli fu consentito di entrare nel negozio: era pieno di clienti.
Vaubert lo raggiunse nel retrobottega e gli consegnò un sacchetto con i soldi per la fornitura di lana poi gli fu indicata una porta da cui uscire senza farsi vedere dalle persone di riguardo che affollavano la boutique.
Madame Vaubert aveva occhio per tutto: appena lo vide uscire dal magazzino scese subito a controllare se avesse rubato o danneggiato qualcosa. Non trascorse molto tempo che Jules-Henri e il proprietario udirono un urlo di spavento. Corsero entrambi nel magazzino e videro la moglie del padrone che fissava con occhi sgranati uno dei manichini di legno che Salamandre aveva visto la sera precedente.
La donna teneva le braccia protese in avanti a difendersi da una visione inaspettata che l’aveva terrorizzata. Vaubert, per nulla impres- sionato, si interpose tra la moglie e l’oggetto notando esterrefatto che la testa del pupazzo sembrava aver preso vita. L’iride che ricordava vagamente disegnata da una tempera scrostata risplendeva di un verde smeraldo e le pupille nere e lustre lo scrutavano con fissità. Il bianco dell’occhio era così lucido che sembrava umettato da lacrime appena secrete. Le ciglia nere e folte non erano più tratteggiate da una linea nera ma tremolavano arquate come quelle di una persona che le sollevasse a ritmo. Che cosa diavolo stava succedendo e cosa aveva resuscitato il fantoccio rianimando i colori in quel modo?
Vaubert si protese in avanti e appoggiò le dita sul volto del manichino, i polpastrelli scivolarono indagatori su una scorza coriacea e satinata che gli risultava sconosciuta. Un improvviso trambusto lo spaventò, si voltò vedendo un gruppo di barcaioli sporchi e puzzolenti che irrompevano in negozio, insozzandogli il pavimento pulito come uno stivale da parata.
Allargando le braccia li respinse in strada per nasconderli ai clienti e chiedere come si permettessero una tale intrusione.
Il loro capo prese la parola: «Ieri sera avete svuotato la merda delle vostre acque nere sulla nostra barca! Ci avete rovinato la merce. Dovete risarcirci o vi faremo causa!»
Il parruccaio imbambolato rifletté un istante; sollevato il sopracciglio sinistro si volse per cercare Jules-Henri, ma il ragazzo era sgusciato via, dileguandosi tra la folla che popolava il ponte di Notre- Dame.
«Dov’è finito quel dannato figlio di puttana?»