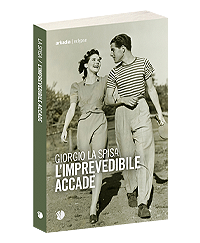La presunta storia vera di Giulia e Giulio
GIULIA
Mio padre è sempre stato un egoista di merda. E un opportunista senza scrupoli. Chi lo ha conosciuto bene, o comunque meglio di noi, non che ci volesse molto, considera tuttavia che l’egoismo e l’opportunismo non siano le sue doti sociali più evidenti. Pare che sia in modo altrettanto evidente egocentrico e snob. Nonché vanitoso, come solo può esserlo una soubrettina sculettante in cerca di successo facile.
Avrei da mettere agli atti una quantità di episodi, dei quali sono stata testimone diretta, e un’altrettanto nutrita antologia di aneddoti, riferiti da amici e parenti, sottovoce, con il tono complice di chi è al servizio della persona che conta e che può solo permettersi la piccola indiscrezione, il commento indelicato gettato lì, en passant. Ne ho conosciuti molti, più o meno in transito alla corte del grand’uomo. Gli indecorosi lacchè di cui ha sempre amato circondarsi, e dei quali però si stancava presto. Gente disposta all’umiliazione, pur di essere lì dove contava stare, accanto al potere. Cortigiani senza cervello, che hanno ammorbato Roma nel suo secondo Medioevo. Questi qua si spacciavano per “classe dirigente”, ma tutt’al più potevano ambire a “classe deficiente”. Una volta ho letto di un festino trash voluto da alcuni politici di allora, mi pare fosse il 2010, con protagonista la cacca, tanto da prevedere all’ingresso del ricevimento alcuni water così che gli ospiti ci potessero lasciare i propri “bisogni”. Un tale decadimento, a detta del mio genitore, non s’era mai visto e perciò doveva essere aggredito con ogni mezzo dagli uomini che custodivano ancora una dirittura morale, gli uomini di legge e di giustizia. E credo che “con ogni mezzo” intendesse qualsiasi stratagemma lecito o illecito capace di arginare quel ciarpame coprofilo.
In guerra, così si sentiva lui. E in guerra qualche vittima innocente ci può scappare.
Amici veri ne ha avuto pochi, mio padre. E quei pochi sono rimasti a distanza, dopo l’ascesa. Più addolorati che contrariati. Quelli che per noi sono stati gli anni dell’infanzia, a lui hanno riservato l’approdo ai vertici di un potere tanto poco appariscente quanto solido, pervasivo, dai quali ha potuto manovrare secondo il proprio gusto le figure di spicco della nostra repubblica, così come si manovrano i burattini di un piccolo teatro dei dolori.
Mi sono fatta questa idea, nel corso degli anni, e ho seri dubbi che il mio giudizio su mio padre possa cambiare.
Le mie amiche, ventenni, le ho viste spesso arrossire nell’incontrarlo, sensibili al fascino dell’autorità più che a quello della maturità. Non di rado ho colto il tono della seduzione nelle parole formali che lui rivolgeva al proprio uditorio in gonnella. Una nota appena percettibile, capace di ridurre la distanza e insieme però di riconfermarla.
A poco mi sono valsi i tentativi di rompere l’incanto, dicendo delle sue manie, della meschinità che gli attribuivo: ciò che per me era motivo di biasimo, per loro era vezzo d’artista, che aumentava la malia.
Una volta, a Parigi, in un piccolo negozio di occhiali artigianali in rue du Marché Saint-Honoré, vicino a Place Vendôme, mi è capitato di assisterlo per ben quattro ore – performance personale ancora ineguagliata – prima che scegliesse la montatura giusta per il suo viso. Me lo ricordo impegnato per i primi sessanta minuti a valutare le possibili forme, saggiando al contempo il peso di ogni esemplare, la sua vestibilità.
«Meglio tondeggianti o rettangolari?», mi chiedeva, senza ovviamente ascoltare le mie eventuali risposte.
«Niente da fare, non vanno», spiegava alla commessa. «Né le une né le altre.» E va da sé, che non vanno: le prime ti fanno sembrare troppo artista, mentre gli spigoli delle seconde banalizzano il volto fino a farlo sembrare quello di un impiegato grigio che insegue la moda senza alcuna possibilità di successo.
E la sua loquela incantava, com’è ovvio, la donna dall’altra parte del banco.
La seconda ora la ricordo spesa a considerare i diversi materiali possibili: esclusi a priori gli “ultraleggeri”, dalle lenti sorrette da staNghette impercettibili, rimaneva da considerare la vasta scelta degli occhiali in corno, in metallo e in acetato. E poi colori e sfumature innumerevoli, piccole varianti del melange. Per essere chic il nero è chic, ma è pur sempre nero, funereo. I colori accesi, invece, mal si addicono a un uomo delle istituzioni. I tartarugati biondi, i tartarugati nocciola o i tartarugati marron e bordeaux sono un bel dilemma per una carnagione pallida e una testa parsimoniosa di capelli.
Infine, scelta non banale: la marca. Artigianato francese, statunitense o inglese? Lo rivedo con il risultato finale dell’infinito lavoro di cernita posato sul naso: un occhiale francese realizzato a mano, un tondo schiacciato sino a diventare un rettangolo imperfetto, color tabacco/bordeaux, col ponte tra le lenti slanciato come l’arco di trionfo.
Tutto questo, e molto altro, era mio padre, Ernesto Luigi Saccherio, non più di qualche anno fa.
Dovendo ritrarne le fattezze, e attraverso le fattezze dovendone raccontare lo spirito, comincerei da qui, dagli occhiali scelti quel pomeriggio. Comincerei dalla loro forma, vicina alla regolarità di una figura geometrica, però irregolare, appena diversa. Come fosse questa in fondo anche la sua cifra più vera: la piccola devianza, la deformazione appena percettibile.
Di fatto, poi, tanto io quanto Giulio abbiamo seguito la sua strada. Abbiamo scelto di studiare legge e, sia pure in modo diverso, abbiamo imparato ad amare la sua materia.
Segno che dietro l’insofferenza nutrita sin dall’infanzia nei confronti della sua autorità, in qualche misura dobbiamo averne sentito noi stessi il fascino. Il fascino o la paura.
Giulio parlerebbe di autorevolezza, più che di autorità. Si direbbe insofferente alla sua autorità, pur riconoscendogli una certa autorevolezza.
Di una – l’autorità – come dell’altra – l’autorevolezza –, io ho solo sentito il peso.
Per il resto, lo riconosco senza difficoltà: non posso dire di possedere il talento di mio fratello, e non ho certo la sua visione mistica del diritto. Ma padroneggio la materia, non meno di lui; mi ci muovo con facilità. Ed è vero, posso dire, che nel corso degli anni il diritto è diventato il centro attorno a cui gravitano le nostre esistenze.
L’autunno scorso, quando il professor Bozzolo – uno dei luminari più illustri della facoltà, del quale seguivo i corsi da tempo – mi ha ricevuto nel suo studio, tenendomi in piedi per qualche lungo minuto prima di indicarmi la sedia pesante che gli stava di fronte, per un attimo ho pensato di dirgli apertamente della mia passione per il diritto. Non avevo altri argomenti per convincerlo. Non certo quello d’esser figlia di mio padre – non è tipo da farsi intimidire, il vecchio – né quello d’esser bella, che con altri avrebbe qualche presa .
Avevo da mostrare nello spazio di un breve colloquio qualcosa che lo incuriosisse e lo inducesse a darmi fiducia.
Volevo che fosse difficile, il mio lavoro. Lo volevo per me. E siccome l’esame con lui l’avevo passato a pieni voti con lode, ho pensato di poter chiedere.
Pensavo che un’idea mi sarebbe venuta, una volta lì, che avrei trovato le parole per convincerlo, e poi invece non ho saputo far altro che propormi: un’altra laureanda che vorrebbe il prestigio di una tesi assegnata da lui. Ma, come spesso accade, ha detto di no.
«Lei mi vede, come sono», ha cominciato sornione, «vecchio e stanco. La salute malferma non mi consente oramai di seguire con l’attenzione dovuta più di qualche studente.» Mi ha guardato da sopra le lenti, subito riprendendo a scorrere le poche scartoffie che gli avevo posato sulla scrivania. «Quei pochi, poi, procedono per proprio conto, perlopiù, senza avere da me l’aiuto che meriterebbero. E a volte non è facile.»
Siamo rimasti in silenzio, per un po’.
«Vedo che ha finito con gli esami, e ha superato in modo brillante quelli più impegnativi.» Di nuovo mi guardava, senza dir nulla, rigirandosi la penna tra le mani. «I miei colleghi saranno felicissimi di accompagnare una studentessa così seria alla laurea.» Ha letto poi il mio nome, e ci si è soffermato. «Vedo che viene da una famiglia importante. È suo padre che le consiglia la magistratura?»
Ho detto secca: «No, non è lui. Lui non avrebbe voluto. È una passione tutta mia.»
«Sono pericolose le passioni», ha scherzato lui, appoggiandosi lento allo schienale della poltrona.
«Sono pericolose, è vero. Pericolose ma inevitabili.» Ho azzardato un tono appena informale, e lui ha sorriso.
«Oh, no: questo no. Si possono evitare facilmente. Ma è vero che la vita senza la passione diventa insipida e noiosa. Alla mia età ci si accontenta di poco. Non può immaginare quanto poco.» È tornato a poggiare i gomiti sulla scrivania, si è accarezzato il mento ben rasato e poi mi ha rivolto uno sguardo complice: «Lei ha un fratello che si laurea con me. È vero?»
Sono rimasta di stucco.
«Non lo sapeva?», ha chiesto gentile.
«No, a dire il vero no. Non ci vediamo molto, io e mio fratello.»
«Be’, dovrebbe forse parlare con lui. Lo studio che abbiamo concordato è complesso: potrebbe occuparsi lei di una parte del lavoro che pensavamo di sfiorare appena, e che invece meriterebbe un approfondimento. Ma dovreste eventualmente lavorare insieme, e non so se la cosa vi faccia piacere. Non so cosa pensi suo fratello, soprattutto. Non vorrei crearle degli imbarazzi.» Mi guardava ancora, in attesa di un segno, cosciente di aver mosso un passo irrituale e maldestro.
«Nessun imbarazzo, le assicuro. Parlerò con mio fratello, senz’altro.»
«Ecco, brava. Vedete un po’ se vi pare possibile. Si tratterebbe di lavorare a lungo negli archivi di alcune procure.»