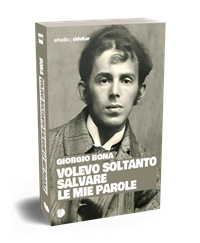Espiazioni collettive
PROLOGO
Nella stanza rischiarata dal lucore, irrompe una bambina. Sbatte contro lo stipite della porta e rovescia una sedia. La sua è una fuga disperata. Nella corsa insensata inciampa e cade su un corpo abbandonato, nel pavimento. Sul volto l’espressione di terrore di chi è senza scampo.
Più indietro la braccano degli uomini incappucciati.
La bambina con uno slancio si rialza. Tenta di scappare, ma è immobilizzata da braccia muscolose. Come un giunco sferzato dal vento ripiega nella parte buia della stanza. La scena è confusa. Sembra che tre persone la stiano trattenendo, anzi no, forse sono di più…
Dall’armadio non si vede bene.
Improvvisamente la ragazzina riappare nella luce della stanza tra due ombre che la avvinghiano, come un agnello da macellare. Si agita, i capelli spettinati le coprono il viso. Ma è tutto inutile. Una mano bestiale solleva un bastone fin quasi al soffitto e affonda un colpo, come un tuono, tra il collo e la spalla. La bambina rovina a terra quasi senza fare rumore.
Un attimo dopo un braccio di velluto infilza una lama nel petto della piccola, due, tre, quattro volte, e la sua vestaglia si impregna di una fioritura di punti scuri che si condensano in un attimo in una macchia che somiglia a un grande papavero. La vita le scivola via, solo un braccio si muove lentamente rattrappendosi sul collo squarciato. Sul pavimento scorre, verso l’angolo in fondo alla stanza, una scia scura.
Poi è il nulla. Tutto è silenzio, terrore.
Da dentro l’armadio, gli uomini in velluto scuro adesso si intravedono appena. Parlottano in gruppo, vicino alla finestra, come la domenica sera nella bettola.
Fuori la luna continua a scrutare la terra specchiandosi nella sua bellezza. Sicuramente non sa, o forse si è solo distratta e le sta sfuggendo quello che succede nella casa di Televras, a Saspendula. Certo, se solo immaginasse smetterebbe di mostrarsi così indifferente a quell’oltraggio, curandosi unicamente del suo splendore argentato.
Ora nella casa isolata regna una quiete da notte fonda. La macchia scura intorno alla bambina si è allargata, fino a confondersi con il grumo scarlatto che cinge la donna riversa poco lontano.
Dentro l’armadio comincia a mancare l’aria.
Più in là, nel corridoio buio, un puntino di fuoco si espande in un cerchio luminoso. Una candela viene accesa, dilatando le ombre. Dal suo nascondiglio l’occhio vede, per un attimo, altri tre corpi circondati da pozzanghere rosse.
La fiammella giallognola si spegne, di nuovo solo il riverbero bruno di luna piena. Altre ombre al centro della stanza nel cono di luce della luna. Sui loro volti, a nasconderli, dei fazzoletti. Discorrono fitto tra loro, calmi, sottovoce.
Due ombre si staccano dagli altri e si immergono nell’oscurità dell’andito, infestato di corpi privi di vita. Riemergono con due fagotti inanimati, persi nel sonno pesante dei bambini. Uno dei piccoli è avvinghiato al collo dell’ombra mascherata, in un gesto blasfemo di fiducia tradita.
Le due ombre, con goffa delicatezza, li adagiano a terra, per poi allontanarsi senza fretta. Nella stanza adesso è rimasta solo un’ombra. Sposta piano i due piccoli corpi. Dentro l’armadio è sempre più difficile ingoiare l’aria, i muscoli sono rigidi.
L’ombra sembra indecisa, fissa i due corpi a lungo, poi solleva il viso mascherato e scruta lo spiraglio tra le ante dell’armadio.
È un attimo interminabile, agghiacciante. Le pupille indagano. Poi lo sguardo si abbassa e l’ombra torna indietro di pochi passi, si fruga in una tasca, prende una sigaretta e la accende. Fa una sola tirata, spegne il mozzicone sulla calcina del muro e lo ripone nella tasca della giacca di campagna. Si rifà avanti e guarda ancora in direzione dell’armadio come se sospettasse qualcosa. Dietro le ante il respiro si ferma, tutto è sul punto di esplodere.
L’ombra di velluto si avvicina al tavolo poco più in là. Prende la leppa con la quale ha ucciso la bambina, la solleva e la scruta. Alla luce fioca della luna la guardia di ottone che separa la lama dal manico sembra un grande anello d’oro. Il filo d’acciaio è ricoperto da una densa patina rossastra.
All’improvviso l’ombra, con un movimento fulmineo, si inginocchia di fronte al primo dei piccoli corpi e affonda il coltello nelle carni del bambino. Il passaggio dal sonno alla morte è quasi istantaneo.
Da dentro l’armadio, chi scruta con orrore quella scena, vorrebbe gridare, ma dalla bocca non esce niente, neanche il fiato.
L’ombra si gira e affonda il coltello sull’altro fagotto. Passano pochi istanti e la morte giunge anche per il secondo fanciullo.
Dentro l’armadio i timpani scoppiano, la gola è una brace, il cuore un tamburo impazzito. Un tappo ostruisce l’aria nei polmoni, gli occhi sembrano schizzare via. I muscoli sono come ferro, la mascella è serrata.
L’ombra guarda di nuovo verso l’armadio. Afferra la maniglia, la tira a sé senza fretta. Lo spiraglio tra le ante si allarga, dilatandosi sempre più. Poi, il tappo schizza e l’aria esce tumultuosa dalla bocca aperta, il sangue pulsa furiosamente nelle tempie. Dal sonno alla vita, la differenza è una pressa acuminata che grava sulla testa, come una tenaglia.
L’uomo si sveglia, il respiro meno impetuoso. L’incubo da cui si è appena ridestato lo insegue da troppo tempo. Quindi, rendendosi conto di essere in un luogo sicuro, piano piano si rilassa. Quando richiuderà gli occhi si chiederà per l’ennesima volta quando terminerà il suo viaggio onirico. Ma non riuscirà a darsi una risposta.
I
Saspendula, 1990
L’infermiera, la signorina Viola, mentre attraversava la corsia del reparto di geriatria con il carrello della colazione, sentì addosso gli sguardi bramosi degli ospiti maschi, ma non se ne curò, era abituata.
L’odore del surrogato di caffè annunciava la solita giornata sciapa, perfettamente uguale a quelle che l’avevano preceduta.
«Stanotte, purtroppo mare agitato», le disse il signor Mulliri della stanza numero 5. «Migali si è lamentato tutta la notte. E questo qui», fece indicando il compagno di stanza, un certo Frongia, «non ha sentito niente. Ma le pare possibile?»
«Ma lei Mulliri non dorme mai?», lo rimbrottò l’infermiera versandogli il latte nella scodella.
Lavorava da anni alla Clinica San Damiano di Saspendula, oramai credeva di aver fatto il callo a tutto. Per questo rispondeva a tono ai pazienti che si prendevano, o pensava si prendessero, troppe libertà nei suoi confronti.
«Cosa gradisce oggi, marmellata o formaggino?», domandò Viola rivolgendosi al signor Frongia, sdraiato sul letto di fronte a Mulliri. Il vecchio era imbacuccato nel suo pigiama di due taglie più grandi. Ogni tanto lanciava un’occhiata al vicino che detestava. Se avesse potuto avrebbe cambiato immediatamente stanza. Ma i letti li assegnava la direzione e purtroppo gli era toccato come compagno quel sapientone di Mulliri che aveva da ridire su tutto: sul cibo, sulle pulizie dei bagni, sulle notizie del telegiornale. E, come se non bastasse, si atteggiava pure da capo. “Ma capo di che cosa? Capo di stugazz…”, ripeteva spesso tra sé Frongia. Cosa gli aveva chiesto quella mattina? Ah, ecco, come mai non aveva sentito i lamenti notturni di Migali.
«Allora, signor Frongia, formaggino o marmellata?», gli domandò nuovamente l’infermiera.
Frongia rispose brusco: andava bene il formaggino, anche se si pentì quasi subito. Forse era meglio la marmellata, ma non ebbe il tempo di riformulare la sua richiesta perché Mulliri aveva ripreso a cianciare sul povero Migali.
«L’ho sempre trovato strano questo qui, un po’ misterioso, eh? Sempre per conto suo, ma stanotte, chissà cosa gli è preso! Deve aver avuto un incubo.»
Frongia prese il formaggino e cominciò a tagliuzzarlo con il coltellino di plastica, augurandosi che il compagno di stanza la facesse finita con le sue elucubrazioni. Viola ascoltava, mentre finiva di sistemare per le colazioni.
«Mi sono anche alzato per vedere se stesse male. Stava mugolando. Ma possibile Frongia che tu non abbia sentito niente?», gli chiese. Ingoiò un sorso di latte bollente e, subito dopo, si lamentò che era troppo caldo.
«E lei lo faccia raffreddare», si difese la donna. Non era mica colpa sua se aveva a che fare con un paziente ingordo.
«Poi si forma la panna… non mi piace», spiegò l’altro.
“Puoi sempre foderarti la bocca con la cera”, gli avrebbe voluto rispondere Frongia, ma finì il formaggino alzando gli occhi al soffitto.
Mulliri riprese la litania: «Allora, hai sentito qualcosa?»
«Io di notte dormo, non controllo i compagni e non mi faccio i fatti loro», fece secco.
«Ehi, ehi… calma, non incominciate dalla mattina presto», li rimbrottò Viola. «Ricordatevi che dovete stare tranquilli, altrimenti chi lo sente il dottore?»
I raggi del sole trapassavano i vetri della finestra diffondendo nella stanza una luce viva e primaverile. Dal bosco circostante, attraverso i vasistas aperti, si spargeva il profumo della resina dei pini che attenuava l’inconfondibile odore che si respirava in qualsiasi struttura ospedaliera. Un aroma certo non inebriante come quello della natura.
La discussione era interrotta, almeno per il momento. I due degen ti consumarono la colazione e osservarono Viola che si accingeva a preparare la terza, quella per Migali.
«Adesso lo svegliamo», disse l’infermiera.
«E magari gli chiediamo… cosa è successo…», rintuzzò tra un boccone e l’altro Mulliri.
Il letto di Migali si trovava in una sorta di stanzetta interna alla camera numero 5. Vi si accedeva tramite una porta dall’aspetto poco solido. Un tempo lì si trovava un locale per le caldaie, ma considerato l’alto numero di pazienti la direzione aveva deciso di dismetterlo e renderlo disponibile per altri “clienti”.
Francesco Migali si trovava a Saspendula da una settimana. Doveva sottoporsi a una serie di controlli, roba di poco conto, aveva spiegato agli altri due Viola. Da qualche giorno, però, non stava bene. Il medico gli aveva prescritto dei sedativi che lo aiutavano a dormire. Per questo, a quell’ora, erano convinti che dormisse ancora.
Una volta entrata, l’infermiera spalancò la finestra: «Signor Francesco, su, sveglia!»
Migali non si mosse. Il corpo era fasciato dalla coperta e, a parte la testa, spuntava fuori solo un braccio.
Viola si volse verso l’anziano, lo soppesò con lo sguardo e si allarmò. Velocemente gli si avvicinò e gli tastò il polso. Sull’uscio fecero capolino Mulliri e Frongia.
«Se n’è andato?», domandò il primo con un tono che non denotava alcuna costernazione, come se stesse chiedendo se c’era acqua nelle tubature.
«Non si impicci, Mulliri», rispose Viola, sentendo la collera salirle dal ventre. Doveva subito chiamare i medici di turno. «No, non se n’è andato», fece poi, «ma sicuramene non sta bene. Forse un ictus. Ha tutta la parte destra del corpo rigida.»
La donna guardò ancora per qualche istante Migali, poi si avviò con passo veloce verso l’uscita della camera.
«Voi state nei vostri letti e non toccate nulla», li avvisò perentoria. «Così se n’è andato anche Migali!», fece Frongia.
«Non dire scemenze, non è morto», lo corresse Mulliri.
Pochi minuti e l’infermiera era tornata indietro, scortata questa volta da un medico e un assistente. Entrarono nella stanza di Migali, chiusero la porta alle loro spalle e lasciarono che Frongia e Mulliri si interrogassero sullo stato di salute del “compagno” di sventura.