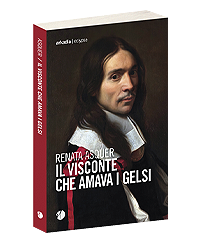Fratello minore. Sorte, amori e pagine di Peter B.
C’è un tempo interiore del viaggio che di solito non corrisponde al tempo reale degli spostamenti e delle permanenze. Non è difficile accorgersene: se al ritorno da un viaggio – da un viaggio vero: un’esperienza di vita altrove – ci sentiamo rinati ma irrisolti, se proviamo un senso di scomoda incompiutezza, se ci coglie il desiderio pungente di ritornare nel luogo che abbiamo appena lasciato, significa che il viaggio non è finito e che, nel migliore dei casi, dovrebbe poter proseguire con altri viaggi, successivi, nello stesso luogo, affinché il processo avviato in noi dal primo viaggio possa proseguire e infine compiersi, ultimando la nostra trasformazione in persone nuove. Allora, e solo allora, quel viaggio può dirsi finito.
Il mio primo viaggio a Berlino durò circa tre anni e comprese diversi soggiorni, alcuni lunghi, altri anche molto brevi, ma non meno assetati. Del primo di quei soggiorni, del suo mistero che mi trasformò, cercai di rendere conto in un libro, un romanzo i cui tratti di fantasia hanno finito per forgiare, falsandola, persino la memoria di quell’esperienza. Ma di autentico è rimasto il tratto esistenziale che avrebbe contraddistinto il viaggio per tutti e tre gli anni: la ricerca viscerale di una vita vera, in cui coincidere in ogni momento con se stessi, una vita che nei miei luoghi natii non reputavo possibile. La stessa vita che, nel decennio che seguì, continuai a cercare, sempre a Berlino, sempre a singhiozzo, ma in modo meno viscerale, con più misura.
Questo secondo viaggio ha coinciso all’incirca con il mio quarto decennio di vita. Il suo tratto più costante, mentre io mi accomodavo come potevo nell’età adulta, fu la casa di Rosemarie: è soprattutto qui, in questo grande appartamento nella Mauerstraße, rimasto in gran parte come ai tempi della DDR, che ho dormito i miei sonni berlinesi più sobri, o quasi. E oggi Rosemarie non mi ospita più nella camera accanto all’ingresso riservata agli studenti, ma in un’altra, più piccola, dove fino a qualche tempo fa aveva il suo pied-à-terre un consulente drammaturgico del Deutsches Theater, Alexander Weigel. Del suo passaggio sono rimasti due scaffali colmi di libri e, affisso alla parete, un manifesto di uno spettacolo di Heiner Müller, il maggior drammaturgo tedesco della seconda metà del ventesimo secolo.
L’immagine, incorniciata in rosso, è il Duello rusticano o “a randellate” di Goya: due uomini del popolo che cercano di colpirsi a vicenda con dei bastoni, mossi da una furia primordiale e dalla consapevolezza che uno di loro cadrà morto, su uno sfondo naturale, montuoso, che ha qualcosa di sovratemporale. Il titolo del dramma, Der Lohndrücker, è traducibile come “Lo stakanovista”, ma alla lettera significa “colui che abbassa i salari”. Il manifesto è quello di una storica messa in scena del 1988. La frase sulla sinistra del manifesto dice: «Quello che è stato, puoi seppellirlo?» E a destra: «No.»
Molto prima che Weigel occupasse la camera dove adesso alloggio io e che studenti e studentesse da tutto il mondo si avvicendassero in quella accanto all’ingresso, Rosemarie affittava queste stesse stanze agli operai forestieri che lavoravano nei dintorni, ben pochi dei quali ormai dovevano ricordare l’ambiguo super-lavoratore malvisto dai colleghi nel dramma didattico di Heiner Müller. Erano gli anni centrali della Repubblica Democratica Tedesca, anni di una maturità abbastanza fiorente e compiaciuta, più orientata alla distribuzione sociale dei frutti della produzione che al loro incremento agonistico. Ma furono anche anni di rigida censura culturale, che culminarono nella sottrazione della cittadinanza al poeta e cantautore Wolf Biermann, già inviso da tempo al partito per le sue posizioni critiche. Era il 1976, e tra coloro che si espressero contro quel provvedimento c’era anche un giovane aspirante scrittore che pagò caro il proprio gesto: fu espulso dall’università di Lipsia, dove studiava germanistica. Si chiamava Peter B.
Non so più dire come sia nato il mio interesse per lui. Fu poco prima del mio primo soggiorno a Berlino da quarantenne. Il suo nome mi era noto da vari racconti di Rosemarie. Sapevo che era stato più volte a casa sua, che era una specie di amico di famiglia, che beveva molto, tanto che ne morì. E sapevo che era il fratello minore di Thomas B., uno degli scrittori più celebri della Germania realsocialista. Ma non so cosa mi spinse, un paio di giorni prima di partire, a usare internet con meno distrazione del solito e cercare sue notizie, possibilmente tracce. Trovai un video, aveva un titolo generico: “Peter B. sulla cultura”. Era un estratto di pochi minuti da una trasmissione televisiva della rete tedesco-orientale del Brandeburgo, la puntata di un talk-show chiamato Wie weiter?, “Come andare avanti?”, andata in onda l’8 giugno 1991.
Il giovane uomo seduto in poltrona accanto ad altri due tizi e chiamato a intervenire in qualità di autore e regista, inquadrato dapprima di profilo, ha i capelli castani, indossa una giacca nera, jeans schiariti e scarpe scure. Tiene una sigaretta fra le dita. Si piega in avanti e allunga il braccio, oltre le gambe accavallate, verso il posacenere sul tavolino che ha di fronte. Tossicchia. Il primo piano a tre quarti ne restituisce adesso l’espressione non serena, un solco netto fra le sopracciglia, il volto lucido, gli occhi chiari e vitrei, il naso importante e le due rughe simmetriche che scendono fino ai lati della bocca socchiusa, sopra il mento arroton- dato da una pappagorgia appena gonfia. Sembra respirare con lieve affanno.
Il moderatore lo interpella sulla funzione del teatro nell’est e nell’ovest. Lui dice che non c’è differenza, che il teatro in primo luogo deve divertire. Si oppone poi all’espressione DDR-Identität perché, sostiene, «nessun uomo è identico a uno Stato». Dice che c’è semmai un DDR-Gefühl, un senso di provenienza e appartenenza, e che nella Germania orientale le aspettative nei confronti del teatro prima dell’89 erano diverse da oggi. Allora, dice, il teatro sostituiva i quotidiani – un’affermazione che stento a comprendere. Poi sostiene che il calo di spettatori accusato dai teatri dell’est è dovuto semplicemente al maggior costo del biglietto, ossia all’introduzione dell’economia di mercato. Passa allora a parlare di denaro, della cattiva distribuzione dei fondi ai diversi teatri tedeschi. Cita ad esempio la ben foraggiata Volksbühne, il maggior teatro sperimentale berlinese e tedesco, e il Grips Theater, un piccolo teatro progressista di Berlino ovest dove attualmente lavora. Agita una mano quando dichiara: «Il denaro in effetti ha una parte rilevante, e in tal senso oggi qui sostituisce l’ideologia». In passato, dice, chi lavorava nel mondo teatrale non doveva occuparsi di soldi, preoccuparsi dei finanziamenti. Poi accusa il teatro di Karlsruhe, nel sud-ovest del paese, dov’è stato di recente, di mettere in scena «solo merda», portandolo come esempio di un teatro noioso, vecchio, di repertorio. Lì sì che è necessario tagliare, dice, così da poter sostenere una rete più ampia di teatri più vivi – possibilmente nell’ex-Germania dell’est, mi pare di capire. Fa alcuni esempi e, man mano che parla, sembra acquistare sicurezza e tranquillità. «Sfoltire», dice, richiamandosi a non so quali parole di Heiner Müller. E afferma che questo, in fin dei conti, è un problema comune a «entrambi i Paesi» (nonostante nel frattempo siano diventati uno solo).
Fu quel video a sommuovere il mio fondo. Eccolo dunque, lo scrittore maledetto del quale avevo sentito parlare varie volte nel corso degli ultimi anni, ma senza mai badarvi troppo, come se fosse soltanto un personaggio secondario delle avventure di Rosemarie nel Paese dei contadini e dei lavoratori. C’era qualcosa, in quel giovane uomo tormentato, che toccava una mia corda nascosta. Perché lo sentivo così vicino, così familiare? Era solo una suggestione dovuta ai racconti della mia pensionante? O forse somigliava a qualcuno che avevo conosciuto in passato, ma che non sapevo ricordare? O faceva semplicemente appello alla mia passione indomabile per tutto ciò che è berlinese e affine alle mie passioni? La sua parlata, il mondo teatrale…
Proseguii la ricerca in preda a una crescente eccitazione. Trovai subito un altro video, anch’esso breve, poco più di quattro minuti, mostrava un Peter B. di otto anni più tardi e nettamente invecchiato, ingrigito dal fumo ma sobriamente compiaciuto di presentare, per la stessa televisione locale, il suo primo romanzo, Schön hausen. Scritto attaccato, “Schönhausen” sarebbe il nome del castello barocco di Pankow, nella parte nord-orientale di Berlino, che funse da residenza dell’unico presidente della DDR, Wilhelm Pieck, e più tardi da sede del Consiglio dei Ministri, finché nei mesi della Wende, la “svolta” del biennio 1989-90, vi ebbe luogo una seduta governativa di preparazione alla riunificazione; la sua presenza si annuncia già nel quartiere dove vis- se Peter B., un cui viale porta appunto questo nome. Staccato, invece, Schön hausen ha un significato più semplice e quotidiano, qualcosa come “alloggiare ben bene in una misera dimora”.
Di questo secondo filmato, un servizio girato per lo più a casa dello scrittore, capii poco, forse per l’eccitazione, forse per la foga da internauta che mi aveva afferrato e che, teleguidata almeno in parte da stratagemmi fuori dal mio controllo, mi indusse a interrompere la visione dopo neanche un minuto per cercare subito quel titolo in vari siti di commercio librario on line.
Gli esemplari erano pochissimi, tutti usati o comunque fuori commercio, e avevano prezzi molto alti. C’era poi qualche altro titolo di Peter B. a prezzi per lo più ragionevoli, ma non Schön hausen, la sola opera che in quel momento mi interessava, il suo unico romanzo.
Avevo raggiunto una soglia di curiosità non appagabile, che mi rendeva irrequieto e superficiale. Perché avevo intrapreso quella ricerca? Non ne avevo idea. Ma sentivo di aver abbordato un tema, un personaggio, una questione irrisolta che in qualche modo riguardava anche me. Tuttavia non avrebbe avuto senso proseguire quella convulsa ricognizione in rete. Sarebbe stato meglio aspettare di arrivare a Berlino e chiedere a Rosemarie di parlarmi di nuovo del suo amico.
Così feci. Era un novembre mite. Come al solito Rosemarie mi accolse sulla porta della sua abitazione in un’armonia di neri che, fra indumenti, scialle e capelli a caschetto, incorniciava la sua pelle rosea di sassone, facendo risaltare gli occhi azzurri che un tempo dovettero procurarle molti ammiratori. E come al solito ci mettemmo a chiacchierare già nell’ingresso, per vari minuti, io ancora con la giacca indosso e una mano sul manico allungato del trolley.
Le chiacchiere proseguirono nel cosiddetto Berliner Zimmer, l’ampio soggiorno al centro dell’appartamento dove ancora campeggiavano una grande stufa in ceramica e diversi mobili dell’epoca socialista. Fu qui che le parlai del mio recente, improvviso interesse per Peter B. Fu sufficiente. Mentre ancora mi sistemavo nella mia camera assistito in silenzio dai libri di Weigel, Rosemarie si vestì e uscì. Rientrò meno di un’ora dopo con una borsa di stoffa contenente vari materiali: articoli di giornale, il plico rilegato di una pièce teatrale, un poster – e una copia di Schön hausen: in copertina un’illustrazione violacea, notturna. Proveniva tutto dalla casa di Margit, la migliore amica di Rosemarie, una famosa attrice.
Conoscevo Margit, l’avevo vista recitare al Deutsches Theater nei Persiani di Eschilo e in Germania di Heiner Müller sotto la direzione di Dimiter Gotscheff, un regista che ammiravo, morto proprio poche settimane prima di quel mio soggiorno autunnale. Ed era già capitato che Margit e io sedessimo allo stesso tavolo, a casa di Rosemarie o in un ristorante dei dintorni. Quello che non mi era stato chiaro fino a quel momento, anche se Rosemarie me lo aveva certo già detto, era che Margit, anni addietro, era stata sposata con Peter B.
La dedica sul risguardo della sua copia di Schön hausen era corredata da un disegno, un esile omino in riva al mare non dissimile, nel tratto bambinesco, dalle tre piccole figure che in copertina parevano stagliarsi su un’abisso, illuminate in controluce dal chiarore lunare. Le parole della dedica alludevano a un esilio esistenziale – «A casa, quando è stato?» –, e rimanevano suggestive anche a una lettura estranea come la mia, ma non seppi immaginare a cosa po- tessero riferirsi veramente.
Quella stessa sera iniziai a leggere il romanzo, che mi trascinò fin da subito in un’incredula meraviglia. Non era un capolavoro, ma l’immaginazione che vi albergava aveva qualcosa di irresistibile: era una forza innocente, libera e divertita, che mi riempiva di euforia e rafforzò la sensazione di aver trovato un consimile, un compagno di strada – un fratello? Qualcuno, comunque, che mi parlava dallo stesso mondo in cui sospiravano i miei sogni e i miei disincanti, che perciò non potevo, non volevo abbandonare all’oblio al quale sembrava essere stato condannato dalla sorte.
Capii così che, a quarant’anni compiuti, il mio terzo viaggio a Berlino era incominciato. E che sarebbe stato anche un viaggio nel tempo.
Prima parte
TU
I
Ti vedo, o almeno credo. È uno dei momenti più sfocati della tua biografia. In bianco e nero, si direbbe, o forse è solo Berlino est che a quest’altezza, sei anni dopo il cosid- detto crollo del Muro, è ancora immersa in larga parte in un grigio fatiscente, che smorza i facili entusiasmi nostalgici di chi ti vede dal futuro: dal variopinto supermarket dell’Europa d’inizio millennio. Chissà di che colore è il tuo soprabito, subito spruzzato dalla pioggerella autunnale ap- pena metti piede in strada, il portone scrostato che si chiude alle tue spalle. Sotto l’unico lampione nei tuoi pressi, in una luce tremolante, la fiamma dell’accendino che si accosta alla seconda sigaretta senza filtro del giorno – e sono solo le cinque del mattino – perde forza e poesia. Ne saresti contento, una vignetta kitsch in meno.
La Choriner Straße è un buon posto per abitare, dopo l’89. Al confine tra Mitte e Prenzlauer Berg, da qui in pochi minuti sei in Alexanderplatz – se vuoi fiutare bene i venti che spirano da ovest e che stanno spazzando via tutto, un po’ alla volta, in un paziente e implacabile lavoro di erosione; oppure in un attimo sei nella Schönhauser Allee, l’asse più in fermento di questo ex-quartiere operaio che, nel giro di un decennio o poco più, verrà colonizzato e tirato a nuovo dai figli di papà occidentali, tedeschi e non solo. Molti autoctoni, i più anziani soprattutto, se ne andranno da qui nei sobborghi, arresi ad affitti sempre più insostenibili; qualcuno della tua cerchia resisterà e lo incontrerò.
Ma non è ancora tempo, sono molti gli edifici ancora in stato di abbandono, frutto di una gestione anche urbanistica che qui, nel biotopo degli artisti alternativi, aveva ancor meno interesse a farsi bella.
Guardi la cavità che hai davanti, un buco fra due case, uno dei tanti vuoti che puntellano il tessuto cittadino, per lo più resti di guerra – le bombe alleate, mezzo secolo fa, cadevano fitte –, uno dei pochi tuttavia in questa zona, risparmiata più di altri e perciò preda a venire degli speculatori immobiliari più glamour-oriented. Qui poi, davanti al civico 36, è cresciuto un tiglio, grande e bello, la cui chioma, dimora di uccelli e scoiattoli, gareggia in rigoglio con quella del castagno che, nel cortile interno, ti fa compagnia quando volgi lo sguardo alla finestra, seduto alla scrivania, dalla tua abitazione al quarto piano. Oggi quello non l’hai guardato, è vero, è ancora buio, settembre è ormai alla fine. Ma converrai che neppure una partita a campo minato su uno schermo a tubo catodico è la vista migliore per entrare nel giorno.
Certo, continuare a non bere è una sfida più dura del previsto. Non fosse per Petra, che ha stretto la mano al bimbo puro e rabbioso che è in te e che, nella veste di un controllo amorevole, ti sprona a trovarti fuori dai tuoi vecchi schemi, saresti scivolato ancora più giù, la tua vita era un greppo franoso – da quanto? Quand’è che il tuo istinto ribelle ha iniziato a procurarti più sfiducia che gloria? Hai compiuto da poco quarant’anni e, benché da venti porti gli stessi occhiali, o almeno la stessa montatura, non puoi dire di aver costruito granché. Non dovrebbe essere, questa, l’età dei primi bilanci? Sciocchezze, diresti, anzi: troiate. Neanche Petra, a dire il vero, ti travolge fino in fondo: l’idea che Margit, tua moglie, l’attrice perfetta, il grande amore, voglia ormai il divorzio ti distrugge, sarebbe da sola una buona ragione per riprendere il bicchiere, subito. E pensare che hai smesso anche, forse soprattutto per lei. Ma Petra non lo sa – o magari sì; comunque la tua mano non la molla.
Ti incammini verso nord, non so perché, oggi è così. Non puoi nasconderti, come al solito, un certo senso di lutto per i luoghi già estinti. Non che prima, nella DDR, qui ci fosse chissà cosa. Ma anche solo il Rechenberg, bettolaccia senza neppure un nome, chiamata con quello del suo gestore, dove qualche sabato mattina ti ubriacasti assieme a uomini già sfatti dalla sera precedente, era un modo, che allora non pareva neanche tanto degradato, per sospingere la vita, la sua pena disuguale. L’Oderkahn era un po’ meglio, più decente, a parte quel gradino all’ingresso che pareva lì apposta per far inciampare e schernire gli imbra- nati; bruta uguale era invece la Trümmerkutte, all’angolo fra l’Odeberger e la Kastanienallee, dove portacarbone e portarottami crollavano sui tavoli già alle sei del mattino; ma apriva appunto alle cinque, avresti potuto andarci anche oggi. E forse ci andresti, se ci fosse ancora.
Invece non vai in nessun posto, cammini soltanto, una via dopo l’altra, alcune già ribattezzate dal nuovo corso della Germania riunificata, te ne freghi della pioggerella – ti protegge una vecchia coppola – e resisti ai cattivi pensieri, residui tenaci e antichi dell’ennesima notte seminsonne. Osservi, convinto che l’esplorazione ravvicinata di un microcosmo, anche quando deve ancora ridestarsi e sono poche le finestre già illuminate, sia la strada da percorrere, adesso. Al diavolo il vasto mondo, non è di quello che oggi si può scrivere, pensi. Presto sarà tutto uguale e ugualmente asfissiante, in questa fregatura chiamata capitalismo. Se la Germania dell’est era una dittatria, dirai fra un paio d’anni in un’intervista, quella di oggi è una democratura – tu e i tuoi giochi di parole, non puoi proprio farne a meno.
Non lo sai, ma ti aspetta una fase feconda. Il successo è un’altra cosa, sia pure. Ma quello ti manca da sempre, quasi quasi ci hai fatto l’abitudine. Del resto la sorte ci ha messo del suo: la volta, la prima, in cui unisti i tuoi testi in volume, ti venne a mancare il contesto. Era stato Gerhard Wolf, marito della più famosa Christa, autore ed editore, a invitarti a prender parte al banchetto. La collana si chiamava ausser der reihe, “fuori programma”, in minuscolo, senza gerarchie. L’editore era il prestigioso Aufbau, pilastro portante della produzione libraria tedesco-orientale. L’idea era di dare finalmente riflettori a quelle voci non conformi che ormai, verso la fine degli Ottanta, non c’era più ragione di occultare o sorvegliare, tale era ormai la loro innocuità rispetto ai disastri della perestrojka.
Della cosiddetta scena del Prenzlauer Berg, Wolf aveva già accolto certe pallide teste di serie, metti Bert Papenfuß, l’eterno punk-rocker, o Stefan Döring, il poeta lirico che traduceva dall’inglese e dal russo, o quello sperimentatore impenitente di Jan Faktor. Gli serviva un autore teatrale, gli mandasti il Santerre e lo Juan ricalcato su Da Ponte, ma era poco, ti chiese allora testi in prosa e in poesia, e quando finalmente il conglomerato informe fu stampato con il titolo rückblenden an morgen – flashback su domani? – con molti, troppi refusi ma una sovraccoperta fra le più belle della mia libreria, era ormai il ’91: il Paese evaporato, il marco unificato, l’underground si dissolveva, il pubblico si andava disperdendo, il libro lo comprarono in pochissimi e la collana morì.
Non sono io a infierire, sei tu che ci ripensi, anche in quest’alba di primo autunno. Ti ci vorrebbe una sosta in una Kneipe, se solo ogni volta che ti ritrovi davanti a un oste non si ripresentasse la tremenda tentazione. Ascolteresti l’ennesima storia di violenza domestica, osserveresti l’incrocio fra i residui festaioli della notte e chi si è alzato per iniziare il turno, parleresti con lo spazzacamino di qualcosa che non sia una qualche arte verbale. Ti distrarresti. Ma non è questo che vuoi, adesso, o così ti racconti. L’osservazione è una disciplina, proprio come l’astinenza. Il tuo diario in grande formato, chiuso in casa, aspetta storie o disegni che non siano le solite tirate contro la cultura dominante e i suoi ballerini, tanto più aspre se a farti rabbia sono tuoi ex-connazionali, un tempo eslegi fino al vittimismo e oggi compiaciuti sotto i riflettori, a spartirsi bocconcini insapori in un sistema che sì, si sarà pure rimesso in movimento rispetto all’immobilità del socialismo reale, ma ha tutta l’aria di correre verso il conformismo universale.
Ma stiamo sulle cose, alla tua buona intenzione. Sei già quasi in cima alla Schönhauser Allee, non lontano dalla stazione della S-Bahn, come qui chiamate la sopraelevata, anche se in questo punto, come in altri della rete berlinese, passa sotto il livello stradale. E visto che ormai – sarà anche una sottile pioggerella, ma acqua è – oltre alle spalle e alla coppola hai bagnate anche le tue vecchie scarpe fin dentro i calzini, hai una scusa per fare solo altri cinquanta metri, perché lì davanti, guarda un po’, dalla vetrina della panetteria che aveva chiuso tre mesi fa, brillano di nuovo un’insegna e una luce. Alla tua destra, in alto al centro del viale, sui binari sopraelevati della metropolitana che qui chiamate U-Bahn e che in punti come questo confonde il forestiero incapace di comprendere la differenza fra una sopraelevata a tratti sotterranea e una metro a tratti di superficie, sferraglia verso Pankow uno dei primi treni gialli del giorno.
È la ex-linea A, da cinque anni ribattezzata U2 e una delle più affollate. Oggi attraversa di nuovo la città da est a ovest e viceversa, scarrozzando per lo più frotte crescenti di turi- sti fra Zoologischer Garten e Alexanderplatz, di rado più oltre, o portando a sabati alterni tifosi di calcio ex-occidentali allo stadio voluto da Hitler per le olimpiadi del 1936; ma nei decenni del Muro si fermava poco prima della terra di nessuno, alla fermata Thälmannplatz, oggi Mohrenstrasse, vicino all’ambasciata nord-coreana, non lontano da casa di Margit, la tua ex-moglie, l’attrice perfetta, il grande amore. La stessa zona dove ho avuto una camera per oltre dieci anni, quando eri già morto, nella casa in cui per la prima volta ho sentito parlare di te. Del resto, se adesso sei qui tra le mie grinfie, redivivo, è perché conoscevi anche la mia pensionante, che di Margit è ancora oggi la più cara amica.
A te, tuttavia, di una simile connection frega poco. Potrebbe persino irritarti. È la luce dell’insegna ad attirarti, invece: non è più quella di prima, è un’altra catena. Così vanno le cose nella nuova Berlino, in un continuo avvicendarsi di esercizi e attività periture, una sottomissione alla metamorfosi dettata dalla frenesia di una concorrenza cieca. Anche l’arredo all’interno è cambiato, eppure chi ci trovi? La stessa commessa di prima, quella che si era licenziata perché l’azienda precedente non la pagava da due mesi. Entri, la saluti, ti riconosce, ti saluta, tu ordini qualcosa per la colazione, lei ti racconta come sia riuscita a farsi assumere dal nuovo produttore e di come lo consideri, più che un colpo di fortuna, un riconoscimento del suo lavoro, dei suoi bi- sogni anche, quasi quasi una forma di rispetto padronale. Infine, allietata dall’aver ritrovato il suo vecchio cliente, sul vassoietto di cartone ti mette due tranci di dolce invece di uno, e nel sacchetto del pane ti c’infila cinque pezzi anzi- ché tre. Ecco quello che tu, ugualmente rallegrato, consideri ben più di una mera transazione commerciale, un vero «scambio culturale», altro che i tuoi colleghi letterati.
Le eccezioni, certamente. Ma quelle hanno a che fare con l’amore. E il più recente è fresco, persino aurorale, si chiama Pessoa. Tutto nasce dal soggiorno in Portogallo con Petra dal quale sei rientrato da poco e dove hai compiuto i quaranta. Il tuo premio per i primi tre mesi lontano dal bicchiere. Lei l’hai omaggiata in uno scritto che sarà pubblicato tra due anni, con pochi altri testi lirici e in prosa, accompagnato da una sua acquaforte, per un micro-editore berlinese. Vera arte libraria, su carta autoprodotta, diciassette per ventuno, bordi grezzi, copertina blu elettrico, legatura in filo nero, sedici pagine in tutto, un’edizione limitata e numerata in venti copie fuori commercio e cento per la vendita. Fu lo stesso editore, il mite signor Ludewig, a mandarmene una copia residua, un cadeau, dopo esserci conosciuti a una lettura in tuo onore tenutasi nel giorno del tuo sessantesimo compleanno. In rete, fra gli antiquari, se ne trovava un solo esemplare, a un prezzo esagerato.
In quello scritto portoghese, dopo aver riflettuto sulla non linearità di ogni cammino esistenziale, tu sogni «di essere seduto sul bordo di una piscina in una località turistica nell’Algarve. Sogno di essere una donna bionda, mi chiamo Piccolina Basta e sono pittrice. La gente che abita nel paesino l’avrò presto dimenticata. I quattordici giorni che ci trascorro sono presto affondati nel passato, rintracciabili soltanto dalle foto. Le foto sbiadiranno e perderanno ogni significato. Le getterò nel bidone della spazzatura. I luoghi, i nomi, le denominazioni non mi diranno più nulla.» Vedi, in questo flirt con la dimenticanza ti stai già esercitando a dissolverti. «Incontro ogni giorno la mia reincarnazione. Non occorre che cerchi un animale o una pianta che sono stato in una vita precedente o che sarò dopo la mia morte biologica. Porto con me, adesso, ogni reincarnazione. Non è una religione, è un fatto. E siccome sono una pittrice, sono il sughero che disegno mentre attraverso in pullman l’Alentejo, sulla strada per Lisbona. Sono tutt’uno con la luce di questa città, poiché la luce entra in me, come l’albero, la via, la strada…»
Accidenti, però. Se c’era un modo per dare di te una prima impressione parziale, l’ho trovato riportando questa tua rêverie. L’immaginazione, certo, l’invenzione linguistica – quel nome italiano, così ingenuo e giocoso – ma non sei tutto dentro a questa prosa mentale… Meno male che durante quel soggiorno vacanziero hai scritto anche un’Elegia portoghese – nel tuo stile maturo: «Le case sono bianche / I negozi chiusi / Un motorino crepita sul viale lontano / All’angolo un cane ha versato una lacrima / A bordo piscina suda una tazza di caffè // A bordo piscina si crogiolano gli svizzeri / Il sole cerca urgente un riparo da se stesso / All’ombra sonnecchia un fuochista portoghese / La mia anima suda ferita sotto un intonaco di pietra. // La mia anima bianca barcolla / Bianca una quercia s’accorteccia / Nero un gatto ne penzola / L’Europa prima che sparisca.»
Così adesso crederanno che sei soprattutto un poeta. Un poeta che ha vissuto in due paesi senza mai cambiare città e che, a metà degli anni novanta, vedeva l’Europa morente come un languido tableau vacanziero. Non senza animali domestici, giusto l’affetto creaturale che ti anima, anche se la vita ti ha portato a dissimularlo dietro un’intransigenza sofferta e suscettibile. Cosa non si diventa per proteggersi. La lirica subito dopo l’Elegia, l’ultima della plaquette, pagina 14, ultime due quartine: «Viene nuotando un pesce / Nuota intorno ai miei ginocchi / Al cuore me lo porto / Freddo come mai cuore fu // Il giorno cade greve sulla mia camicia / Non sono qui eppure ci sono / E dove fui sarò straniero / Perché ieri non ero ove domani.» Ho detto il tuo stile maturo, perché a leggere queste liriche si sente ancor più che nelle tue prime l’influenza del secondo fra i tuoi amori, il sofferto fra i due. La tua eccezione d’eccezione, che ancora oggi ti fa ombra. Oggi che nessun sole ti fa più sudare l’anima.
È l’alba, sei rientrato, ti togli soprabito, scarpe e calzini, mangi una fetta di dolce accompagnandola con il caffè, poi accendi una sigaretta e ti metti a scrivere.