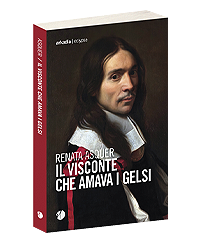La ragazza andalusa
1
Il locale si chiamava Mi madre era una Groupie e ci ero capitato per caso. Eduardo festeggiava il compleanno di una sua amica, quella notte, e mi aveva invitato in un bar messicano in calle del Olmo. Il bar messicano confinava con le cantine della Bodegas Alfaro, i cui interstizi conoscevo bene. Poco oltre, in calle del Ave Maria, c’era La Temeraria, un ristorante italiano fondato da Anna, e poi, subito prima di arrivare in calle de la Cabeza, la cui malinconia rimandava a una più possente, El dinosaurio todavía estaba allí. Era un omaggio al racconto più breve che sia mai stato scritto e ad Augusto Monterroso, ma questo è un altro discorso. Il locale al quale eravamo destinati, come dicevo, si chiamava Mi madre era una Groupie e, quando scorsi Eduardo seduto al bancone del Maria Bonita, con una Tequila tra le mani, era ancora chiuso: le sale deserte, i condotti dell’aria condizionata vuoti e il dj, probabilmente, doveva ancora finir di cenare. La festeggiata era una giornalista ecuadoriana che aveva da poco esordito nella narrativa con un libro di racconti intitolato Una bulla tra i galli. Era una di quelle donne che onorano il venerabile culto di Lilith, e ti accorgevi subito che c’erano solo due possibilità di fronte a lei: soccombere alle sue mire amazzoniche o fingere che non esistesse. Stavo scegliendo come comportarmi, quando vidi la sua mano posarsi sulle natiche di Eduardo.
«Io non mi farei toccare così allegramente», gli dissi.
Eduardo però mi aveva preceduto nella comprensione della vita e nel numero di Tequila: «Non preoccuparti, fa così con tutti.»
«Appunto», mimai, ma agli atti restai in silenzio.
Avevo già visto in azione María Fernanda de Guzmán durante i preparativi della festa di Halloween dell’anno precedente. Eravamo passati a prenderla a casa sua, e l’avevamo trovata in compagnia di due amiche completamente truccate di nero.
«Siamo la morte», esclamarono arcigne, «venite con noi.»
Insieme a me e a Eduardo, quella sera, c’era anche Agostino, un tipo che riconobbi nel Maria Bonita con il gomito poggiato sul bancone. Agostino aveva partecipato di buon grado al loro gioco ambiguo, incassando i palpeggiamenti rituali, sorridendo mansueto. Era stato educato nell’Opus Dei, e qualsiasi contatto con il mondo femminile, anche il più violento, era per lui una ragione di riscatto. A me invece non è mai piaciuto chi rivendica una posizione dominante, come se a una dittatura dovesse per forza subentrarne un’altra di segno contrario. Ho sempre parteggiato per un’amichevole parità tra i sessi, una posizione che ultimamente non riscuote molto successo, ma che almeno mi ha evitato di partecipare a quei negoziati che dimenticano la tenerezza. Chiamatemi idealista, ingenuo o babbeo, ma sono fatto così.
Il Maria Bonita era diviso in due parti: appena entrati c’era il bancone, dov’erano seduti Eduardo e Agostino, e più avanti si ballava. La pista era il regno di María Fernanda de Guzmán, che v’imperava propugnando il suo scettro notturno, attorniata da una compagnia di amici dalle tendenze sessuali interscambiabili. La regina si staccava ogni tanto dalla plebaglia che la venerava per venire a pescare un po’ di calore al bancone, dove vezzeggiava i suoi invitati più composti per tornarsene alla svelta tra le fredde comparse che la idolatravano. Io dovevo essere entrato durante una di quelle sue ricognizioni, perché si rivolse a me come se ci conoscessimo da tempo immemorabile, avvicinando i suoi capelli cortissimi, di un nero amazzonico, al mio naso da contadino.
«Ma che caruccio… Sei un amico di questa chicchina che beve la sua terza Tequila?»
Ci sono donne più chiare di un annuncio pubblicitario, quando si tratta di farti capire che il tenore della serata avrà una seducente tendenza allo strofinamento.
«Sì, sono un amico di Eduardo», dissi.
E credetti di far bene a presentarmi, visto che dopotutto stavamo festeggiando il suo compleanno, e che evidentemente non si ricordava della festa di Halloween dell’anno precedente, durante la quale, ora che ci pensavo, avevo scelto d’ignorarla. María Fernanda de Guzmán aveva però già trovato una strategia più diretta da mettere in atto, e sulla tela dei miei pantaloni avvertii una scia calda calda, come quella del getto di vapore del ferro da stiro, che se dimenticato sul tessuto per un paio di minuti avrebbe causato una chiazza di bruciato difficile da mandar via.
«Cosa prendi da bere, tesoro?»
«Prendo una birra ma, per favore, non chiamarmi “tesoro”.»
La notte era appena iniziata, non avevo alcuna fretta di accedere alle sfere di saggezza che mi avrebbero permesso d’inserirmi nell’ambiente di quella festa, e di accettare di buon grado i suoi vezzeggiativi. Ero un semplice amico di amici, in fondo, e potevo permettermi di restarmene un po’ in disparte, che poi è una delle mie specialità. Le strade di Lavapiés erano un placido saliscendi che sfiancava alla svelta, e ricordai con piacere le atmosfere distese di un bar lì vicino, l’FM, dove Paco trascinava i suoi robusti polpacci da ciclista da circa trent’anni. Serviva soltanto birra e prosciutto, sotto lo sguardo sonnacchioso del suo vecchio spinone, che occupava da solo metà della ridotta capienza del locale: speravo di convincere la strana comitiva a farci un salto, una volta finita l’ultima ronda di Tequila. Calle de Santa Isabel ci aspettava con la sinuosa proposta di squallore e non volevo deluderla, così chiesi a Eduardo quale fosse il programma.
«Ci muoveremo tra un’oretta», mi disse, «prendila pure con calma.»
Non ricordo esattamente quando cedetti alla Tequila, ma mi lasciai vincere dalla sua seducente trasparenza e ne bevvi. Eduardo e Agostino mi precedevano di varie unità e la compagnia di María Fernanda de Guzmán sembrava immersa in un baccanale senza tempo, di modo che potevo considerarmi tra i più sobri quando uscimmo dal Maria Bonita. Incedemmo con passo lento, da scalatori, verso calle de Santa Isabel, e vidi che Paco aveva già chiuso l’FM. Passammo davanti alla palazzina in Art Nouveau della filmoteca spagnola, che Curro aveva restaurato con la sua scala e il suo pennello, per immetterci in quel corridoio che costeggia il mercato di Antón Martín, in cui di giorno si vendono ortaggi e carni bianche, ma che di notte sembra Brooklyn, per arrivare alla torrentizia calle de Atocha. Traversarla non è mai un’operazione da compiere a cuor leggero, e men che meno quando devi badare a che un’intera compagnia di baccanti arrivi incolume dall’altro lato. Agostino ebbe un accesso ecumenico, e prese per mano le due adepte più fedeli alla regina, che rimase sdegnosamente priva di accompagnatore. La sua ira, una volta che si fu messa al riparo dalla corrente di automobili, si sprigionò dall’onice delle sue pupille nerissime. Dettò senza impietosirsi la rotta da seguire: «Si va al Dumbarton Club», disse, e difilato s’intendeva.
Il Dumbarton era uno di quei posti dove non c’era niente di particolarmente ben fatto, i cocktail erano scadenti, le pareti sfoggiavano i tipici lampadari anni Trenta e nell’arredamento vintage non potevano mancare le macchine da scrivere. La musica non era migliore del parquet, rigorosamente in stile alpino, e una colonna divideva in due lati il bancone. Una decina di persone ballava quando ci riversammo all’interno, e nei loro occhi s’intravidero possibilità fino a quel momento dimenticate. Passai un’ora e mezzo fumando sigarette in calle de Moratín. Lo spirito dell’irriverente poeta vi aleggiò sin dall’inizio, riversandosi nel rosso ocra de Los Chanquetes, e fino alla Taberna de las Letras mi accompagnava una tonalità di affresco pompeiano.
Esisteva ancora il Begin the Beguine, che non era un bar, non era un salotto, non era nulla; era solo il ripostiglio di un vecchio egiziano con la passione per il gin e i ventagli colorati. Era impossibile passare da calle de Moratín senza rivolgere un pensiero a Tony, perché faceva parte della strada, non aveva neanche un’insegna che lo contraddistinguesse come bar, era clandestino e infatti, dopo che questa storia si fu svolta, venne chiuso. Adesso Tony vaga per il Barrio de las Letras aggrappato al manubrio della sua vecchia bicicletta, trasportando foglie fresche di basilico e menta. Non potendo più guarnirci i Gin Tonic, le vende insieme alle cianfrusaglie che incolonnava per incoronare i suoi amati ventagli, ma chi le compra noterà la tristezza di chi gliele ha vendute. Calle de Moratín era una di quelle strade con cui parlavo volentieri, e più di una volta, quando mi ero trovato giù di morale, avevo attraversato il centro e mi ci ero ficcato, contento di farmi trasportare dalla sua inclinazione decisa, ma non violenta, e dal quel rosso sulle veneziane del Jazz Bar, in vista del Paseo del Prado.
Scrivere di calle de Moratín non è la stessa cosa che fumare una sigaretta in calle de Moratín, ma ricordo i suoi freschi sampietrini con la stessa allegria di quando ci passeggiavo, aspettando di vedere chiuso il portone del Begin the Beguine, dal momento che lo era quasi sempre, tranne che dalle tre alle sette del mattino, sul lato sinistro della strada, quasi d’angolo, accanto a una di quelle aiuole quadrate che contengono un albero e poi un altro. Tratteneva la discesa per un inciampo, poi si proseguiva spediti verso le diramazioni pianeggianti, all’altezza del rosso Ministero dell’Istruzione. Era impossibile trovare nella notte qualcosa di più bello di calle de Moratín, e ancora più impossibile sarebbe stato scovarlo nel Dumbarton Club, quindi rimasi fuori. Il tempo in fondo non è che una successione di opportunità, e le opportunità sono facilissime da sprecare, praticamente non si fa altro. Eduardo si affacciò sulla porta resistendo alla forza di un braccio che lo tratteneva dall’interno.
«“Dígote, en fin, que es admirable idea la de marcharse”», mi disse citando il drammaturgo in questione.
Una volta che ci fummo messi in marcia feci finta di niente, ma Agostino dava evidenti segnali di un’euforia che sarebbe tornata utile, perfino troppo. In quel momento scorgemmo le insegne del Mi madre era una Groupie nel punto algido di calle de Santa Polonia. La protettrice dei dentisti ignorava che il locale avesse appena aperto i battenti e che gli addetti alle relazioni pubbliche stessero distribuendo ingressi da otto euro con cocktail o due birre sotto la sua effige, nonché il fatto che la maggior parte di noi, a quell’ora, avrebbe decisamente optato per i cocktail. La santa era originaria di Alessandria d’Egitto, e noi procedemmo verso il bancone chiedendoci cos’avremmo ordinato per introdurci in quell’ambiente. Saremmo stati testimoni dell’inizio della musica, quando il dj avesse ingerito con calma il suo frangelico.