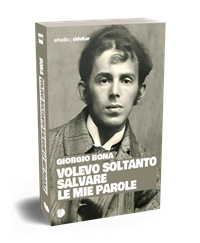La traversata del deserto
1
Ecco, alla fine ci è toccato. A noi che non lo credevamo possibile, che ci sapevamo con radici profonde. Anche a noi, come a tutti quelli che ci hanno preceduto, che chiamavamo folli per aver voltato le spalle alla loro terra e puntato lo sguardo oltre il mare. Ora la fiumana è giunta fin qui e ci sta trascinando via. Dobbiamo chinare la testa e lasciarci portare. Come tutti.
Meglio non pensare. Non è il momento. Ora è tempo di occuparci dei bagagli, della sistemazione. Siamo sulla nave, finalmente. Abbiamo attraversato la banchina lucida di pioggia pressoché di corsa e cominciato a salire la passerella senza quasi sentire il peso delle valigie. Un gradino dopo l’altro, mentre il passo si faceva più lento, siamo arrivati sul ponte con un senso di leggerezza. Di liberazione. Negli ultimi tempi, un’intima afflizione si era insinuata nei nostri cuori. Non ne parlavamo tra noi. Era lì, segreta e presente. Era nei silenzi, nelle risate subito spente, nelle parole mozze. Era un’agonia che lievitava lenta e annuvolava a tratti la mente, esitante come i gesti di noi donne che, giorno dopo giorno, riponevamo con cura gli effetti nei bauli, scegliendo cosa portare e cosa lasciare, quali oggetti scartare dalle nostre vite e quali tenere per avere l’illusione della continuità.
Ora siamo tutti sul ponte, noi due, i bambini, il nonno, Lucia, le due nonne. Giovani uomini in divisa ci orientano. Sorridono come se accogliessero i passeggeri di una crociera.
«Portate i bagagli in coperta», consiglia un marinaio, «ché stanotte l’acqua arriverà fin qua… Eh, sarà dura, stanotte!»
È il trentuno gennaio, è normale che il mare sia mosso. Chissà se dovremo davvero affrontare l’inferno. Nessuno di noi ha mai viaggiato per mare, a parte il nonno Francesco e la nonna Marina quando da Sciacca e da Alcamo vennero qua. Pochi chilometri di mare, attraversati di notte con le barche dei pescatori. Ma erano bambini e non hanno ricordi.
Ora dobbiamo trovare il nostro posto su questa nave. Prima forse è meglio dare un ultimo saluto ai parenti sul molo. Chissà quando li rivedremo. Si riesce a fatica a trovare uno spazio. Tutti vogliono farsi almeno scorgere da chi è rimasto a terra. Stiamo finalmente con i gomiti appoggiati al parapetto, immobili. La passerella è stata ritirata, il portellone è chiuso. Gli addetti si affannano intorno agli ormeggi, muovendosi in silenzio. Non si sente un respiro. Sembra di essere in un sogno in cui le cose accadono, ma le voci, i rumori, i gesti rimangono muti. I capannoni della dogana, così lunghi e bassi, sembrano mura di una cittadella che chiudono il porto. Oltre, Tunisi quasi non si distingue più nella sera che si avvicina. Sul molo la gente sta in attesa come a un capezzale. Pian piano si formano gruppetti che non alzano più la testa verso la nave. Poi, di colpo, il piazzale è vuoto. In pochi rimangono a sventolare fazzoletti bianchi. A un tratto non ne ho più voglia. Questi addii che non finiscono mai mi danno sui nervi. Lasciamo che i più giovani se ne stiano ancora attaccati al parapetto. Noi abbiamo altro da fare. Dobbiamo sistemare i bagagli, individuare i posti letto, il ristorante, il bar, capire come vivere nei prossimi due giorni di questo viaggio. Domani mattina arriveremo a Palermo. Ce ne hanno parlato sempre i nostri vecchi. La città più bella del mondo, dicevano. Chissà se potremo vederla, se potremo scendere dalla nave e andarcene in giro. Abbiamo un giorno intero. E la sera riprenderemo il mare per Napoli. Ci siamo. Siamo in mezzo alla tempesta. Come gli altri, ci lasceremo trasportare senza opporre resistenza. Per non annegare.
La nave è ancora ferma. Ci sediamo entrambi su un divanetto del salone. I nonni sono tranquilli nelle loro cuccette. Non ne volevano sapere di vedere partire la nave, non gli importa niente, hanno detto. Non vogliono nemmeno salire a cena. È davvero comodo questo divanetto. Sento che finalmente i muscoli si rilassano. Ci hanno avvelenato la vita fino all’ultimo, quelli là. Abbiamo dovuto sparpagliare sul bancone della dogana il contenuto delle nostre borse, mostrare i gioielli che indossavamo. Ci hanno chiesto di aprire il cappotto e il maglione, di toglierci i guanti, di tirare su le maniche. Lui è stato condotto altrove, spogliato, perquisito come un delinquente.
«Dov’è la macchina per cucire? Dov’è?», mi ha urlato il doganiere. «Dove l’hai messa?»
«L’ho lasciata a mia cognata, come vi ho detto ieri», ho risposto con calma.
«E i gioielli?», ha urlato ancora.
«Ve li abbiamo appena mostrati.»
«Gli altri? Dove avete messo gli altri?»
«Abbiamo tutto addosso.»
Il doganiere non si capacitava che questi italiani, questi rumi, possedessero così pochi oggetti di valore. Ha frugato nelle valigie, buttato all’aria il meticoloso ordine con cui avevamo sistemato ogni cosa. Poi è arrivato un suo collega.
«Sono persone oneste», ha assicurato esprimendosi in arabo. «Sono amici della mia famiglia. Lascia stare.»
Abbiamo rimesso la roba alla meglio nelle valigie e nelle borse. Quando lui è tornato, siamo usciti quasi volando. Avevamo superato il giudizio finale, potevamo partire.
2
Caspita! È già sera. Così, tutto a un tratto. Non si vede quasi più niente, solo qualche riflesso pallido sul molo ancora lucido. Ha smesso presto di nevicare stamattina, poi un po’ di pioggia e più niente per tutto il giorno. Chissà quando partiremo. Non ho mai preso la nave. Ho sempre solo viaggiato in macchina. Beh, sì, un paio di volte, sono anche andata in treno da Pont-du-Fahs a Tunisi. Ah, ecco la sirena. Una, due, tre volte. Forse si parte adesso… Il molo si allontana pian piano… Dapprima solo pochi metri, poi un baratro scuro che si allarga sempre più. Ci stiamo separando per sempre.
Voglio ancora stare aggrappata al corrimano con Lucia e François. L’impermeabile, che la mamma chiama cappotto, è troppo leggero e non mi ripara dalla brezza marina. Sollevo e stringo il largo collo intorno alla gola, ma non serve a niente. Ci sono ancora le luci all’orizzonte e non voglio perderle di vista. Fino a quando si vedrà il loro riverbero, io starò qui. Quella striscia di terra che sfuma all’orizzonte non la vedrò mai più. Di questo sono certa. Dicono che il mio paese – quello vero – sia di là dal mare. È là che stiamo tornando. Quel paese lì, non l’ho mai visto. Lo conosco solo per sentito dire.
«Se lei vedesse, signora mia, quanto è bello il cimitero di Bologna!», raccontava alla mamma il venditore ambulante di stoffe quando capitava a casa con le sue merci.
«Che cosa dice, signor Romeo. Un cimitero non è mai bello.»
«No, ma questo è un vero giardino, mi creda, un giardino monumentale!»
Non so altro di questa Italia, solo qualche briciola di conversazione raccattata per caso fra un gioco e l’altro. L’unico paese che conosco è quello minuscolo, là in fondo all’orizzonte. Ci sono piccole case tutte bianche e d’estate la terra si screpola, le erbe diventano secche e gialle e il vento di scirocco toglie il respiro. Le luci sono diventate puntini appena percettibili. La linea di terra quasi non si distingue più dalle ombre della notte. E io sto qui a guardarla diventare pian piano nulla.
Refoli di aria fredda penetrano attraverso le maniche fino quasi al gomito. Non potrò resistere ancora a lungo sul ponte. A un tratto, Lucia ci prende per le spalle.
«Les enfants, andiamo nel salone.»
È ora di cena. Il babbo e la mamma stanno seduti in silenzio. Appena ci vedono, si alzano e ci precedono verso il ristorante.
Un cameriere ci accompagna a un tavolo. Ci sediamo senza aprire bocca. Non sapremmo cosa chiedere e rimaniamo in attesa che ci portino qualcosa. Ci servono un brodo caldo con pastina. Il liquido oscilla nella scodella e ho il terrore che scivoli sulla tovaglia rosa così linda. Anche l’acqua nei bicchieri ha movimenti ondivaghi. Se traboccasse, che vergogna. Lo stomaco comincia a seguire il movimento dei liquidi sul tavolo. È impossibile mandar giù.
«Voglio andare a letto», dico.
«Anch’io», conferma il piccolo subito dopo di me.
«Io non me la sento proprio di mangiare», sussurra il babbo. «Non sto tanto bene.»
La mamma chiama il cameriere e gli chiede qualcosa per i nonni che sono rimasti a letto. Parla in italiano. Chissà quando l’avrà imparato. È la prima volta che la sento parlare in questa lingua. Mi sembra un’altra persona. Il cameriere le sorride.
«Certo, signora! Subito!»
E le porta delle mele, dei biscottini impacchettati e una bottiglia d’acqua. È molto gentile questo cameriere. Anche gli altri sono sorridenti e solleciti. Forse hanno pietà di noi che non abbiamo nemmeno più una casa. Siamo orfani in cerca di un rifugio. E loro così premurosi. Chissà, forse sono così tutti gli italiani.
Scendiamo i primi gradini e ci ritroviamo su uno stretto pianerottolo. La scala si biforca. Il babbo ci abbraccia.
«Noi uomini siamo di qua. Buona notte.»
La mamma gli dà una mela e un pacchettino di biscotti per il nonno Francesco. Continuiamo a scendere per altre due rampe. Poi entriamo in un camerone pieno di letti a castello e ci dirigiamo verso il fondo. La nonna Maria e la nonna Marina sono sdraiate su due letti contigui. Non si parlano, ma appena ci vedono, ci sorridono e si siedono sul letto. Si dividono un biscotto come due amichette nel cortile della scuola, poi si sdraiano di nuovo.
«Chi vuole stare nel letto a castello?», ci chiede la mamma.
«Io, io!», rispondo subito.
Mi arrampico senza tener conto della scaletta. Ho trascorso tante di quelle notti in un letto del genere quando ero in collegio. Passare nell’ala dei letti a castello voleva dire essere grandi. E io ci dormivo già da anni. So come si fa a non cadere quando gli incubi invadono i sonni. Ora non credo di poter dormire fino a sognare. Non sentirò i rumori che punteggiavano le mie notti al dormitorio del collegio. Solo il rollio della nave come un guscio in mezzo alle onde, con il frastuono che l’accompagna.
Mi sdraio senza togliermi i vestiti. Ho un pantalone nero e un maglione bordò con puntini colorati che la mamma ha finito poco prima della partenza. Tolgo solo le scarpe che appoggio ai piedi. Lucia è nel letto accanto, vestita esattamente come me. Da poco ho avuto il permesso di non chiamarla zia. Mi guarda, sorride, poi volge gli occhi verso il soffitto basso e s’irrigidisce.
Me ne sto sdraiata come un cadavere, i piedi dritti e le mani intrecciate sull’addome. Non mi piace addormentarmi in questa posizione. Temo di non svegliarmi più. E se l’Azrail, l’angelo della morte, vedendomi così, credesse che io sia pronta e pensasse di portarsi via la mia anima? Mi giro su un lato. Lo stomaco segue il ritmo della nave, su e giù, in gola e in fondo, e la nausea cresce e cala. Non posso starmene di fianco, devo tornare nella posizione da morto. E se poi passasse davvero l’Azrail. Beh, che m’importa. Io sto qui a morire di nausea. In fondo forse nemmeno esiste quest’angelo. Ho letto da qualche parte che, per non soffrire troppo, bisogna respirare accompagnando i movimenti della nave. Aspirare quando va su, espirare quando va giù. Cerco di seguire il ritmo aggrappandomi con diligenza puntigliosa. Su, giù, su, giù, su, giù… E non esiste null’altro che lei e me… lei e me… lei e me…
3
È meglio che metta il piccolo a dormire con me questa notte. Gli asciugamani sono rimasti piegati nella borsa. Nessuno si è ricordato di lavarsi stasera. Ci penseremo domani. Forse saremo un po’ più riposati dopo questa nottata.
«Vieni qui nel mio letto. Prendi il cuscino e mettiti lì in fondo.» «Non ho sonno però. La pancia mi gira da tutte le parti.»
«Fa lo stesso se non hai sonno. Mettiti sdraiato. Vedrai che la pancia andrà meglio. Adesso ci metto la mano sopra e vedrai che ti passa.»
È meglio che non gli tolga i vestiti, solo le scarpe. Se gli metto la mano sullo stomaco, forse si rasserena e, chissà, magari si addormenta. Dovrei cantargli la ninna nanna come a casa, quando era piccolo. Funzionerebbe, ne sono sicura. Ma qui… con tutte queste donne. Perché mi guarda con quegli occhi spalancati? Ma sì, adesso gliela canto pian piano… Non so se riesce a sentirmi. Sì, sta sorridendo.
«Chiudi gli occhi, così ti viene il sonno.»
«Le marchand de sable non passa sulla nave.»
«Se tieni gli occhi chiusi, vedrai che passa.»
«Perché non ti sdrai?»
«Perché ogni tanto guardo le nonne, se hanno bisogno. Stai tranquillo, rimango qui vicino a te.»
Alla fine riuscirà ad addormentarsi. Le nonne sono sdraiate. Nemmeno loro dormono. Hanno mangiato così poco. Un biscotto in due. Chissà come faranno a sopportare le fatiche del viaggio.
La grande è lassù, sul letto a castello. Sembra che le faccia piacere stare lì. Ci si è arrampicata come un gatto. Le ricorda il collegio forse. Credevo che non volesse pensarci più. Forse mi sbaglio.
«Su, dormi. Ti tengo la mano sulla pancia. Senti com’è calda?»
Ogni lunedì mattina, quando suo padre l’accompagnava a scuola, mi sentivo strappare le viscere. Soprattutto il primo anno. Così piccola e già lontana da noi. Bisognava non far capire niente, lasciarli partire da soli per chiudere prima la faccenda. E mettersi a fare i la- vori di casa a testa bassa. O filare nell’orto a fare i lavori degli uomini, che tolgono il fiato. Poi, pian piano mi ci sono abituata. Quella buona tazza di caffè con il feuilleton della settimana appena la macchina spariva in mezzo al polverone… Non c’era altra scelta. Non volevamo che crescesse come noi. Oddio, lui ha fatto studi regolari, almeno fino verso i quattordici anni, quando suo padre l’ha messo a lavorare nei campi. A casa mia è stato ancora più semplice. C’era bisogno di me per accudire alle sorelline. Non c’era tempo per la scuola. Mai ho avuto tempo, io. Solo un anno ci sono andata e perché la maestra mi ha notata.
«Che cosa fa questa bambina in casa? Perché non viene a scuola?»
Si vede che si sono vergognati e mi ci hanno mandato. Allora, ricordo bene, la nostra casa era attaccata al cortile della scuola. Il mattino arrivavo un’oretta prima, spazzavo l’aula, poi toglievo la polvere. Mi pagavano, certo che mi pagavano, chissà quanto però, non ricordo. Ma quella volta che avevo le dita gonfie per i geloni, e appena sfioravano il legno duro dei banchi, mi veniva da urlare dal dolore… Quella volta, appunto. La maestra aspettò che tutti fossero seduti ai loro posti. Poi mi chiamò. Mi alzai e rimasi in attesa.
«È così che si puliscono i banchi? Non vedi che hai lasciato della polvere qui? E qui? E qui?»
Continuava a parlare con quella voce secca che rintronava nel silenzio, mentre passava il dito sui banchi, se lo portava davanti agli occhi e poi lo mostrava a tutta la classe. Che vergogna davanti a tutti. Nessuno dei miei compagni sapeva chi teneva pulita l’aula. Nessuno ha guardato dalla mia parte. Sono rimasti a capo chino ad ascoltare. Quella, non la scorderò mai. Certo non le ho dato problemi per imparare a leggere. Sapevo già farlo quando sono arrivata in classe. Mi aveva insegnato Giuseppe, il mio povero fratello scapestrato. Sapevo riconoscere le lettere e metterle insieme a formare le parole. In italiano però. A scuola, c’era il francese e all’inizio, tutte quelle lettere scrupolosamente lette senza trascurarne nessuna.
Ma ho capito in fretta. Dopo due mesi, la maestra già mi affidava il gruppo dei più piccoli, con quello stupido di Jean che non riusciva a ricordare nemmeno un segno e mi faceva impazzire di rabbia. Come si può avere il cervello vuoto fino a quel punto. Buono per badare alle capre, quel Jean, come ha finito per fare. La scuola non era per lui. Per me sì. Avrei voluto fare il medico, oppure, al limite, l’infermiera. Invece, l’anno dopo è nata Lucia e ho dovuto occuparmene. Se non sono analfabeta, è per merito della maestra, quella nuova che è arrivata l’anno dopo. Madame Ambrosi si chiamava. M’incitava continuamente.
«Non capisco quello che leggo», le dicevo.
«Non importa, mon petit», insisteva, «ricomincia la stessa pagina fino a quando non avrai capito. Lascia perdere le singole parole, cerca di capire l’insieme. Alle singole parole ci arriverai poi, quando diventerai più esigente.»
Benedetta quella maestra. Mi prestava i libri della biblioteca scolastica. Faticavo il giorno con la casa e la sera con le parole. Leggevo e rileggevo. Storie di bambini fortunati del secolo passato, delle loro vacanze nel castello di famiglia, di cugini e amichetti, e dell’infelice Sophie che pure aveva tutto… Da una bambina all’altra, da un luogo all’altro, volevo sapere tutto di loro. Mi facevano sognare. E mi appassionai. Poi, durante la guerra, che follie ho fatto per continuare a leggere. Non avevo più libri francesi e ho ricominciato a leggere in italiano i romanzi a puntate sui paladini di Francia che papà comprava ogni volta che andava a Tunisi e che custodiva quasi segretamente in un cofanetto metallico. Ai miei fratelli era proibito toccarlo, solo io potevo aprirlo. Ho ancora in mente quelle nottate di guerra, con il coprifuoco, e io sotto una coperta con la candela accesa e il libro in mano, per tutta la notte, o quasi. A rischio d’incendiare il letto. E la mattina dopo, con il naso affumicato. Quando è finita la guerra, nell’orto abbiamo trovato una cassetta di metallo in una buca. Noi giovani pensavamo a un tesoro, un qualche bottino di guerra. L’ha aperta Michele. C’era un grosso volume, il Novissimo Melzi, con il nome del proprietario, Camillo Guglielmi. Era di Milano, ricordo bene. Che fine avrà fatto, povero carabiniere. Forse ha nascosto la cassetta proprio nel nostro orto perché la trovassimo. Noi e non altri. «Tsè! Come potevamo vincere la guerra con tutta ’sta zavorra inutile che ci portavamo dietro!», ha esclamato Michele e se n’è andato alzando le spalle.
Così ho ripreso la lettura. Avevo raccattato pazientemente le pagine dei libri di papà sparpagliati per casa, dopo il nostro rientro. Alcuni foglietti erano stati usati come carta igienica dai soldati. Avevo delle storie monche. Ma ho ricominciato a leggere con il dizionario accanto e ho finalmente capito termini come “approdare”, “lusinghiero”, “farneticante”. E poi da sposata, in piedi, con il libro aperto sul comò, per sviare i bambini che non mi sopportavano in lettura e subito accorrevano per saltarmi in braccio.
Sarà meglio che mi sdrai un po’. Forse riuscirò ad addormentarmi anch’io. Con questa testa così pesante, mi farà bene. Domani la giornata sarà lunga. Certo che per i miei figli ho voluto, voglio e vorrò sempre che studino. Non potevamo far altro che mettere in collegio la grande. Non c’erano altre possibilità. Meglio il collegio che l’ignoranza. Anche il piccolo avrebbe dovuto cominciare quest’anno. Ora non so come gireranno le cose. Ma la scuola sarà il primo pensiero. A qualsiasi costo. Speriamo che Dio ci aiuti. Comunque, finché avremo braccia e forza per lavorare, non sarà un problema. Le cose alla fine si aggiustano sempre. Ci vuole solo pazienza. Oh, la nonna Marina si lamenta, forse non si sente bene.
«Mamma, che avete?»
«Accompagnami in bagno, per favore. Ho lo stomaco in subbuglio.»
Ci avviamo lentamente per il corridoio. I bagni sono in fondo. Non so come faremo ad arrivarci. Tutto oscilla. Le scalette dei letti a castello sferragliano a destra e a manca. Non riusciamo quasi a stare in piedi. La nonna non ce la farà mai ad arrivare fino ai bagni. Non può vomitare qui nel corridoio. Non saprei come fare dopo per pulire. Devo trovare una soluzione.
«Attaccatevi a me con una mano. Così. Sì, mettete una mano sulla mia spalla e con l’altra vi tenete. Così io ho le mani libere e posso tenermi stretta bene… State tranquilla, riesco a stare in equilibrio per tutte e due.»
Procediamo molto lentamente. Purché non vomiti qui. Purché riusciamo ad arrivare fino ai bagni. Ecco. Ce ne sono tre. Uno è occupato. Nell’altro, c’è Antoinette, la figlia di Mastro Leonardo, seduta per terra, con la bocca sulla turca. Solo il bagno del mezzo è libero.
«Mamma, mettevi qui. Antoinette, vuoi che ti aiuti a tornare al tuo letto?»
«No, sto troppo male. Oramai passerò la notte qui. Puoi dare un’occhiata a mia madre? Anche lei ha il mal di mare.»
«Stai tranquilla, andrò a vederla.»
Torniamo ai nostri posti. Lascio la nonna Marina mentre si sdraia e pian piano mi avvio dall’altra parte del dormitorio, verso la madre di Antoinette. È lassù, su un letto a castello. Che idea fare arrampicare una signora di quell’età fino lì.
«Donna Santina, come vi sentite?»
È bianca come un cencio sbattuto dal vento. All’improvviso, gira il viso verso il basso e un fiume le esce dalla bocca. La vecchietta del letto di sotto, che era già tutta rannicchiata, quasi scompare nel buio delle coperte.
«Donna Santina, vi posso aiutare? Volete un po’ d’acqua?»
«No, niente, niente. Vediamo se posso dormire un po’.» «Chiamate, se avete bisogno.»
Sembra che non abbia nemmeno sentito. Meglio che vada a sdraiarmi anch’io. La testa comincia a farmi male.