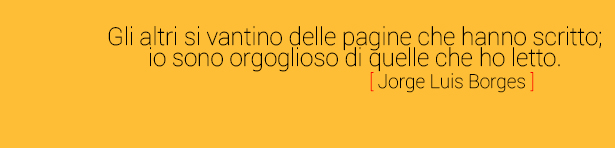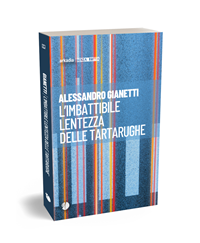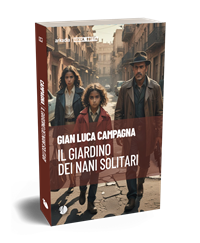Eclypse
Gli ingranaggi dei ricordi
“E’ la guerra, Generosa. A Roma c’è l’occupazione, ci sono i tedeschi. Ognuno fa quello che può.”
Pag. 104
TRAMA:
Cagliari, 1943. Dopo l’ultimo bombardamento, Generosa lascia a malincuore la città devastata e si rifugia in un paese dell’interno con i figli e due donne di servizio. È in pena per il marito, rimasto nel capoluogo in qualità di medico all’ospedale militare, per il figlio che deve nascere e per quelli che ha già, ma soprattutto è in pena per sua sorella Gisella e suo fratello Silvio, che vivono a Roma e pare siano coinvolti nella lotta partigiana. Olbia, 1943. Felice ha 18 anni e, con le due sorelle Bella e Demy, accompagna il padre a imbarcarsi sul traghetto che lo condurrà sul Continente. Ora tocca a lui prendersi cura delle ragazze, in un lungo vagabondaggio che percorrerà l’isola da nord a sud, da un paese all’altro, tra mille disavventure e incontri bizzarri. Roma, 1944. Un attentato in via Rasella provoca la morte di 33 soldati tedeschi e due civili italiani. Il giorno dopo, per rappresaglia, i germanici uccidono 335 italiani alle Fosse Ardeatine.
RECENSIONE:
Tra i numerosi generi letterari, le saghe familiari sono molto amate e lo dimostrano chiaramente le classifiche dei libri più venduti e il successo del celebre “L’amica geniale”. Questi romanzi raccontano la storia di una famiglia nell’arco di diverse generazioni e così fa “Gli ingranaggi dei ricordi”, narrando le vicissitudini della famiglia di Generosa Zedda-Serra e di quella di Demy Dubois, due donne forti e originali, personaggi pittoreschi ai quali il lettore si affezionerà subito. La prima, figlia del notaio Serra e moglie di un medico di nome Ruggero (sempre in prima linea per aiutare il prossimo), scamperà ai bombardamenti di Cagliari con due gemelli nella pancia, e da questa città racconterà le sue pene e i suoi pensieri per la sorella Gisella, trasferitasi a Roma con il fratello Silvio. Quest’ultimo avrà un ruolo centrale nella storia: il ragazzo “dagli occhi azzurri e dai lineamenti delicati” (pag.58) farà parte dei GAP, combattenti urbani di un nucleo partigiano, e avrà parte attiva nell’attentato di via Rasella del 1944. La storia di Silvio viene indagata con dovizia di particolari da Kevin, pronipote di Generosa, che sta scrivendo la tesi per laurearsi in Storia. Antifascista convinto, Kevin è invitato dal suo relatore ad approfondire la misteriosa figura dello zio per cercare di scoprire quale sia stato il suo ruolo nei GAP, oltre a comprendere se sia stato tra le vittime della tragedia delle Fosse Ardeatine. Il giovanesi si avventura così in una ricerca “un po’ storica e un po’ famigliare,” prendendo “confidenza” con questi antenati la cui storia “sembra essere strettamente intrecciata con quella famosa storia con la S maiuscola” (pag. 31). Parallelamente scopriamo a poco a poco le vicissitudini di Carla, alle prese con la cura della zia inferma di nome Demoiselle “Demy” Dubois, personaggio goliardico e divertente affetto ormai da demenza senile. Demy racconta a Carla e al lettore della sua migrazione lungo tutta la Sardegna, un viaggio a piedi percorso con la sorella Bella e il fratello Felice, padre di Carla e colui che si innamorerà di Maria Ausilia (figlia di Generosa), legando così le figure degli Zedda-Serra e dei Dubois. Carla tornerà più volte in Sardegna per accompagnare e aiutare la cugina Donata nel traferimento della zia da una RSA a Villa Gioiosa, nuova residenza per anziani dove l’anziana sarà accolta e seguita. Carla si affezionerà quindi a questa anziana un po’ bisbetica e perdutamente innamorata del “suo” Marco, un uomo sposato che proprio non riesce a dimenticare. “Gli ingranaggi dei ricordi” è un intreccio ben costruito tra passato e presente, con una ricostruzione storica che si mescola alle emozioni introspettive dei personaggi: un romanzo commovente ma ironico allo stesso tempo, che appassiona e diverte dalle prime alle ultime pagine.
La recensione su Introspectif
Cagliari “La bella virtù” di Marisa Salabelle Nuova anteprima della XI edizione del Festival Premio Emilio Lussu
Un’opera corale che esplora temi universali come la memoria, la malattia, la perdita, l’amore e la
ricerca delle proprie radici. È “La bella virtù”, il nuovo romanzo di Marisa Salabelle, edito da Arkadia
(2025), che sarà presentato venerdì 7 marzo alle 19, al Centro Culturale Hermaea di Pirri (via Santa Maria
Chiara 24A), tra le anteprime della XI edizione del Festival Premio Emilio Lussu organizzato
dall’associazione culturale L’Alambicco. A dialogare con l’autrice sarà lo scrittore Daniele Congiu.
La scrittura di Salabelle è elegante e incisiva, e rende la lettura un’esperienza intensa e appagante.
Attraverso la storia di una famiglia, l’autrice offre uno spaccato della società italiana del Novecento, con le
sue trasformazioni e i suoi contrasti, coinvolgendo il lettore all’interno di pagine dove prendono vita
personaggi delineati con cura e profondità psicologica. Il racconto invita alla riflessione sulla complessità dei
rapporti umani e sulla forza dei legami familiari.
La scrittrice è nata a Cagliari nel 1955 e vive a Pistoia dal 1965. È laureata in Storia all’Università di Firenze e
ha frequentato il triennio di studi teologici al Seminario arcivescovile della stessa città. Dal 1978 al 2016 ha
svolto la professione di insegnante. Nel 2015 ha pubblicato il suo romanzo d’esordio, “L’estate che
ammazzarono Efisia Caddozzu” (Piemme), seguito nel 2019 dal suo secondo romanzo, “L’ultimo dei Santi”
(Tarka). Entrambe le opere sono state finaliste al Premio letterario “La Provincia in Giallo”, rispettivamente
nel 2016 e nel 2020. Nel settembre 2020 è uscito il romanzo storico-familiare “Gli ingranaggi dei ricordi”
(Arkadia Editore) e nel 2022 “Il ferro da calza” (Tarka), un giallo con ambientazione appenninica. Suoi
articoli e racconti sono apparsi su riviste online e antologie cartacee.
La segnalazione su Mediterranews
Venerdì a Cagliari “La bella virtù” di Marisa Salabelle
Nuova anteprima della XI edizione del Festival Premio Emilio Lussu
In programma il 7 marzo la presentazione del romanzo edito da Arkadia
È online il bando di concorso per le opere di Narrativa e Saggistica edita con scadenza il 1° giugno 2025
CAGLIARI. Un’opera corale che esplora temi universali come la memoria, la malattia, la perdita, l’amore e la ricerca delle proprie radici. È “La bella virtù”, il nuovo romanzo di Marisa Salabelle, edito da Arkadia (2025), che sarà presentato venerdì 7 marzo alle 19, al Centro Culturale Hermaea di Pirri (via Santa Maria Chiara 24A), tra le anteprime della XI edizione del Festival Premio Emilio Lussu organizzato dall’associazione culturale L’Alambicco. A dialogare con l’autrice sarà lo scrittore Daniele Congiu. La scrittura di Salabelle è elegante e incisiva, e rende la lettura un’esperienza intensa e appagante. Attraverso la storia di una famiglia, l’autrice offre uno spaccato della società italiana del Novecento, con le sue trasformazioni e i suoi contrasti, coinvolgendo il lettore all’interno di pagine dove prendono vita personaggi delineati con cura e profondità psicologica. Il racconto invita alla riflessione sulla complessità dei rapporti umani e sulla forza dei legami familiari. La scrittrice è nata a Cagliari nel 1955 e vive a Pistoia dal 1965. È laureata in Storia all’Università di Firenze e ha frequentato il triennio di studi teologici al Seminario arcivescovile della stessa città. Dal 1978 al 2016 ha svolto la professione di insegnante. Nel 2015 ha pubblicato il suo romanzo d’esordio, “L’estate che ammazzarono Efisia Caddozzu” (Piemme), seguito nel 2019 dal suo secondo romanzo, “L’ultimo dei Santi” (Tarka). Entrambe le opere sono state finaliste al Premio letterario “La Provincia in Giallo”, rispettivamente nel 2016 e nel 2020. Nel settembre 2020 è uscito il romanzo storico-familiare “Gli ingranaggi dei ricordi” (Arkadia Editore) e nel 2022 “Il ferro da calza” (Tarka), un giallo con ambientazione appenninica. Suoi articoli e racconti sono apparsi su riviste online e antologie cartacee.
La segnalazione su Sardegna Reporter
“Leuta”
Leuta, Mario Falcone, Arkadia. Leuta è un’isola, si trova in mezzo al Mediterraneo, fra Lampedusa e Malta: lì è nato e cresciuto, e non vi torna da tanto tempo, Enrico Criaco, che si è costruito una vita fruttuosa lontano. Scrittore di successo, sul limitare dell’età acerba ha dovuto abbandonare il suo mondo perché schiacciato da un dolore ingestibile: è passato mezzo secolo, e immagina naturalmente e razionalmente di non avere altrettanto tempo dinnanzi a sé, ed è convinto che li potrà ritrovare serenità, grazie agli amici ritrovati, alla famiglia o a quel che ne rimane, ma il conflitto che lo lacera comunque non sembra trovare requie, disilluso da tutto e tutti. Rimettere insieme i pezzi non è semplice, ma talvolta la frattura può essere un esaltante e prezioso filo d’oro: è una storia articolata quella di Enrico, raccontata con delicata profondità, piacevole a leggersi, emozionante e coinvolgente, bella sin dalla copertina.
Gabriele Ottaviani
La recensione su Convenzionali
Intervista a Marisa Salabelle, in libreria con “La bella virtù”
Secondo volume sulla storia di una famiglia, “La bella virtù” spazia dagli anni Cinquanta e Sessanta ma arriva fino alla pandemia di Coronavirus, dando voce a quattro personaggi, fra vita di tutti i giorni, lutti e ricerche. In questa intervista Marisa Salabelle ci lascia entrare nel suo progetto, fra possibili nuovi sviluppi, sessualità, religione e i grandi autori che l’hanno accompagnata e ispirata.
Marisa Salabelle è nata a Cagliari, ma vive a Pistoia dal 1965. Laureata in Storia all’università di Firenze, ha frequentato il triennio di studio teologici presso il seminario arcivescovile della stessa città.
I suoi libri più famosi sono Gli ingranaggi dei ricordi, 2020, e La scrittrice obesa, nel 2022 sempre per Arkadia Editore.
La bella virtù è pubblicato per Arkadia editore nel 2025 e le domande sono per questo libro.
Intervista a Marisa Salabelle
Buongiorno e grazie. Dove ha preso l’idea della bella copertina e del titolo del romanzo?
Copertina e titolo sono di competenza dell’editore, come i paratesti, cioè quello che viene scritto sui risvolti e nella quarta di copertina: presentazione del libro, bio dell’autore, una citazione… Tuttavia con i piccoli editori c’è una discreta collaborazione riguardo a questi aspetti. Il titolo è quello che ho proposto io: non sempre va così, con Arkadia ho pubblicato tre romanzi e sia La bella virtù che La scrittrice obesa sono titoli miei, mentre Gli ingranaggi dei ricordi è stato concordato con l’editore.
Per quanto riguarda la copertina, di solito Arkadia mi propone una scelta di immagini. In questo caso l’editore mi ha mandato una serie di bozze di copertina tra le quali la mia preferita è stata quella poi prescelta, ovvero l’immagine di una bella ragazza sorridente a bordo di una Vespa, che in qualche modo rappresenta, per me, il personaggio di Maria Ausilia, una ragazza che cerca, senza riuscirci del tutto, di emanciparsi dal ruolo che una società ancora patriarcale le ha assegnato.
Chi scrive ha detto che le pagine del libro possono essere anche pezzi di un diario o lettere. Cosa sono realmente nella sua scrittura?
Questo romanzo è costruito su quattro voci narranti: ognuno dei protagonisti parla in prima persona, perciò potremmo dire che i loro contributi costituiscono in effetti una sorta di diario per quanto riguarda Carla e Kevin, mentre si tratta di memorie nel caso di Felice e Maria Ausilia.
Se invece intende cosa siano, per me, le pagine che scrivo, indubbiamente la componente maggiore è rappresentata dalla memoria: memoria dei tempi in cui ho vissuto, delle esperienze che ho avuto, delle persone che ho conosciuto. Voglio precisare però che la mia scrittura non è nostalgica, non c’è nostalgia del passato in me e nemmeno nelle cose che scrivo. Inoltre, anche se attingo a materiale personale, ci tengo sempre a precisare che i miei sono romanzi e non “storie vere”: la componente biografica c’è ma è mescolata a quella dettata dalla fantasia.
La vita nel libro scorre tranquilla, tranne un avvenimento luttuoso enorme. Come ha messo insieme il dolore con la dolcezza?
Il libro parla della vita di una famiglia come tante, con alcuni aspetti che la rendono originale (per esempio la parentela con un santo famoso) e altri invece che la rendono rappresentativa di una società e di un’epoca, l’Italia degli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. Come in tutte le famiglie, a un tran tran tutto sommato banale si alternano pagine drammatiche.
Tutti noi abbiamo perduto una o più persone care. Il mio modo di raccontare la tragedia è attraverso una leggera ironia: sono un po’ manzoniana, in questo, non riesco ad abbandonarmi al dramma, detesto il patetico e quindi cerco di smorzare il dolore con un sorriso.
Nel romanzo conta molto lo scandire del tempo: a volte si va a ritroso, ma perlopiù si arriva al 2020, con solo accenti preoccupanti per il coronavirus. Perché il bisogno di nominarlo ma in modo circoscritto, sintetico?
Avevo bisogno di inventarmi qualcosa per vivacizzare il personaggio di Kevin, il giovane studente che fa ricerche sulla genealogia familiare, perché non risultasse una figura scialba. Così, tenendo presenti gli anni in cui collocare il suo lavoro per la laurea magistrale (nel precedente Gli ingranaggi dei ricordi Kevin aveva svolto la tesi triennale sulla figura di Silvio Serra, partigiano non molto noto e prozio di sua madre, nel 2016) ho avuto l’idea di farlo slittare al 2020, in modo da sfruttare la pandemia per arricchire la parte relativa a Kevin. Felice e Maria Ausilia sono spalmati in tutto il romanzo. La figlia Carla scrive quasi solamente di loro con un rapporto strettissimo col padre Felice, che sembra il perno della narrazione. La convince quello che ho scritto?
Senza dubbio, almeno nelle mie intenzioni, il protagonista assoluto del romanzo è Felice, di cui si rievoca l’infanzia difficile, si seguono gli anni della giovinezza e della maturità, infine lo si accompagna nella malattia e nella morte. Felice è una delle voci narranti ed è inoltre protagonista delle narrazioni di Maria Ausilia, sua moglie, e di Carla, sua figlia. Anche le ricerche di Kevin sono collegate alla figura di Felice, perché è sulla sua famiglia che il giovane indaga, per scoprire l’esatto rapporto di parentela tra il nonno Felice e il santo Giuseppe Moscati.
Lei ha uno stile riconoscibile; ma cosa migliorerebbe di questa “saga” familiare?
Non so cosa rispondere a questa domanda… non perché penso che il romanzo sia perfetto, tutt’altro, ma perché ci ho lavorato molto e ho cercato di fare “il meglio possibile”.
Cioè, penso che questa sorta di saga in due volumi (Ingranaggi e Bella virtù) sia il meglio che io potessi fare riguardo a questo tema. Naturalmente un lettore esterno potrebbe indicarmi i lati deboli, darmi dei consigli e suggerirmi dei miglioramenti, e questo in effetti è accaduto mentre i due romanzi erano in corso d’opera: ormai però sono usciti e non si possono migliorare più…
Qualcuno mi ha detto che il ciclo potrebbe completarsi con un terzo romanzo, perché ci sono personaggi che hanno avuto un ruolo marginale e che potrebbero aver voglia di far sentire la loro voce. Devo dire che non avevo pensato a un terzo capitolo, ma in effetti questo suggerimento lo trovo stimolante!
Maria Ausilia da sola regge dolore e ironia, mentre Kevin sembra un pretesto per non dare ulteriore spazio a Felice, Maria Ausilia e Carla. O è solo una mia impressione?
Kevin è un personaggio “di servizio”. A lui infatti, in entrambi i libri, sono affidate ricerche che devono chiarire alcuni aspetti poco conosciuti della vicenda familiare. Forse per questo ha meno spessore degli altri: non mi interessava approfondire la sua interiorità, quanto seguire le sue ricerche e le sue riflessioni, i suoi dubbi in proposito. È anche un personaggio “di alleggerimento”, perché è giovane, un po’ scettico, e le sue avventure sono lievi.
Lei parla di sesso tra coniugi molto ignoranti del come si pratica con una grazia che ci fa sorridere. Perché Felice è così preso ancora dal rapporto con la Chiesa cattolica? Di solito chi entra in istituti religiosi poi cerca di dimenticare quel periodo. È così?
Secondo me l’educazione ricevuta da bambini e da ragazzi lascia un’impronta importante in quello che poi diventiamo. In particolare l’educazione ricevuta all’interno di un ente religioso, soprattutto in periodi della nostra storia passata in cui il peso dell’educazione cattolica era davvero forte. Inoltre Felice è un ragazzo abbandonato, vive per strada, non ha la madre e suo padre è spesso lontano: è inevitabile che si leghi a don Angioni, il prete salesiano che diventa il suo mentore, e che assorba profondamente i suoi insegnamenti.
Riguardo poi alla sessualità, c’è da dire che proprio negli anni Cinquanta del Novecento un pesante silenzio avvolge sia la sana, normale sessualità coniugale, che le situazioni di abuso. Maria Ausilia, che non è bigotta come Felice, non ha ricevuto in famiglia un’educazione sessuale, e del resto all’epoca questo era normale, perciò prima del matrimonio è in ansia perché non sa cosa deve aspettarsi…
Insomma lei mette un punto al proseguimento di questa famiglia con la morte di Felice? Pensa che due libri siano sufficienti? Perché lo ha fatto morire tra forti dolori? Lei ha paura della morte?
Alla prima parte della domanda ho già risposto: non pensavo di scrivere un terzo capitolo della saga, ma potrei farci un pensiero alla luce di alcuni commenti che ho ricevuto.
Riguardo alla morte di Felice, più che forti dolori quello che lui prova è una grande sofferenza psichica. Nonostante sia anziano, non vuole arrendersi, non vuole morire, e nonostante la sua fede ha il terrore della morte. Si può dire che la fede non l’aiuta ad affrontarla.
Quanto a me, ho ormai una certa età e nella mia vita ho visto morire molte persone, alcune delle quali in età avanzata, ma altre ancora giovani. Forse per questo la morte è sempre presente nei miei libri, e non soltanto nei gialli, dove è praticamente d’obbligo. Mi sono accorta che nel primo capitolo di ognuno dei miei libri, considerando anche alcune cose che ho scritto ma non ancora pubblicato, nel primo capitolo, dicevo, c’è sempre una morte…
Riguardo alla mia, di morte, non ci penso granché; penso di avere davanti a me ancora un po’ di tempo, e non sono particolarmente preoccupata. La cosa di cui ho paura non è tanto il morire, ma la sofferenza, l’invalidità, la perdita dell’autosufficienza.
Mi dica, se ne ha voglia, quali libri leggeva durante la scrittura del romanzo e in generale di libri recenti che le sono piaciuti.
Oh, impossibile rispondere a questa domanda… io leggo una quantità veramente industriale di libri, e non ricordo cosa leggessi durante la stesura di questo romanzo.
Però posso dire qualcosa degli autori o dei libri che mi hanno influenzata. Ho già citato Manzoni per l’ironia e aggiungo anche per il “misto di storia e d’invenzione”, che è una caratteristica del mio scrivere e che a volte mi procura divertenti scambi di battute con quelli dei miei lettori che mi conoscono personalmente. Per l’infanzia di Felice, il modello è sicuramente dickensiano, e del resto Dickens compare nel romanzo fin dalle prime pagine, come un autore amato e discusso da Felice e da sua figlia Carla. Per la pluralità delle voci narranti, che è presente anche in altri miei libri, mi sono ispirata a uno scrittore che ho amato molto, Abraham Yehoshua. Infine, per la descrizione delle difficoltà di Felice e Maria Ausilia nei primi tempi della loro vita sessuale ho preso spunto da Chesil Beach, un romanzo di uno dei miei autori preferiti, Ian McEwan.
Vincenzo Mazzaccaro
L’intervista su SoloLibri
Il tema di Ethna, di Anna Bertini, Arkadia editore 2025, recensione di Daniela Domenici
Ho “incontrato” sulla mia strada, per la prima volta, la scrittrice Anna Bertini grazie a questa sua opera recente, appena edita da Arkadia, ed è stato un vero piacere per vari motivi. In primis per come ha saputo ben caratterizzare la principale protagonista, Ethna, che è una musicista toscano-irlandese, per essere più precise/i è una violoncellista jazz, e la moltitudine di co-protagonisti/e che fanno parte della sua vita in vari momenti e la rendono piena e colorata, mai noiosa, da Enzo a Lora, da Lorenzo a Sabrina, da Jeffrey a Chris, da Horace a Kevin e a Nina, ognuno/a di loro ha un ruolo ben definito nella storia di Ethna e ne disegna il tema sul pentagramma della sua esistenza. Complimenti per come ha descritto i paesaggi di Castel Sonnino, di Livorno, di Firenze e, in parallelo, quelli di una particolare zona dell’Irlanda: magici e struggenti. E complimenti anche per aver inserito molte frasi in inglese (senza traduzione), che fanno da perfetto contraltare ai dialoghi e alle parti narrative in italiano, per mettere in evidenza la doppia anima di Ethna: quella irlandese e quella toscana.
Daniela Domenici
La recensione su Daniela e Dintorni
Il tema di Ethna
Il tema di Ethna è l’ultimo romanzo di Anna Bertini, alla sua seconda pubblicazione con Arkadia Editore, casa editrice sarda che, con la sua collana Eclypse, porta in libreria romanzi di alta qualità letteraria nei quali le emozioni e i vissuti risaltano dietro trame originali e stili identitari dei suoi autori. Bertini in questo libro ha saputo fondere nella sua prosa e nella sua narrazione le ampie conoscenze acquisite in campo linguistico e musicale, ma non solo, le vissute esperienze umane e professionali all’estero traspaiono nell’articolazione della trama, in cui non vi è una sola verità ma un percorso sincero, atto alla ricerca di sé stessi, perché solo nel vivere la vita appieno si possono scoprire le carte che a mano a mano la stessa offre. Il romanzo, sviluppato in due parti e costruito su diverse linee temporali, ambientato tra l’Irlanda e l’Italia, narra la vita di Ethna e delle persone che nel corso della sua esistenza hanno influenzato il suo modo di essere, la sua affettività e la sua vita professionale Nel 2004, durante un viaggio in treno, attraverso il finestrino, Ethna è come folgorata da uno scorcio incastonato nel verde brillante della vegetazione Toscana; è il Castello Sonnino, un luogo che appartiene al suo passato e che, ora, con spietata prepotenza, reclama la sua attenzione. La protagonista, rispondendo alla forte chiamata, scende dal treno per andare incontro a un capitolo della sua vita mai chiuso, uno spaccato denso del suo passato che ha un nome preciso: Lorenzo Possenti, avvocato brillante della zona, amore passionale interrotto.
«Però, poi, quel treno decise di passare da Sonnino. Perché le cose, sì tornano; tornano dal passato e sconvolgono il presente per fortuna.» pag. 116
Estate del 1997, Ethna attraversava un periodo complicato, il suo matrimonio stava naufragando, la sua arte di creare composizioni musicali jazz si era prosciugata come una vena in cui tutto l’oro era stato predato.
«Qualche nota si smosse, nella mia mente. La sequenza in tenuto e piano, frusciante con gli archetti appena appoggiati alle corde, accarezzò il pensiero…» pag. 34
Lorenzo Possenti e le persone di Castello Sonnino erano state l’innesco per liberarla dal suo modo di pensare rigido e spesso giudicante, ma quel momento, fatto di nuotate in mare sotto la luna, gite e discorsi importanti atti a comprendere il proprio essere, veniva violentemente spazzato da uno scandalo in cui era coinvolto Lorenzo. Ethna, sconvolta ma ferma, decideva quindi di lasciare quel luogo e di non farvi più ritorno. Lora, la madre di origine irlandese di Ethna, è preoccupata per lei, la morte del padre Enzo, figura positiva, centrale e determinante per la figlia, ha creato un grandissimo vuoto per entrambe, ma soprattutto ha lasciato irrisolta la composizione di un grande mosaico incomprensibile e incompiuto: Enzo non è il padre biologico di Ethna, Jeffrey O’Brien è il vero padre che, non sapendo della gravidanza di Lora, abbondona quest’ultima, ma Enzo e Jeffrey in tutti quegli anni avranno modo di incontrarsi e di “aiutarsi”. Nel 1968, Enzo, grazie al lavoro ottenuto presso l’International School of Florence trasferì la sua famiglia dall’Irlanda a Firenze; Ethna si formò in questa scuola, Lora svolse un lavoro di segretariato presso la stessa e negli anni la famiglia conobbe il rettore e amico Horace Gibson, persona di vastissima cultura e grande umanità che, segnò positivamente, la vita di tutti loro. Ethna, professoressa di musica, compositrice jazz e violoncellista, in quei fatidici sette anni, tra il 1997 e 2004, affronterà zone scure del suo passato, cambiamenti di vita e relazioni ma, soprattutto, comprenderà meglio sé stessa per poter finalmente perdonare e amare.
«Per amare ci vuole solo l’amore, nient’altro, è semplice» pag. 105
La composizione jazz di maggior successo della protagonista è Ethna’s song, Il tema di Ethna, the theme; come la vita è la somma dei giorni vissuti, una composizione è un costruirsi di note su un pentagramma; la base ricorrente della tecnica del jazz è la pulsazione dei giorni che trascorrono, ma sono le virate di improvvisazione swing che, come gli accadimenti della vita, danno valore al tempo e alle scelte prese. Il romanzo scritto da Bertini è un libro dalla trama fitta, ma sempre chiara, in cui i temi famigliari sono approfonditi con il rispetto di ogni punto di vista delle persone coinvolte; ogni personaggio, a suo modo, da un contributo a Ethna sul significato di un legame così inscindibile. L’io narrante della protagonista si mescola a quella coralità discreta dei personaggi di questa storia che colorano e danno profondità alle emotività. In particolare la figura di Horace, realmente esistito – come specifica l’autrice nelle note – da vigore e ritmo; un prezioso tributo che Bertini ci dona per conoscere una persona così eclettica. Gli innesti in lingua inglese nella prosa identificano i personaggi, caratterizzando un linguaggio intimo che ogni famiglia migrante possiede. Qualche dettaglio di contestualizzazione, come i titoli delle canzoni o i piccoli e grandi fatti storici, aiutano a calare il lettore nella temporalità degli eventi distribuiti nei sette anni. Nel romanzo si possono cogliere anche riferimenti artistici, l’autrice cita la corrente dei Macchiaioli e ovviamente la musica che, come un personaggio, ricopre un ruolo determinante nella narrazione.
«Amo la “macchia”, mi fa pensare al jazz: devi conoscere molto bene la tradizione e le sue regole, per decostruire e improvvisare» pag. 17
Per l’autrice la bellezza, non solo in canoni artistici ma nella vita, è armonia ed è armonico vedere il crescere interiore di Ethna che, grazie e attraverso le sue stonature disarmoniche, compone, infine, il suo tema completo di amore.
Caterina Incerti
La recensione su Exlibris 20
LA BELLA VIRTU’ : L’ULTIMO LIBRO DI MARISA SALABELLE, ORIGINI SARDE, DA SESSANT’ANNI A PISTOIA
Marisa Salabelle torna in libreria con il seguito de Gli ingranaggi dei ricordi, romanzo pubblicato da Arkadia nel 2020; la medesima casa editrice pubblica oggi La bella virtù, in cui ritroviamo Felice e Maria Ausilia, già conosciuti nel romanzo precedente, all’epoca della loro gioventù e dell’incontro alla fine della seconda guerra mondiale. In questo nuovo romanzo le voci narranti dei due coniugi, ormai anziani, si alternano a quella della figlia Carla, ricostruendo il passato e narrando il presente, fino a comporre un variegato, interessante ritratto di famiglia. Carla, figlia di Felice Dubois e Maria Ausilia Zedda, unica persona che si prende cura degli ormai anziani genitori, racconta la malattia del padre, colpito da un tumore al pancreas all’età di ottantacinque anni, quando lei non era ancora pronta a perderlo: “Era l’uomo che amavo, l’uomo della mia vita. Certo, avevo mio marito e mio figlio, e amavo moltissimo anche loro, ma con mio padre non c’era gara. E dire che non era neanche particolarmente amabile: non importa. Mi bastava vederlo là, sulla sua poltrona, le mani piene di macchie, il viso ancora bello, il neo in rilievo sotto l’occhio destro che era diventato un’escrescenza un po’ ripugnante, le labbra sottili, la sigaretta in mano, per sentirmi stringere il cuore”. Il rapporto tra Felice e Maria Ausilia è sempre stato vivace, appassionato e conflittuale. Carla parla dei suoi genitori con obiettività, riconoscendone pregi e difetti. Alle tre voci adulte si aggiunge quella di Kevin, figlio di Carla, che si appresta a conseguire la laurea magistrale con una tesi in una materia storica. La madre è riuscita a convincerlo, ai tempi della laurea triennale, a scrivere una tesi sul prozio partigiano, Silvio Serra; adesso gli suggerisce di approfondire un’altra questione che le sta a cuore, la parentela tra il nonno Felice e san Giuseppe Moscati.
I tre filoni narrativi ‒ la malattia di Felice, i ricordi dei due anziani coniugi, la ricerca di Kevin ‒ scorrono alternandosi da un capitolo all’altro. Sul passato, sulla maturazione di Felice e Maria Ausilia, innamoratisi quando erano due adolescenti, si concentra in particolare Maria Ausilia.
Felice si sofferma spesso, amareggiato, sugli aspetti più miserevoli del presente, sulla malattia che erode le sue forze e la sua autonomia; a tratti indulge alla rievocazione dei tempi andati e al rimpianto di ciò che è stato e non è più. Carla rievoca con nostalgia la giovinezza e il rapporto intenso con un padre ancora forte, in grado di essere per lei una guida. L’arco della narrazione, con il suo andirivieni dal presente al passato e di nuovo al presente, abbraccia una sessantina d’anni. Attraverso le storie di famiglia, che ciascuna delle voci narranti descrive dal suo peculiare punto di vista, vediamo in controluce l’evoluzione, di decennio in decennio, dei rapporti fra uomini e donne, con la graduale conquista, da parte di queste ultime, di un ruolo sociale che supera gli angusti limiti dell’accudimento familiare. Uno dei pregi maggiori del romanzo è la caratterizzazione dei personaggi, sfaccettati e quindi veri, soprattutto Felice e Maria Ausilia: li vediamo alle prese con le pesanti contraddizioni fra la loro natura, le emozioni e i desideri da un lato, i retaggi dell’educazione dall’altro: l’uno per la formazione cattolica e i condizionamenti del suo mentore, il salesiano don Angioni, che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita, soprattutto durante gli anni difficili della crescita; l’altra perché le va da sempre stretta la concezione del ruolo femminile trasmessa dalla famiglia e diffusa nella società quando lei era una ragazzina e poi una giovane donna; assai poco, inoltre, Maria Ausilia si entusiasma alla fervente religiosità del marito, con il suo corollario di preghiere e rosari. Il pensiero di Felice sul ruolo femminile non potrebbe essere più arcaico; alla donna si richiede di essere “docile e mite” e lui è consapevole che la sua “cara moglie” (come spesso dice parlando di lei o rivolgendosi a lei) è l’esatto contrario dell’ideale di donna sottomessa e subalterna. E non si rende conto che anche i suoi principi sull’educazione dei figli sono superati, inadeguati, improntati a una severità irragionevole e condizionati dal suo bigottismo. Mentre la vita di Felice volge al termine, fra rievocazioni del passato nostalgiche con punte a volte ironiche e sfoghi accorati sulla perdita dell’autonomia che avanza a grandi passi, Kevin è alle prese con la ricerca che svolge per la sua tesi, un po’ svogliatamente all’inizio, poi sempre più incuriosito, muovendosi con difficoltà tra le ramificazioni degli alberi genealogici di ben tre casati. Fino a quando, da una vecchia foto e da un’intuizione della sua ragazza, Marghe, salta fuori il dettaglio illuminante che lo aiuterà a risolvere un piccolo mistero di famiglia e a concludere la stesura dell’elaborato.
La scrittura cristallina di Marisa Salabelle ci regala una bella storia familiare sullo sfondo della Storia travagliata del Novecento italiano. Seguito de “Gli ingranaggi dei ricordi”, in queste pagine ritornano i giovani Felice e Maria Ausilia nel periodo del loro fidanzamento e poi del lungo matrimonio. Mentre la figlia Carla rievoca la malattia e la morte del padre, Kevin, suo figlio, studente universitario, dedica la propria tesi magistrale alle vicende della famiglia del nonno materno, ricostruendo intrecci tra casate più o meno nobili del napoletano e dell’avellinese e indagando sul legame di parentela tra il nonno Felice e il santo Giuseppe Moscati. In questa nuova puntata di una saga famigliare che si dipana nel periodo tra il dopoguerra e i giorni nostri, attraverso plurime voci narranti, conosceremo sempre più a fondo i personaggi di questo potente e sapiente affresco. Felice, giovane intelligente e volitivo ma dal carattere aspro; Maria Ausilia, che si rivela una ragazza e poi una donna molto determinata, con un sentimento ambivalente verso il fidanzato e poi marito, che ama ma con il quale ha un rapporto conflittuale. E poi Carla, molto legata al padre, del quale tuttavia non ignora i limiti e che segue con grande pietas durante la sua malattia. Infine Kevin, studente un po’ riluttante e scettico, ma impegnato con successo nel ricostruire la storia famigliare. Ancora una volta Marisa Salabelle riesce a costruire un’epopea di affetti affascinante e ricca di profondità.
Marisa Salabelle è nata a Cagliari nel 1955, vive a Pistoia dal 1965. Laureata in Storia all’Università di Firenze, ha frequentato il triennio di studi teologici presso il Seminario arcivescovile della stessa città. Dal 1978 al 2016 ha insegnato nella scuola italiana. Nel 2015 ha esordito con il romanzo L’estate che ammazzarono Efisia Caddozzu (Piemme), seguito nel 2019 da L’ultimo dei Santi (Tarka) e nel 2022 dal giallo Il ferro da calza (Tarka). I primi due romanzi sono stati finalisti al Premio letterario La Provincia in Giallo, rispettivamente nel 2016 e nel 2020. Con Arkadia Editore ha pubblicato la saga famigliare Gli ingranaggi dei ricordi (2020) e La scrittrice obesa (2022).
Rosalia Messina
La recensione su Tottus in Pari