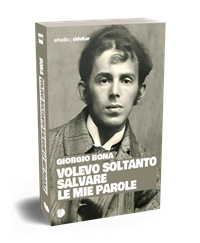Massimiliano Scudeletti, abusi sui minori e abissi della Rete
Sogni e flashback si mescolano alla narrazione del presente ne “La laguna del disincanto” di Massimiliano Scudeletti. Un ex videoreporter di guerra indaga un piano ben congegnato, ma votato al male e all’orrore, specie nel web contro i più piccoli… Il fenomeno delle violenze e degli abusi sui minori è un problema complesso, caratterizzato da una pluralità di sfaccettature, per affrontare il quale sono necessari un esame accurato e un approccio complessivo, che prendano le mosse da un’effettiva conoscenza del fenomeno, nelle sue dimensioni e nelle sue tendenze evolutive. Nel primo semestre del 2024, quindi nel solo periodo compreso tra gennaio e giugno, in Italia sono stati registrati 20.502 reati commessi ai danni di minori. Si rileva, inoltre, un sensibile aumento di alcuni reati in particolare: abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, maltrattamento contro familiari e conviventi, sottrazione di persone incapaci, violenza sessuale di gruppo. Dalla disamina dei dati emerge che, anche tra i minori, sono soprattutto i giovanissimi infra-quattordicenni quelli che continuano a veder minacciato il proprio sviluppo psico-fisico dagli odiosi reati in argomento. Sono delitti che intaccano profondamente la sfera emotiva e psicologica, con ovvie conseguenze dannose a breve, medio e lungo termine non solo sulla personalità dell’abusato, ma anche sull’intero sistema relazionale e sociale con il quale il soggetto si troverà a interagire. Un ulteriore conseguenza a lungo termine, frequentemente riscontrata, riguarda la reiterazione dei comportamenti violenti, osservati durante l’infanzia, nelle relazioni vissute in età adulta. Il minore, quindi, potrebbe tendere a subire simili violenze anche nelle relazioni future, ovvero a metterle in atto, interpretando il ruolo di carnefice. Gli episodi di violenza sono perpetrati sui minori prevalentemente da parte di uomini italiani, di età compresa tra i 35 e i 64 anni (63% dei casi) e per il restante 37% da parte di stranieri. Si tratta di dati ricorrenti negli ultimi anni, che individuano soprattutto negli uomini, con requisiti anagrafici abbastanza definiti, i soggetti verosimilmente più intrisi di quella “sottocultura” che affonda le proprie radici nell’ignoranza, nella negazione della ragione, e che traduce la paura del confronto nella violenza, fisica e psicologica, riproponendo modelli passati, che si credevano ormai superati.
Nel mirino di chi dovrebbe proteggere
Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza dell’esistenza di fenomeni di maltrattamento, sfruttamento sessuale e abuso a danno di minorenni, effettuati da persone appartenenti a organizzazioni umanitarie, associazioni, istituzioni religiose, scuole e quindi in posizione fiduciaria e autorevole. La scuola è un’istituzione educativa dove il principio universalmente riconosciuto del “non fare alcun male” (do not harm) dovrebbe raggiungere la sua massima espressione; pertanto ha la precisa responsabilità sia di minimizzare il rischio di nuocere ai bambini e agli adolescenti ai quali si rivolge, sia di saper rispondere efficacemente in caso di preoccupazioni e sospetti. E, in generale, ciò avviene. Fortunatamente. Ma i casi di cronaca che raccontano il contrario, purtroppo, aprono una dolorosa feritoia su rischi a volte troppo sottovalutati. Ne La laguna del disincanto (272 pagine, 17 euro), edito da Arkadia, Massimiliano Scudeletti sceglie di indagare proprio questo aspetto della violenza sui minori, facendolo diventare la colonna portante dell’intero libro. Il protagonista Alessandro Onofri, ex videoreporter di guerra, viene chiamato in causa dall’amica Sarah la quale è preoccupata per il particolare e apparentemente inspiegabile comportamento dei figli. Quello che scopre lo porta a indagare più a fondo di quella che sembra sempre più una ramificazione strutturata di un piano ben congegnato, ma votato al male e all’orrore. Un male e un orrore che sono già entrati nella vita di Onofri, un tormento della sua esistenza che egli ora rivive tra sogni e flashback che si mescolano alla narrazione degli accadimenti recenti.
Più persone e più luoghi
L’indagine sembra ingrandirsi sempre più coinvolgendo persone che si trovano anche in luoghi fisici distanti fra loro e collegando punti oscuri sulla rete del mondo sommerso del Deep web. Il Deep web è costituito dall’insieme di tutti i contenuti presenti sulla rete che non sono indicizzati dai motori di ricerca. Le risorse web sommerse rappresentano il 96% dell’intero world wide web, per un volume 500 volte superiore a quello del Surface web. Il Dark web è un sottoinsieme del Deep web, a cui è possibile accedere solo tramite particolari software, poiché si basa su tipologie di reti sovrapposte alla rete internet tradizionale, individuate generalmente con il nome di Darknet. Il Dark web racchiude al suo interno un insieme di contenuti accessibili pubblicamente, ospitati in particolari siti web dall’indirizzo IP nascosto (la navigazione è quindi anonima), o contenuti privati scambiati in un network chiuso di computer. Il lato oscuro della rete è composto principalmente da attività di natura illecita. Negli abissi della rete si nasconde l’illecito e con esso, molto spesso, il male. Il medesimo indagato a fondo da Massimiliano Scudeletti il quale, ne La laguna del disincanto, sembra invitare il lettore a una profonda riflessione su quanto sta accadendo oggi, su dove si nasconde il male e su quanto esso può moltiplicarsi all’infinito pur rimanendo pressoché invisibile.
Uno scenario allarmante
Possibile che la progressione tecnologica e digitale invece di “portare avanti” anche la cultura e la conoscenza si trascini antichi rituali e credenze che sembrano riportare tutti indietro di millenni? L’uomo è “un animale cerimoniale”. Allora ogni tentativo di spiegare il rituale come forma di vita cerimoniale non può ignorare questo fatto: che il rituale, come forma di un rito, si connette sempre in modo problematico e un atto – magico, miracoloso, politico, spirituale, o altro – che si presume efficace. I rituali sono anche un efficace metodo di condizionamento mentale, uno strumento per fare proselitismo e indottrinamento. La mente umana è facilmente influenzabile. Quella di un minore lo è anche di più di quella di un adulto. La manipolazione mentale agisce su processi, strutture e sistemi che garantiscono a un individuo il senso di unicità e continuità nel tempo e danno stabilità alla relazione con il sé e con l’ambiente, minando la sua volontà e riducendo il suo senso critico. Occorre creare un canale privilegiato di comunicazione che veicoli le informazioni distorsive nella mente del manipolato in modo tale che queste vengano accolte acriticamente e inserite nella narrativa personale, sostituendo quella autentica, entrando così a far parte della sua identità. Fatto già di per sé grave ma che acquista connotazioni ancor più inquietanti allorquando il “manipolato” è una persona sotto la cui responsabilità si trovano dei minori. Uno scenario allarmante su cui il libro di Massimiliano Scudeletti accende i riflettori.
Irma Loredana Galgano
La recensione su LuciaLibri