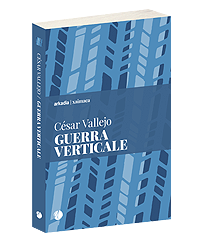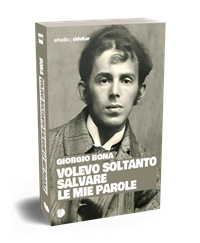Lo Scaffale di Andrea: Sin rumbo
Rotte senza destino, rotte senza destinazione
Recensione al libro di Eugenio Cambaceres
“Sin rumbo”
“Los squires ingleses silbaban para llamar a sus sabuesos, y algunos personajes dickensianos silbaban para conseguir un cab. En quanto a la literatura argentina silbaba poco, lo que era una verguenza. Por eso aunque Oliveira no habìa leìdo a Cambaceres, tenìa a considerarlo como un maestro nada màs por sus titulos, a veces imaginaba una continuaciòn en la que el silbido se iba adentrando en la Argentina visible e invisible…”
“Gli squires inglesi fischiavano per chiamare i loro segugi e alcuni personaggi di Dickens fischiavano per ottenere un cab. In quanto alla letteratura argentina (Oliveira) fischiava poco, una vera vergogna. E così, per quanto non avesse letto Cambaceres, Oliveira tendeva a considerarlo un maestro più che altro per certi titoli e qualche volta ne immaginava il seguito in cui il fischio si insinuava poco a poco nell’Argentina visibile e invisibile…” (Cortàzar, J: “Rayuela”. Catedra. Letras Ispanicas. Madrid 2003. Pag. 389. La traduzione italiana è di Flaviarosa Nicoletti. Rossini. Einaudi. 2015. Pag.245).
Non è un caso che il nome di Eugenio Cambaceres compaia in uno dei romanzi più importanti e complessi di Julio Cortàzar e non è un caso che compaia il fischio. Sia la prima opera di Cambaceres, pubblicata nel 1882, “Potpourri”, sia la seconda, pubblicata nel 1884, “Musica sentimental” avevano come sottotitolo “Silbidos de un vago”, “Fischi di un pigro”. Del resto Cortàzar cita ancora Cambaceres nel brevissimo capitolo 153 di “Rayuela” (Pag. 733 dell’edizione originale). Aggiungo che nel romanzo più importante di Cambaceres “Sin Rumbo”, pubblicato nel 1885, questo sottotitolo scompare.
Dunque il fischio. Quel fischio di Horacio Oliveira, eterno studente e infaticabile flaneur a Parigi, quel fischio che rende omaggio a un autore considerato un maestro sebbene non letto. Quel fischio di un autore che darà vita a personaggi che molto ricorderanno il flaneur Oliveira, quell’autore a cui gli scrittori argentini del Novecento dovranno, davvero, molto.
Ma chi era Eugenio Cambaceres? Era il figlio di un chimico francese che si era stabilito in Argentina nel 1829. Nacque a Buenos Aires nel 1843. Fu uomo politico, deputato, segretario e vicepresidente del Club del Progreso. Nel 1876 ebbe una relazione con la cantante lirica Emma Wizjiak, relazione che sfociò in uno scandalo. Viaggiò spesso in Francia dove ebbe un’altra relazione con un’altra cantante lirica, Luisa Bacichi, che sposò nel 1887 e da cui ebbe una figlia, Rufina. Morì di tisi a Buenos Aires nel 1888.
Eugenio Cambaceres appartiene a quella che venne chiamata la Generacìon del ochenta, la Generazione dell’ottanta”. Fu una generazione che visse con gli occhi rivolti alla città e al suo sviluppo proprio nel momento in cui Buenos Aires volgeva il suo sguardo all’Europa, alla Francia, In particolare a Parigi, come lo si può constatare dalle trasformazioni urbanistiche, di tipo hausmanniano, che che il sindaco del 1880, Torcuato de Alvear, volle fortemente con l’obiettivo di far diventare Buenos Aires la Parigi del sud. E non è un caso che molti degli uomini politici, degli scrittori, degli intellettuali di quella generazione viaggiassero verso Parigi in un vero e proprio viaggio di iniziazione. Lo fu anche per Cambaceres che venne considerato dal critico letterario Martin Gace Meon -anch’egli appartenente alla generazione dell’ottanta- come il fondatore del romanzo argentino contemporaneo.
In Italia Eugenio Cambaceres è un autore non tradotto e praticamente sconosciuto. Bisogna ringraziare la casa editrice di Cagliari Arkadia -una casa editrice che pubblica libri di grande spessore e non solo di area sarda- per averci fatto conoscere quello che da molti critici, come si è detto più sopra, è considerato il padre del romanzo moderno argentino. E ce lo ha fatto conoscere nel modo migliore possibile con l’ottima cura e l’ottima traduzione di Marino Magliani e Luigi Marfè. Marino Magliani e Luigi Marfè sono anche i curatori, sempre per Arkadia, della collana Xaimaca, una collana interamente dedicata ad autori latinoamericani e che ci riserverà, certamente, altre piacevoli sorprese letterarie di quell’ambito geografico.
“Sin Rumbo”, senza rotta, è un libro da leggere e sul quale meditare.
In breve la trama: Andrés è un uomo molto ricco, possidente terriero e che non dovrebbe avere affanni di sorta. In realtà è abitato dalla noia, da uno spleen baudelairiano che cerca di vincere, dapprima, avendo una relazione con Donata, la figlia di un suo bracciante e che metterà incinta, poi, anche per sfuggire alla sua responsabilità, andandosene a Buenos Aires. Là avrà una relazione con la cantante lirica Amorini (in cui è adombrata la figura di Emma Wizjiak). Ma, ben presto, la passione si trasformerà in noia mortale. Andrés non troverà altra soluzione che quella di tornare nella pampa, nei suoi possedimenti, dove potrà conoscere la figlia Andrea, nata nel frattempo. Cosa altro troverà lascio al lettore scoprirlo.
Cambaceres è stato considerato un seguace del naturalismo di Zola. Di sicuro è così. Ma in “Sin Rumbo” c’è un netto superamento di questa influenza. Vedremo più avanti perché.
Andrés è un uomo senza destino e senza destinazione. Qui è d’obbligo citare il grande filosofo ebreo francese di origini russe Vladimir Jankélévitch. Nel suo libro “L’avventura, la noia, la serietà” (Einaudi. 2018), Jankélévitch distingue con chiarezza destino e destinazione:
“Ciò che viene disposto per l’uomo da parte delle fatalità economiche e sociali, fisiologiche e biologiche, le fatalità materiali, insomma, l’ereditarietà, la stessa infermità, nascere poveri, essere handicappati a causa di una grave malattia, eccetera: ecco cosa fa parte del mio destino… intorno a questo destino, c’è qualcosa di evanescente e maggiormente fluido che lo circonda come un’aura o un alone luminoso a cui diamo il nome femminile di destinazione. La stessa libertà in virtù della quale si modifica la propria sorte è un ingrediente di tale atmosferica destinazione. La destinazione conferisce un significato alle bizzarrie arbitrarie, assurde o sconnesse, che sono invece respinte dal destino” (Pag.25).
Anche se Andrés è un uomo ricco e sembra che questo sia il suo destino, in realtà non ha nulla e se avesse un destino gli volterebbe le spalle, magari deridendolo. Ancora meno ha una destinazione. È un uomo senza rotta, che vaga, che sembra girare a vuoto anche nel momento in cui pare che stia prendendo delle decisioni. È come se le avventure che ha attraversato e sta attraversando non avessero lasciato un segno, neppure una cicatrice che diventi memoria. Tutta passa e se ne va come l’acqua che scorre..Ci sono pagine belle e drammatiche in cui è descritta la sua flanerie per Buenos Aires. È una flanerie molto diversa da quella tratteggiata da Franz Hessel nel suo “L’arte di andare a passeggio” (Elliot. 2011) tra le vie di Parigi. O da quella di Baudelaire. O ancora da quella studiata da Walter Benjamin e che aveva come luoghi privilegiati di analisi Parigi e Berlino.
Quello di Andrés non è un andare a zonzo per la città dove si scoprono casualmente angoli di strade di cui mai ci si era accorti prima, scorci che ci lasciano sorpresi e dove la flanerie implica un sottile piacere. La flanerie di Andrés è una flanerie disperata in cui il tempo è un tempo vuoto e omogeneo, in cui il tempo diventa il tempo della noia, quel tempo così magistralmente descritto da Jankélévitch sempre in “L’avventura, la noia, la serietà” dove tutti i possibili ci sfilano davanti senza che ne scegliamo uno e vanno ad affollare un passato sterile, che non provoca alcun languore a ricordarlo. Per dirla con Jankélévitch la noia
“non è la miseria di una coscienza sottoalimentata, ma al contrario è l’inedia della sazietà” (Pag. 78. Il corsivo è mio).
Andrés cita il suo filosofo preferito, Schopenhauer, a proposito del tempo:
“‘Ci accorgiamo del tempo solo quando ci annoiamo e non quando ci divertiamo. Entrambe le cose dimostrano che la nostra esistenza è tanto più felice quanto meno la sentiamo: ne segue che sarebbe meglio non averla’” (pag.13).
In realtà in Andrés non c’è quel tempo che i greci chiamavano Kairòs, quel tempo dell’istante in cui si decide, in cui si può decidere il senso della vita. E, sempre seguendo Jankélévitch, se noi siamo tempo incarnato, se la nostra patria è il tempo, allora Andrés è un senza patria, uno sradicato, un fuggiasco dalla vita. In questo senso Andrés ci ricorda tanti personaggi di Onetti, tanti di Arlt che vagano senza meta per una Buenos Aires stravolta e iperrealista.
Anche la nostalgia per la pampa che prende Andrés dopo il girovagare disperato per Buenos Aires non è quella nostalgia che, nel presente, può essere un ponte tra il passato e il futuro. È come se quella nostalgia fosse qualcosa di estemporaneo che non si radica dentro all’anima. Il desiderio del ritorno alla pampa e alla sua hacienda è un disperato bisogno di fuga, non è l’approdo di Ulisse ad Itaca. Il suo sarà un approdo molto diverso. Solo nel momento dell’incontro con la figlia Andrea (che ci ricorda aspetti autobiografici, in particolare il rapporto di Cambaceres con la figlia Rufina) parrà risollevarsi ed assumersi la responsabilità di una esistenza. Ma sarà un’assunzione goffa, incerta, che ripeterà il modo in cui la propria madre aveva avuto di prendersi cura di lui quando era bambino in una specie di trasmissione intergenerazionale. Forse l’unico destino possibile sarà questa trasmissione, tanto studiata dagli psicoanalisti, una trasmissione che agisce nell’inconscio di Andrés.
Anche dal punto di vista formale “Sin Rumbo” è un romanzo moderno, ormai proiettato snella letteratura del Novecento. Alla narrazione del narratore onnisciente, di stampo prettamente ottocentesco, si alterna il discorso libero indiretto, il flusso di coscienza, l’onirismo (unico esempio della letteratura argentina dell’epoca) come accade alla fine del capitolo XXVIII:
“E tutto, tutto era menzogna. Non aveva un figlio, non esisteva nessun mostro; il nano, il maiale, il rospo erano chimere, vani deliri della sua mente in momenti di incubo. E sognando alla fine di essere un sogno, smise di sognare e si ritrovò in viaggio, con destinazione l’Europa, a bordo di un vapore, steso tranquillamente nella sua cabina. D’improvviso, pensò che la nave si stesse rovesciando. Di soprassalto si sedette e aprì gli occhi…
La carrozza si era incagliata, immersa fino ai mozzi delle ruote in un vecchio fosso” (Pag. 90-1).
Esiste, poi, uno scarto incolmabile tra il narratore e il protagonista. Anche per tutto questo il “Sin Rumbo” di Cambaceres supera il naturalismo di Zola, ma anche il decadentismo dello Huysmans di “A’ Rebour” e di “A’ vau-l’eau” a cui, spesso, il romanzo di Cambaceres è stato spesso paragonato.
Le descrizioni dei paesaggi sono magistrali come lo è il ritmo che le sostiene. Un esempio:
“Era calata la notte, tiepida, trasparente.
Una nebbia spessa iniziava a salire dalla terra.
Il cielo illuminato di stelle era il lenzuolo di una immensa cascata che si rovesciava a terra e, nel cadere, alzava gli schizzi d’acqua che si frangeva nello schianto” (Pag.13).
Con una conclusione del periodo che ha forte sapore surrealista.
Altre descrizioni fanno venire in mente un montaggio cinematografico dove il quadro, poco a poco, si anima, dove l’aggettivazione è efficace e evocativa e dove acquista una grande importanza la punteggiatura, l’uso sapiente della virgola, del punto e virgola e dell’a capo. Eccone un esempio:
“Nelle osterie, gli ubriachi bruciavano una infinità di fuochi artificiali.
I ragazzi, in cerchio, tenendosi per mano, saltavano gridando.
I cavalli, attaccati agli steccati dei marciapiedi, stanchi, riposavano, liberi dalle capezze e dalle redini.
Di tanto in tanto, un carretto passava sferragliando rumoroso, circondato da nuvole di polvere.
Sul sagrato si riunivano gli uomini. Il giudice di pace, il comandante, il medico, il farmacista, il commissario di polizia, il maestro di scuola, i negozianti, gli impiegati comunali o i personaggi influenti, gli assi del paese stavano tutti in gruppo.
Un poco più in là, con i piedi più in basso, i dipendenti, intorno al telegrafista.
Sul ciglio della strada le ultime carte del mazzo: i mantelli e le camicie formavano un gruppo a parte.
Le donne, gonfie e tronfie, entravano due o tre alla volta” (Pag.23).
A proposito dei ritmi della narrazione. occorre ripeterlo: se noi possiamo gustarli anche in lingua italiana lo dobbiamo all’ottima traduzione di Marino Magliani e di Luigi Marfè.
Non c’è rotta, non c’è destino, non c’è destinazione, non ci sono teologia o teleologia in questo romanzo.
Andrés precorre l’uomo del primo Novecento. Non è solo un uomo decadente, ma anche un uomo senza qualità, ma ben più intriso di nichilismo dell’Ulrich di Musil che è salvato dall’ironia. È anche l’uomo che, non molto tempo dopo, sarà trasformato in scarafaggio. È l’uomo che soccombe alle pulsioni dell’inconscio. Gli faranno compagnia tanti altri personaggi che hanno perduto la rotta e il senso delle loro esistenze e che non sapranno da che parte dirigere le loro vele.
Andrea Cabassi