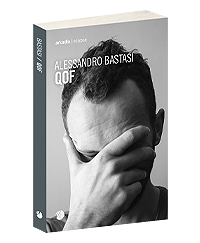Valentina Di Cesare, L’anno che Bartolo decise di morire
L’anno che Bartolo decise di morire nessuno si era accorto di niente, forse perché erano accadute tante cose: Vito e la moglie erano lì lì per lasciarsi, una delle più grandi fabbriche della zona stava per chiudere, Giovanni era tornato in città dopo parecchi mesi, a maggio c’era stata una violenta gelata che aveva compromesso i ciliegi, il Trofeo del Sole non si sarebbe disputato. E poi c’era Lucio. Lucio che aveva perso il lavoro due anni prima ed era più scoraggiato del solito, tanto che lo stesso Bartolo, preoccupato per lui, aveva deciso di parlarne con gli amici di sempre. Con Vito, con Renzo, con Giovanni, affinché tutti insieme si cercasse un modo per aiutarlo. E insomma, di cose quell’anno ne erano successe tante, al punto che, « a ripensarci adesso, viene quasi da chiedersi come mai fossero passate in sordina» e perché nessuno si era accorto di Bartolo, di cosa gli stava succedendo dentro, sebbene «qualche segnale qualcuno lo aveva notato: solo un po’ di stanchezza negli occhi, lo sguardo inargentato di luna calante, il sorriso un battito in ritardo rispetto agli altri, e poi un’inquietudine lenta, serpentina, trasmessa dagli occhi alle ossa e al respiro, un’ondulazione iterata del pensiero, una specie di aritmia esistenziale».
Leggere L’anno che Bartolo decise di morire, di Valentina Di Cesare, pubblicato da Arkadia Editore, significa chiedersi cosa vuol dire crescere e diventare adulti – quand’è che siamo diventati adulti? – perché potrebbe sembrare che niente di ciò che accade ci cambi veramente. Potrebbe sembrare che la vita sia “un intervallo continuo”, quando invece ogni cambiamento ci attraversa “come il rivolo che scanala le pietre” e quando ce ne accorgiamo è ormai troppo tardi. Per noi stessi e per le persone che ci sono vicine e che forse non ci conoscono, non del tutto, non in profondità. È ciò che accade a Bartolo e a Lucio e a tutti i personaggi di questo romanzo che sono cresciuti insieme, che insieme sono diventati grandi con l’illusione però di essere rimasti sempre gli stessi di quando erano bambini. Perché c’è chi riesce a vivere per sempre in questa illusione e chi no. E chi non ci riesce è perché avverte il dolore del mondo, e presta ascolto alle parole degli altri, perché se non ascoltasse le parole degli altri, non ascolterebbe neanche le sue.
L’anno che Bartolo decise di morire è ambientato in una città imprecisata e in un periodo storico indefinito. Questa indeterminatezza non è limite ma sostanza. Permette infatti di ritrarre un mondo immutabile quando invece il tempo scorre e produce strappi, lacerazioni, ferite insanabili. È come in una danza dove sembra che i movimenti siano sempre identici. I capitoli che si aprono con la ripetizione della frase del titolo, «L’anno che Bartolo decise di morire», mimano questa danza i cui movimenti appaiono identici e invece sono ogni volta più ampi, articolati, estesi, colmi di dolore, tragici, irreparabili: perché sono la conseguenza dei movimenti precedenti e li contengono tutti, gli errori compiuti, anche, e le parole non dette, i gesti taciuti e il senso di colpa che poi ci attanaglia. Perché se avessimo prestato abbastanza attenzione a quando ogni cosa è cominciata, fin dall’inizio, fin dal primo singolo passo che pure era innocente e puro e semplice, avremmo intuito come davanti a esso si profilasse invece l’ombra minacciosa del tempo che trasforma la fanciullezza in adolescenza e l’adolescenza nell’età adulta e poi in quella della maturità. Senza scampo. Senza possibilità alcuna di spezzarla, questa catena della vita che siamo.
In sintesi – e sempre ammesso che poi Bartolo muoia davvero e se tutto Bartolo o soltanto una parte di lui e quale – si potrebbe dire che l’anno in cui Bartolo decise di morire ogni cosa era in verità già cominciata ad accadere. Da prima, da anni, da lungo tempo: e se non da sempre, di certo dal momento in cui egli era venuto al mondo.
«L’anno che Bartolo decise di morire, nessuno si era accorto di niente. Parenti, amici e conoscenti non avevano sospettato nulla di quel che stava per accadere. Ogni cosa era uguale a sempre: l’estate era finita, l’azzurro del cielo si affievoliva e il sole di settembre aveva ripreso a tergiversare dietro gli alberi e le antenne della piccola città. Il vento a volte si alzava già rapido al mattino, muoveva le foglie e i rami con rumore di ventagli, e trasportava via le fronde delle piante sui balconi. Al primo accumulo di nubi, gli uccelli volavano bassi, come impauriti, sdrucendo l’orizzonte per mettersi al riparo sotto i tetti, mentre l’odore della pioggia si era già sprigionato e, in un momento, le prime gocce battevano sui vetri e le ringhiere stinte.»
Valentina Di Cesare è nata a Sulmona ed è cresciuta a Castel di Ieri, in provincia dell’Aquila. È insegnante di lettere alle scuole medie e giornalista culturale. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo romanzo Marta la sarta (Tabula Fati) mentre nel 2017 è uscito, per Urban Apnea Edizioni di Palermo, un suo racconto lungo intitolato Le strane combinazioni che fa il tempo.
Gianluca Minotti