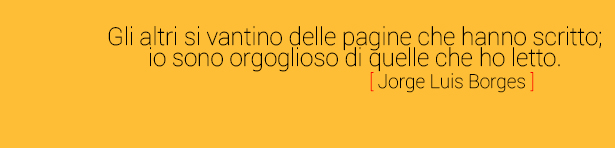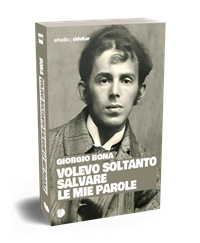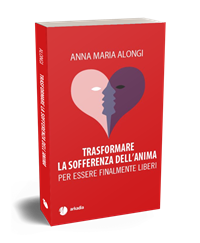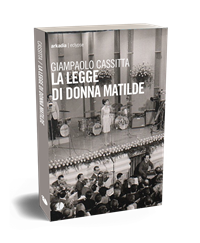L’OMBRA DI KAFKA di Andrea Alba (Arkadia)
Andrea Alba racconta, nel romanzo L’ombra di Kafka, di recente edito da Arkadia, una storia di formazione ambientata a Roma, in un piccolo appartamento nel quale vivono, sognano, maturano tre coinquilini, Fabio, Giulia, Cristina. I tre giovani formano un triangolo non convenzionale; le alleanze, le attrazioni, l’eros che circola fra loro sono quelli dell’età più avventurosa della vita. L’età della scoperta di sé e degli altri, delle infinite possibilità di relazionarsi con il prossimo. Età di scelte, di grandi interrogativi: chi voglio essere, chi sono, chi vogliono che io sia gli altri (famiglia, amici)?
Tre personalità differenti, tre ragazzi aspettative diverse, tre percorsi che camminano paralleli a volte, divergenti altre volte, per intrecciarsi e intersecarsi in alcuni punti nodali.
Il personaggio maschile, Fabio, che a un certo punto si scuote dalla sua letargia e trova lavoro in una videoteca, è ossessionato dal millennium bug. Cosa sarà esattamente? Si chiede. Come funzionerà? Cosa succederà nel mondo già dominato dalla tecnologia digitale?
Fino a un certo punto la narrazione abbraccia simultaneamente le vite dei tre coinquilini, soffermandosi sulle relazioni fra loro e aprendo spiragli sul mondo esterno all’appartamento che condividono: le rispettive famiglie, il relatore della tesi di Cristina, un giovane studioso – l’ambiguo Daniele – di cui Cristina si innamora. Dalla metà in poi, all’incirca, fa la sua comparsa Kafka.
Cosa c’entra Kafka? Cristina, laureanda, sta scrivendo la sua tesi proprio sull’autore boemo e sulle sue opere e, durante il lavoro di ricerca necessario, si imbatte in un mistero che la incuriosisce. Si appassiona alla questione delle prime traduzioni di Kafka in italiano: ciò che scopre la scombussola e cambia la sua vita.
“Non sapeva che cosa la aspettasse, non aveva idea di cosa potessero nascondere le infinite possibilità di traduzione di Kafka o di qualsiasi altro autore, le sue implicazioni nel reale, la pagina che prepotentemente si fa viva, il perturbante del quotidiano che diventa letteratura e il suo contrario”.
Tra amori che si accendono e svaniscono, rapporti amicali che si rafforzano, sbiadiscono, tornano a fiorire, si insinua una storia di libri, di verità e finzione. La scrittura ha un timbro giovanile, le vicende e i personaggi sono accattivanti. L’indagine su Kafka e sulle traduzioni delle sue opere, inserendosi con naturalezza nella trama, risulta avvincente e forse costituisce la parte più interessante del romanzo:
“Un’opera di Kafka è come una casa che ha molteplici porte, finestre, ingressi, balconi. Ma la complessità maggiore non è districarsi tra questa moltitudine di vie di fuga, quanto comprenderne le leggi che la regolano, le ragioni per cui entrare da un punto x ci conduca a y. Forse serve un architetto, più che un traduttore. E che cosa sia una traduzione nessuno lo sa con precisione e infatti non è nostro obiettivo tentare di stabilirlo qui e ora con assoluta certezza. Anzi, che il concetto di traduzione rimanga quanto più indefinito possibile è tra i nostri obiettivi non celati”.
Le vicende diventano kafkiane e surreali, fino allo scioglimento di tutti gli intrecci che l’autore ha abilmente costruito.
* * *
La scheda del libro: L’ombra di Kafka di Andrea Alba (Arkadia, 2025)
Roma, 1999. Cristina, giovane laureanda in Lingue, lavora a una tesi sulle opere di Kafka e le sue traduzioni italiane, ma la ricerca prende una piega inaspettata quando scopre un’edizione apocrifa de La metamorfosi, firmata da un misterioso traduttore. Seguendo le tracce dell’enigmatico curatore, Cristina scopre che è un falsario, autore di una lunga serie di inganni editoriali. La rivelazione manda in frantumi la sua tesi e la sua autostima. Inizia così per Cristina un viaggio che non solo mette in discussione le sue convinzioni, ma la costringe a riflettere sulla verità e sull’autenticità delle storie che raccontiamo, su chi decide cosa sia reale e su come la finzione possa talvolta prendere il posto della realtà. Quando tutto sembra ormai perduto, una sorpresa arriva all’alba del nuovo millennio.
Rosalia Messina
La recensione su Letteratitudine News