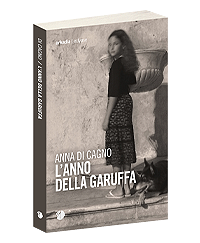VALERIA ANCIONE PRESENTA IL LIBRO “E ADESSO DORMI”: “UN RACCONTO DI VITA SU MATERNITÀ E DISABILITÀ”
La scrittrice e giornalista siciliana Valeria Ancione ha parlato del suo ultimo romanzo a Be Sicily Mag in occasione dell’ultima presentazione presso il Palazzo dei Leoni, a Messina
“Fieramente palermitana, ma altrettanto fieramente cresciuta a Messina”. Valeria Ancione vive da anni a Roma, dove è anche giornalista del Corriere dello Sport, ma non ha mai perso il suo forte legame con la Sicilia, come dimostrato anche dall’ambientazione messinese del romanzo “Il resto di Sara”, uscito nel 2022 per Arkadia editore. La sua ultima opera, “E adesso dormi”, è invece ambientata a Roma, sua città di adozione. Venerdì 24 maggio il libro è stato presentato presso il Salone degli Specchi del Palazzo dei Leoni di Messina. All’evento ha partecipato anche un gruppo di studenti del liceo scientifico Seguenza di Messina, che ha avuto l’opportunità di ascoltare e dialogare con l’autrice, ponendo particolare attenzione ad uno dei temi del romanzo, quello della violenza sulle donne.
“E adesso dormi” di Valeria Ancione: la storia di Gina
Il libro, edito da Arkadia nel 2023, inizia a prendere forma, nella mente e attraverso la penna della sua autrice, già nel 2015, subito dopo l’esordio con “La dittatura dell’inverno”. “Convinta che non fosse il suo momento”, Valeria Ancione lo aveva messo da parte, concedendosi il tempo per approfondire e riflettere. A dare il via alla storia è la scomparsa di Raffaele, marito violento della protagonista che verrà presto ritrovato morto. Al centro c’è lei, l’americana Geena Castillo, che a Roma è diventata Gina e che del giorno della scomparsa non ricorda molto. Il suo percorso verso la scoperta della verità si compone quindi di alti e bassi, dubbi e mistero. Con un’infanzia complicata e un matrimonio infelice e violento, in un momento così delicato Gina trae la sua forza dall’amore per il piccolo Jonathan, “la cui grave disabilità è la cosa più normale nella vita di Geena” e dall’amicizia di Lola e Mara, la cui vicinanza si dimostrerà fondamentale.
L’intervista di Valeria Ancione a BE SicilyMag
A BE Sicily Mag, Valeria Ancione ha parlato di “E adesso dormi” partendo da quello che è stato il punto d’avvio della sua storia, la volontà di raccontare un rapporto speciale e potente come quello tra Gina e il figlio Jonathan. “È anche un libro sulla maternità, a prescindere dalla disabilità di Jonathan”. Una maternità che viene descritta nella sua quotidianità: “Quello che volevo raccontare – ha spiegato infatti la scrittrice – è la normalità della vita di una famiglia in cui c’è un disabile. A volte la diversità la creiamo noi che non la viviamo. Se ci riguardasse tutti, forse la disabilità non esisterebbe”. Da questa scintilla, poi, la storia ha preso altre forme, declinandosi in mistero, introspezione e racconto della potenza dell’amicizia. “Il mistero era un’idea utile alla storia per raccontare la fine di un periodo della vita di Gina, che è stato di violenza. Non è il tema del romanzo ma è ciò che lascia in sospeso. Rappresenta la difficoltà di riconoscere certe scelte importanti della propria vita, quelle di Gina, ma anche di Lola e di Mara, che sono le amiche e che rappresentano una parte fondamentale nella risoluzione del problema, nel vivere questa attesa, prima di sapere come è morto il marito”. Quello della scelta è un tema ricorrente per la scrittrice siciliana. “Trovarsi di fronte a una scelta significa avviarsi verso un cambiamento e a volte il cambiamento fa paura. È un argomento che mi sta molto a cuore perché avere il coraggio di affrontare le verità è il sale della vita”. A proposito dei temi più delicati del romanzo, invece, la scrittrice ci tiene a precisare: “Il mio è un romanzo e non vuole essere un trattato sulla disabilità o sulla violenza, ma soltanto un racconto di vita”.
Non solo “E adesso dormi”, le storie di Valeria Ancione che rinascono come audiolibri
“E adesso dormi” sarà presto anche audiolibro. Com’era già successo per “Il resto di Sara” e “La dittatura dell’inverno”, il romanzo prenderà questa nuova forma grazie a Il narratore audiolibri e all’interpretazione dell’attrice e regista palermitana Virginia Alba. “Adoro gli audiolibri, li ascolto sempre mentre cammino”, ha raccontato Ancione. “Li trovo un altro tipo di comunicazione di emozioni, diverso dalla lettura”. La scelta della narratrice non è stata causale. “A proposito di Messina, Virginia Alba ha letto anche “Il resto di Sara” e mi aveva molto impressionato ascoltare i paesaggi che ho descritto. “La dittatura dell’inverno” mi ha impressionato ancora di più perché è un libro in prima persona, quindi a un certo punto Virginia diventa Nina, la protagonista. Sono molto legata a questo libro perché è il mio romanzo di esordio. Nina ed Eva camminano nelle altre mie storie proprio perché non le voglio far morire”. Quello con “La dittatura dell’inverno” è un legame reso ancora più evidente in virtù dell’annuncio della pubblicazione del libro anche in e-book e cartaceo con una nuova copertina, sempre con Il narratore: “Per me è un grande ritorno”, ha concluso.
Giorgia Nunnari
Il link alla recensione e all’intervista su BE SiciyMag: https://tinyurl.com/mr272puj