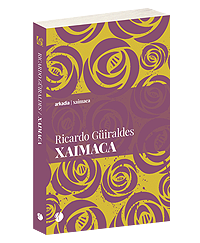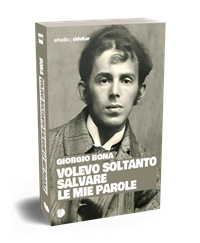Argentina, Italia, Spagna e Olanda: in viaggio con Marino Magliani
Sanremo, agosto 2020
Marino Magliani (Dolcedo, 1960) è uno scrittore e traduttore ligure. Collabora con varie case editrici, tra le quali Exorma, per la quale ha tradotto Sudeste di Haroldo Conti, Miraggi, Amos, Nutrimenti, Del Vecchio e Il canneto editore. Traduce per Arkadia dove cura la collana di letteratura ispanoamericana, Xaimaca-Jarama, con Alessandro Gianetti e Luigi Marfé. Ha tradotto anche con Riccardo Ferrazzi, Giovanni Agnoloni e Alberto Prunetti. Cura inoltre la collana Appennica per Tarka.
Siamo «nella Liguria costiera, dei palmizi e dei cartelloni pubblicitari». In Prima che te lo dicano altri (Chiarelettere, 2018), il protagonista, Raul Porti, dice: «Tutto quello che vedi da Dolcedo, Ripalta, Asinelli e Isolalunga e fin qui e poi fin giù al mare, un giorno sarà una scalinata di case». Appare chiaro un riferimento alla speculazione edilizia, a quelle “selve di cemento” che, come diceva Biamonti, «fanno male agli occhi». Qual è stata la sua percezione della Liguria costiera da bambino, poi crescendo e tornando?
Mi identifico molto con ciò che Italo Calvino scrive in quello che per me è un libro fondamentale: La strada di San Giovanni. Il padre, Mario Calvino, noto botanico, e al contempo contadino, cercava di portarlo con sé nella campagna di San Giovanni. Lo stesso faceva mio padre. Provengo da una Liguria non costiera come quella di Calvino, ma da un profondo fondovalle, una terra dove il mare davvero non c’è. Per cercarlo devi inventarlo o andare sulle pietraie e salire abbastanza. Sono sempre stato abituato a questa negazione del mare: l’ho sempre considerato più dei turisti e dei cittadini che nostro. Ci sono una serie di battute che mi hanno sempre commosso, quelle della gente del mio paese che diceva:
«Sei già andato al mare?»
«Guarda se trovo il costume o i soldi per comprarlo, qualche giorno ci vado».
Loro ci vanno un giorno all’anno, è una goduria, un paesaggio che non si concedono. Mio padre mi portava in campagna e mi diceva: «Marìn bisogna faticare». Io a quel punto ero il ragazzo che preferiva il mare esattamente come Calvino preferiva la parte costiera e luccicante. Ecco quindi che la mia frontiera era davvero quella che Biamonti, o forse Calvino, chiama la separazione fra la Liguria ridanciana e la Liguria sofferente, la Liguria della sofferenza come lavoro, la Liguria muta, aspra, che è quella dell’uliveto. Dal momento che sono figlio di contadini –mia madre era ancora più contadina di mio padre – io ho quindi sempre vissuto il mare come senso di colpa: è ciò che mi sono sempre concesso da ragazzo al posto di quello che avrei dovuto fare, cioè andare in campagna. Mio padre lavorava in un ristorante sulla Costa Azzurra, a Sainte-Maxime, e io andavo con lui d’estate. Il mare per me era più quel mare oltre la frontiera che questo mare e ne parlo nel L’esilio dei moscerini danzanti giapponesi (Exorma, 2017). Questa parola che noi usiamo, frontiera, non l’ho mai capita bene. Non sono di quelli per cui la frontiera è davvero un taglio, ma è una terra pulsante. È una zona che sfuma, così l’Italia può arrivare fino a Mentone e la Francia fino a Bordighera, anche se non ho mai vissuto la frontiera come Biamonti che era della frontiera e che aveva una grande considerazione per la cultura francese…
Biamonti aveva infatti uno sguardo proiettato verso ovest, verso Marsiglia, l’Esterel…
E verso quella luce che lui credeva insuperabile che era la luce della Liguria fino ad Arles, Nîmes, che poi si trasforme in luce africana andando giù verso la Spagna.
Ma la mia Liguria è quella di chi non l’ha vissuta. Io me ne sono sempre andato. Ho passato molto tempo in Spagna e Argentina e ora da trent’anni vivo in Olanda. Solo adesso che ho sessant’anni mi sto accorgendo che davvero non sono più di qua, non lo sono mai stato…Ora più che mai sono considerato uno straniero, un furesto, e questo mi dispiace. Possono dire che non ho combinato niente tutta la vita ma dirmi che non sono di qua è davvero come strapparmi quella specie di identità che al di là di tutto è come un tatuaggio, non la puoi cancellare…
Costiera ligure di Ennio Morlotti
Cosa l’ha portata a evadere, ad andarsene dalla Liguria?
Me ne sono andato via di casa da bambino, ho vissuto molto a lungo in collegio. Uno dei temi de L’esilio dei moscerini è il collegio. Da noi chi aveva le terre lontane andava la mattina a lavorare e tornava la sera a casa: ciò significava non poter star dietro ai figli a scuola. Mia sorella era andata in collegio e non si era trovata bene. Per me è stata, quindi, una sorta di sfida. Ricordo che quando sono andato in collegio, al Col di Nava, avevo una nostalgia tremenda. Ma sapevo che mia madre aveva fatto delle spese, aveva persino messo il numero 66 su tutti i capi della biancheria, e allora mi sono fatto forza e non sono più tornato a casa… Sono uscito dal collegio che avevo 15 anni, mi hanno mandato via per eccesso di tempo. Da Nava ero andato a Mondovì e poi a Roma dove avevo fatta tutta la trafila in prima magistrale… Poi laggiù, grazie a Dio, uno di questi frati mi ha detto: «Guarda non sappiamo se tu sarai un buon padre di famiglia ma sicuramente non sarai un buon frate», anche perché ero un ragazzo, la carne bruciava e si erano resi conto che non sarebbe stata quella la mia strada.
Alla fine dopo essere tornato e dopo aver girato tanto in Spagna e Sud America mi è successo qualcosa che era successo a Gabriel García Márquez: quando ha scoperto i racconti di Kafka ha pensato che se quello era scrivere lui di storie del genere ne aveva tante. La stessa cosa è capitata a me: ho cominciato a leggere, però il mio italiano era molto sporco. Fortunatamente ho conosciuto Gian Giacomo Amoretti, un professore dell’Università di Genova, che è stato molto disponibile. Dopo aver letto le mie cose mi disse che avrei dovuto migliorare la lingua, poiché passavo in continuazione dallo spagnolo all’italiano. Ho dovuto quindi ripossedere/riappropriarmi di una lingua che non mi apparteneva più. Probabilmente la mia prima lingua, l’unica lingua che io abbia mia davvero considerato mia, è stato il dialetto. Sono arrivato in prima elementare che non sapevo una parola di italiano, quindi ho dovuto scrivere molto.
Mi ricordo che quando vivevo in Costa Brava ho tradotto i menu per i ristoranti con un argentino col quale dividevo la casa, che era molto furbo come tutti gli argentini, la viveza criolla.
Era il 1982. L’argentino mi aveva detto: «Marino, senti un po’, se noi traduciamo i menù spagnoli in italiano e poi li vendiamo a tutti i ristoranti, tanto sono gli stessi, cliente per cliente possiamo fare dei soldi: 2000/3000 pesetas o mille più pasti». E in effetti abbiamo fatto un pacco di soldi. È stata la mia più grande impresa con la traduzione.
Quindi il suo primo approccio con la traduzione ha riguardato il cibo, tradurre menù, prima di approdare alla traduzione letteraria…
Sì, poi dopo ho iniziato un po’ a tradurre letteratura. Tradurre non è facile… Pian piano mi hanno assegnato una collana. Non ho mai tradotto per grandi editori, ma per piccole case editrici, seppur di buona qualità, come Amos, Pellegrini, Lo Studiolo, Nutrimenti, Miraggi, Del Vecchio, Arkadia, Quodlibet (Compagnia Extra), Exorma…
Com’è arrivato a tradurre Robert Artl?
Attraverso Adrián Bravi, un autore, mio coetaneo, arrivato dall’Argentina circa trent’anni fa, col quale siamo diventati amici. Lui mi faceva da consulente, mi ha passato tra le altre cose il nome di Haroldo Conti, e mi aveva detto che le Acqueforti di Buenos Aires di Robert Arlt non erano state ancora tradotte. Quindi l’ho tradotto per Del Vecchio con Alberto Prunetti, un autore che si occupa di narrativa sociale, del lavoro.
Il primo libro che ha tradotto?
Ho tradotto per una piccola casa editrice di Treviso (Anordest edizioni) La moglie del colonnello di Carlos Alberto Montaner, un cubano, giornalista dissidente, secondo Cuba un membro della CIA.
Prima avevo comunque tradotto molte altre cose, ma magari andavano in rete o si trattava di cose tecniche. Si dice sempre che la traduzione sia una professione solitaria, ma a me piace dividermi il lavoro, l’ho fatto, dicevo, con Riccardo Ferrazzi, Giovanni Agnoloni, Luigi Marfé, Alberto Prunetti, ma ultimamente è successo con Alessandro Gianetti e succederà con Piero Dal Bon.
«Esule su altre rive», così si definisce Calvino in una lettera a Biamonti. Come si sente in Olanda? Si sente in esilio?
No, in Olanda mi sento a casa anche se non frequento nessuno e forse è per questo che ci sto bene… Lavoro e per il resto ciò che faccio è andare nel bosco due ore al giorno o lungo la riva del mare a camminare. Più che sentirmi esule mi sento quasi un disertore, questa è la mia condizione. Anche perché disertore forse lo sono davvero e un po’ quando sono in Italia mi sento un clandestino. Non che sia un problema ma anche l’Olanda stessa non è che sia la mia patria. L’olandese è una lingua incredibile con la quale non riesco però a comunicare. Gli olandesi stessi non ti capisco se non parli perfettamente la loro lingua. Dal punto di vista del linguaggio l’Italia è la mia terra, da quello della creazione artistica è l’Olanda, solo lì riesco a lavorare.
Ho appena terminato un romanzo dove riesco a scindere le due figure, il traduttore in Olanda, il pellegrino/camminatore solitario e malinconico in Liguria.
Come mai ha scelto il Sud America e nello specifico l’Argentina?
Il Sud America è la mia vita con gli argentini in Spagna, vivevo con loro, lavoravo con loro, ho assorbito la loro cultura e sono ancora in contatto con loro. Dopo la parentesi iberica ho vissuto quasi un anno laggiù, nel 1983 – il colpo di coda della dittatura – nella Pampa a Lincoln e poi a Carlos Paz.
E che mi dice della Costa Brava?
Che era una specie di costa di plastica ed io da quelle parti ero un altro animale, un animale notturno, vivevo sempre d’estate e sempre di notte. Sono cose che lasciano i segni e bei ricordi. Era la fine degli anni ’70 quando sono arrivato e me ne sono andato una decina di anni dopo.
In Prima che te lo dicano altri è ricorrente il tema della luce. Nella parte ambientata in Argentina, ad esempio, si parla di una luce diversa: «la luce della pampa ingannava, esplodeva in un istante e spariva lentamente». Nella parte ambientata in Liguria, si può parlare quasi di un’assenza di luce. Mi viene in mente un Racconto di Calvino, Uomo dei gerbidi, dove è messo in risalto il contrasto tra luce e ombra, ma anche la luce biamontiana, una luce quasi creatrice di confini, in contrasto con le masse d’ombra, e i tramonti “color genziana”. Che ruolo ha la luce nei suoi romanzi?
Io vivo nel fondovalle, in un luogo talmente avaro che non ha neanche concesso un tramonto ai suoi abitanti. C’è il giorno e c’è la notte, è un po’ come la frontiera: o sei di qua o sei di là. Lì allora quella luce è soprattutto l’opaco. C’è il contrasto con quei tramonti lunghissimi e bellissimi che io ricordo dell’Argentina e del Mare del Nord d’estate.
Il link all’intervista su Tre Sequenze: https://bit.ly/35Gk5TY