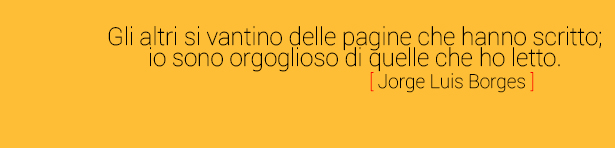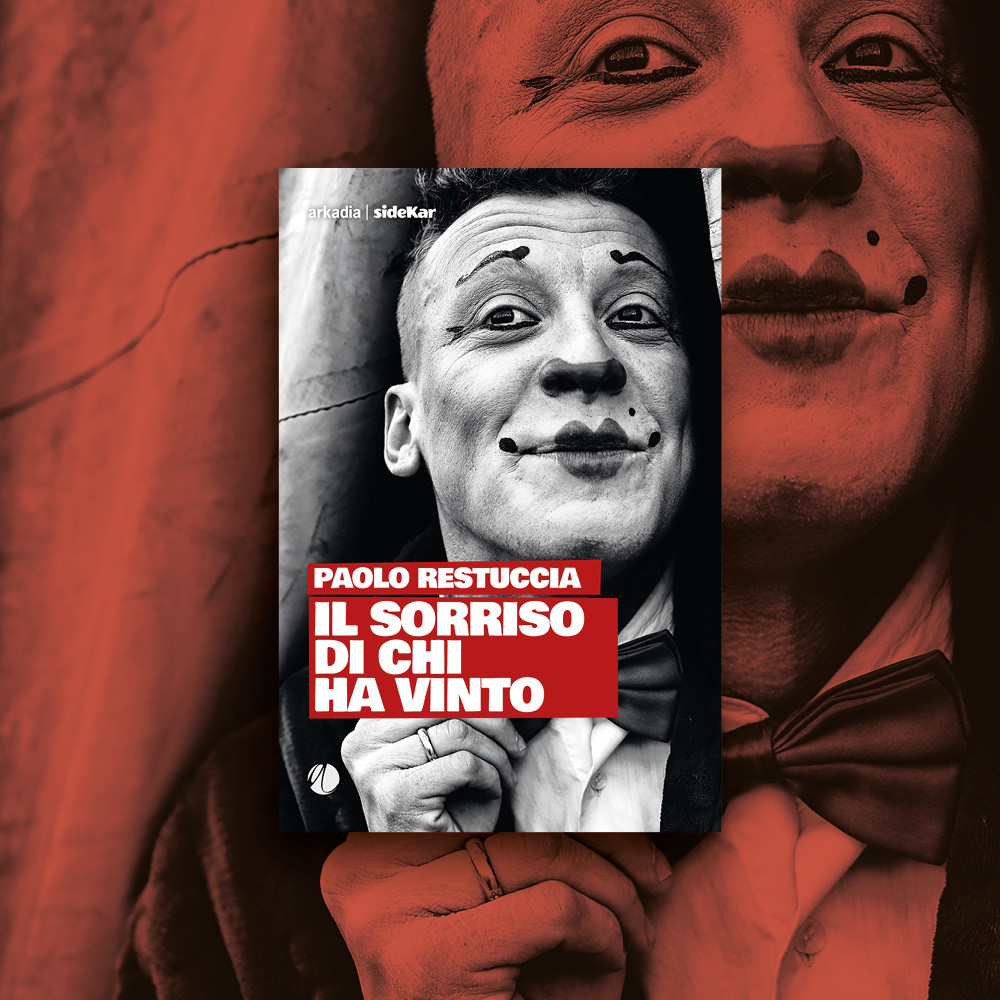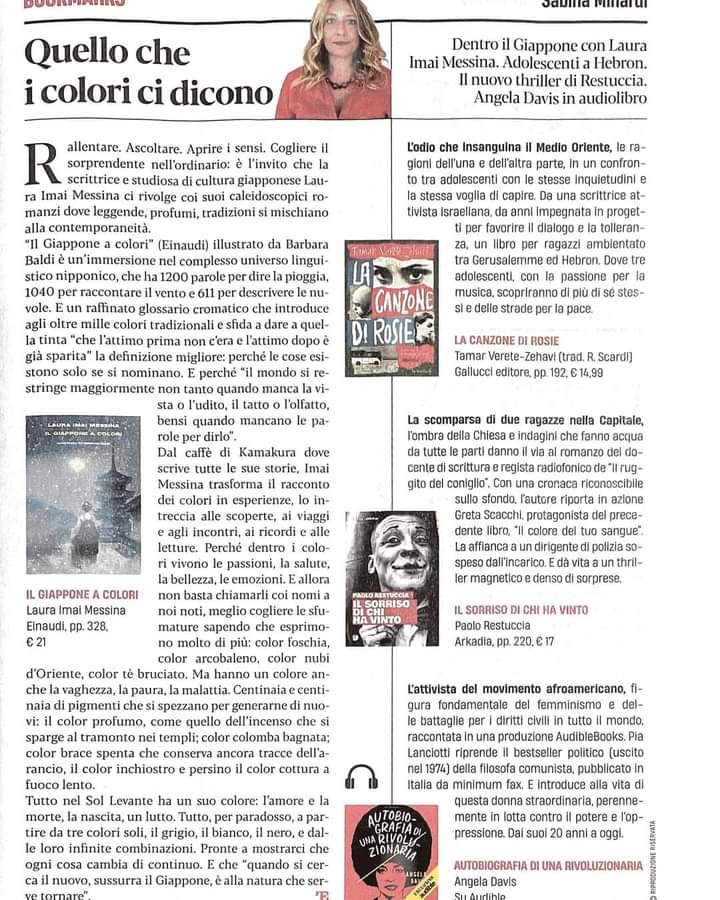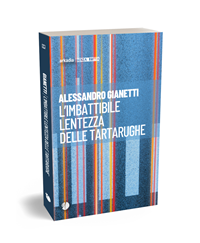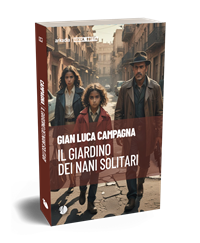SideKar
“Il babbo di Pinocchio” con Paolo Ciampi
Parla l’autore di un libro che racconta l’incontro in una notte fiorentina con un uomo che dice di essere (o forse è) Carlo Lorenzini. Mi chiedo talvolta cosa sarebbe stata la letteratura italiana se invece del Manzoni, o magari insieme ai Promessi Sposi, a scuola avessimo letto per un intero anno Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi, cioè Carlo Lorenzini. Me lo chiedo perché la nostra letteratura, che ancora mi pare moraleggiante e sempre un filino ideologica, sarebbe stata illuminata dall’invenzione fantastica del genio fiorentino che solo apparentemente parla ai “bambini” (certo pure lui moraleggiando, però al contrario). E comunque, la sua fortuna – soprattutto all’estero – sopravanza di gran lunga quasi tutto il resto delle nostre opere letterarie. Basti pensare che in un film sull’intelligenza artificiale del 2001, IA – Intelligenza artificiale, opera sorta in collaborazione involontaria tra Kubrick (deceduto) e Spielberg (regista effettivo), viene citato esplicitamente e offre alla trama la svolta della vicenda. E come dimenticare Pinocchio di Guillermo del Toro che è stata l’ultima – per ora – bellissima rivisitazione dell’opera e del personaggio? E compare anche in un bel romanzo recente tra quelli che abbiamo presentato nel Palazzo del Freddo a Roma, sede della Scuola Genius, Paquito e la Juma di Marco Rinaldi. Così, quando vedo un Pinocchio nuovo tra i libri, lo cerco subito. Quando è uscito Il babbo di Pinocchio di Paolo Ciampi (Arkadia 2023) l’ho letto con gran piacere. Ciampi è un giornalista e scrittore fiorentino che ha scritto una trentina di libri (alcuni candidati allo Strega) e che in questa sua opera immagina lo strano incontro tra un comune cittadino fiorentino e Carlo Lorenzini, ma non ai tempi del Pinocchio, bensì oggi. Sarà proprio lui quello che gli narra la sua esistenza non facile, uomo fragile e disilluso, oppure è un impostore, un poveretto fuori di testa? Sta al lettore scoprirlo, noi intanto ci facciamo una chiacchierata con Paolo Ciampi (che potete vedere nella foto di una sua suggestiva presentazione fiorentina).
Hai scelto di parlare dell’autore di Pinocchio perché lo consideri un capolavoro (come del resto molti di noi)?
Non direi che sia stata questa la molla. Il Pinocchio è certamente un capolavoro, direi anzi un libro universale, il più tradotto nel mondo assieme al Piccolo Principe e allo stesso tempo un libro per tutte le età. Ma io ero intrigato dall’uomo che c’è dietro al Pinocchio, tanto dietro che in effetti si è nascosto dietro uno pseudonimo. A Carlo Lorenzini, per tutti Collodi, peraltro c’ero arrivato per altra strada, inseguendo il suo straordinario lavoro di giornalista all’epoca di Firenze capitale.
La voce narrante di questa storia si rivolge a qualcuno, che si rivela solo alla fine. Perché questa scelta?
Premetto che non si tratta di una biografia, benché credo di essermi mantenuto fedele a ciò che della vita di Collodi è possibile conoscere: che poi non è moltissimo. Ma in ogni caso il libro è soprattutto la storia di un incontro tra la voce narrante e Collodi, in una notte d’estate a Firenze, incontro che consente di incrociare due vite e scoprire somiglianze e affinità. Tutto questo si fa racconto e quel ‘tu’ è figura importante per Collodi, per la voce narrante e anche per il sottoscritto.
Come hai lavorato nel romanzo sulla voce, sul linguaggio di Carlo Lorenzini?
Era inevitabile cercare di adoperare la voce di Carlo Lorenzini, in un libro che si interroga anche sul rapporto tra un autore e la sua opera. Ci ho provato assimilando prima ancora che la lingua del Pinocchio, la lingua del Collodi giornalista, con la sua penna sempre pronta alla battuta ma anche a mettere il dito nella piaga, da grande moralista capace come pochi di raccontare i vizi e le virtù della gente. Ci sono articoli che mantengono intatta la loro freschezza, a cui non aggiungerei o leverei nulla. Ci sono espressioni e invenzioni linguistiche memorabili come quelle che nel Novecento ci hanno consegnato Indro Montanelli o Gianni Brera. Di alcune mi sono appropriato per riconsegnarle al personaggio del mio libro.
Il tuo è anche un modo per parlare di Firenze?
Sì, racconto un vagabondaggio notturno che ridisegna una mappa di Firenze. Mi misuro con la città vetrina turistica, ma provo a rifugiarmi anche in una città meno conosciuta e frequentata. Sto nel presente ma mi aggancio alla Firenze dell’Ottocento, in un gioco di rimandi. Di sicuro questo è anche un atto di amore, ma alla fiorentina. E i fiorentini, si sa, devono parlare male di ciò a cui vogliono bene.
Che rapporto hai scoperto tra Carlo Lorenzini e Geppetto? C’è qualcosa che li accomuna?
In fondo entrambi hanno dato vita a un burattino. E il Pinocchio è un libro dove il tema della ricerca del padre è forte. Il rimando in questo caso è anche alla vita di Carlo Lorenzini stesso, uomo che ha perso presto il padre, ma che non ha potuto essere padre a sua volta: il burattino è il suo unico figlio.
E tu, dovendo scegliere, ti senti più Geppetto o Pinocchio?
Senz’altro Pinocchio, con la stessa inclinazione a resistere poco alle tentazioni che peraltro accomuna il Pinocchio a Oscar Wilde. Però Geppetto è un personaggio di una straordinaria tenerezza. Avremmo bisogno della sua umanità – incardinata nella modestia e nella dignità del lavoro – in questo nostro mondo.
Pinocchio è il simbolo del bugiardo, cosa pensi delle sue bugie?
Penso che tutti in fondo si costruiscono un’immagine di se stessi che ha più a che vedere con un intreccio di interessi, presunzioni e convincimenti assolutamente discutibili. E penso che in realtà la storia di Pinocchio non sia la storia di un bugiardo, ma la storia di un personaggio che riesce a diventare se stesso. Tanto che il burattino di legno alla fine diviene il bambino in carne e ossa.
E della bugia, in genere, cosa pensi? Ti fa ribrezzo o la giustifichi in certe occasioni? Da giornalista la usi mai, per esempio nelle interviste per raggiungere qualche scopo?
Sono convinto che l’intenzione valga sempre di più della parola. E il problema semmai è che tante volte la parola non è all’altezza dell’intenzione. Diffido dai fondamentalisti della verità a ogni costo, che poi in genere hanno da imporre solo la loro verità. Quanto al mio lavoro di giornalista, posso aver commesso sbagli, ma non adoperato bugie intenzionali. Piuttosto certe volte ho optato per il silenzio, che può essere una forma di delicatezza e rispetto. La deontologia professionale domanda giustamente di perseguire la verità, ma la verità poi non è mai una sola e non è mai data una volta per tutte. Alla fine è solo una questione di onestà, in primo luogo con se stessi. Diceva un grande reporter come Ryszard Kapuscinski: «Credo che per fare del buon giornalismo si debba innanzitutto essere degli uomini buoni». Ne sono convinto.
Non temi di poter essere accusato di passatismo? In fondo chi si occupa oggi di uno scrittore per bambini dell’Ottocento e dei suoi temi?
No, perché non credo a un’età dell’oro precedente, così come non ci credeva Collodi, che pure vagheggiava una “Firenze prima della decadenza”. Però dal passato si possono trarre buone indicazioni per il presente. Tanto più che certe questioni di allora sono sempre attuali. Così come lo sono tante questioni che ci sollecita la vita di Collodi. Un uomo, ricordiamo, che arrivò alla letteratura per l’infanzia perché a essa affidava l’unica speranza di cambiare in meglio il mondo. Grazie ai bambini, cioè agli adulti del futuro. Prima era stato tra coloro che avevano provato a fare l’Italia, solo che non gli era riuscita molto bene.
A un certo punto, parlando con Lorenzini, il tuo protagonista dice: “Solita miseria per gli scrittori, gli editori, i librai”, allora perché scrivere?
Meno male che non ci sono solo motivazione economiche. Per quanto mi riguarda sento che scrivere, e ancora di più leggere, mi fa bene. E poi un libro è anche un modo per sentirsi parte di una comunità che dà un senso alla parola e per cucire una rete di intenti e relazioni da cui, chissà, potrà scaturire qualcosa. L’importante è saper tenere a bada la propria vanità.
Paolo Restuccia
Il link all’intervista su Storygenius: https://bitly.ws/3a4t4
Libri dell’anno (seconda parte) Di Marisa Salabelle
Molte delle mie letture di quest’anno le ho recensite qui su Masticadores o su altri blog o riviste online: l’elenco è troppo lungo per riportarlo in questo articolo. Dirò soltanto che tra i romanzi che ho recensito, e che sono quasi solo italiani, non mancano i miei amatissimi Sinigaglia, Magliani, Ciampi, Trevi, Ferraguti, sempre pronti a sorprendermi con nuove splendide opere. Tra gli altri autori italiani che ho letto ma non recensito (o non ancora) ci sono alcuni miei colleghi di Arkadia, e voi potrete dire, okay, deve dirne bene perché pubblicano col suo stesso editore, e certo devo ammettere che ai libri di Arkadia rivolgo sempre uno sguardo particolarmente affettuoso, perché è il mio editore, sì, ma anche perché è una realtà che sta crescendo e che meriterebbe di essere più conosciuta e apprezzata poiché molte delle opere che pubblica sono realmente degne di nota. Come Nomi, cose, musiche e città, di Giovanni Granatelli, una raccolta di racconti brevi molto suggestivi, La lacrima della giovane comunista, di Giorgio Bona, e Un bambino sbagliato, di Giovanni Lucchese, di cui sicuramente parlerò più avanti perché avrò il piacere di presentarlo a Pistoia. Tra le scrittrici italiane che ho letto quest’anno voglio ricordare Francesca Matteoni e Rosalia Messina, anche loro già recensite, Fabrizia Ramondino, una scrittrice novecentesca che non finisce mai di stupirmi, Viviana Viviani, che ha pubblicato con Arkadia una bella e originalissima silloge poetica dal titolo La bambina impazzita, e Antonella Cilento, di cui ho letto Solo di uomini il mondo può morire, un libro molto bello, tra il diario e il saggio, che racconta di passeggiate che l’autrice e il suo compagno usavano fare nella Foresta Regionale di Cuma, durante la pandemia di covid, e spazia tra gli incontri inaspettati e curiosi, la rievocazione delle leggende legate al luogo, le riflessioni personali e le considerazioni relative alla questione ambientale. Passando invece agli autori stranieri, tra di loro ci sono senza dubbio i libri più belli e importanti, non perché gli italiani siano da meno, o forse sì, chissà. Si comincia con Lezioni, l’ultima fatica di Ian McEwan, che percorre tutta la vita di Roland Baines, un uomo sempre alle prese con donne dalla personalità fortissima che in qualche modo lo seducono e lo soggiogano: la madre, l’insegnante di pianoforte Miss Miriam, la moglie Alissa. Un’opera magistrale, come tutto ciò che esce dalla penna di McEwan. Ho letto con grande interesse e un certo senso di spaesamento per la sovrabbondanza di pagine, temi, personaggi, due romanzi di due grandi vecchi: Il passeggero, di Cormac McCarthy, e Cronache dalla terra dei più felici al mondo, di Wole Soyinka. Due opere molto belle e importanti ma di non facilissima lettura. Devo menzionare inoltre lo straordinario V13 di Emmanuel Carrère, il reportage del processo ai terroristi che fecero gli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi. Mi piacerebbe parlare ancora di altri libri che ho apprezzato molto, italiani e no, maschili e femminili, ma come si fa, nominerò appena Amianto, di Alberto Prunetti, La conca buia, di Claudio Morandini, L’orecchio di Kiev, di Andrej Kurkov. Per quanto riguarda la saggistica, sono molti i libri che hanno avuto su di me una forte impressione. La maledizione della noce moscata, di Amitav Gosh, parte da una vicenda storica sconosciuta ai più, del modo cioè in cui l’arcipelago indonesiano Banda, colonia prima portoghese e poi olandese, nel XVII secolo fu ferocemente spopolato dei suoi abitanti, successivamente ricollocati sulle stesse isole come schiavi, per impiantare la coltivazione della noce moscata. Un caso esemplare di colonialismo arrogante e distruttivo che offre all’autore lo spunto per parlare di storia, popoli, ambiente, sfruttamento. La Q di Qomplotto, di Wuming 1, che analizza il fenomeno del complottismo in modo acuto e approfondito, e Doppio, di Naomi Klein, un saggio molto interessante che spazia tra vari argomenti, difficile da riassumere in poche righe. Contagi, di Kyle Harper, un grande affresco della storia umana dal punto di vista delle malattie che l’hanno afflitta nelle varie epoche. Ho letto diversi libri su un tema che mi coinvolge molto, quello delle migrazioni: il più importante è stato il saggio di Sally Hayden, una giornalista irlandese che da tempo si occupa dell’argomento. E la quarta volta siamo annegati è un testo duro, che si basa su inchieste condotte dall’autrice, testimonianze, racconti autobiografici, e narra senza nascondere nulla il dramma dei migranti che vengono dall’Africa. J’accuse, di Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite, è invece un duro atto di accusa verso la politica coloniale di Israele nei confronti della terra e della popolazione palestinese, con occupazione dei territori, apartheid, stragi e ora la spaventosa guerra che sta distruggendo Gaza. Concludo con una biografia davvero monumentale, quella di Philip Roth scritta da Blake Bailey, imperdibile per chi ama il grande scrittore americano, e con due testi di poesia: la raccolta Corpuscoli di Krause, di Fabiano Alborghetti, e Le case vogliono dire, un libro a metà autobiografico e a metà autocritico di Umberto Fiori, un poeta che mi piace talmente che mi basta leggere un suo verso per sorridere di felicità dentro di me.
Marisa Salabelle
Il link alle segnalazioni su Masticadores Italia: https://bitly.ws/39EBN
UN BAMBINO SBAGLIATO il nuovo romanzo di Giovanni Lucchese – Arkadia Editore – articolo di Lié Larousse
“Forse alcuni esseri umani vivono la loro vita alla maniera di Annibale.
Si comportano in modo strano, fanno cose a cui non sappiamo dare una spiegazione e le ripetono ogni giorno senza fermarsi mai, corrono su e giù per tutto il tempo e si sentono sempre più arrabbiati, ma forse lo fanno per distrarsi, così non devono guardare le sbarre della loro gabbia e possono far finta di non trovarsi in prigione. Forse stare sempre in movimento li aiuta a non pensare al futuro che li aspetta, che sarà uguale al loro presente e identico a ogni giorno che hanno vissuto, senza cambiare mai niente. Perché se corri come un matto su una ruota che gira su sé stessa non arrivi mai da nessuna parte, ma magari alla fine sei così stanco da poterti addormentare senza impazzire dalla rabbia e non hai più la forza si stare a chiederti il perché di tante cose”
Avete mai avuto quella strana sensazione di sentirvi osservati anche se ci siete solo voi nella stanza? Magari avvertite proprio una presenza e allora iniziate ad aggirarvi per casa un po’ irrequieti, preoccupati e perché no, curiosi, improvvisamente incontrate lo specchio, lui è lì da sempre, eppure, vi ci specchiate ora come fosse la prima volta e solo in questo preciso momento vi sembra di guardarvi davvero.
Quanto intimorisce vedersi per la prima volta?
A questa domanda ci risponde un bambino, che correndoci incontro, ci porta in un viaggio nel passato, alla scoperta dell’essere umano e di tutte le sue peripezie per diventare adulto.
Con lo scalpore, le speranze, le delusioni, i sentimenti, la vivacità, l’ingenuità, la voce che sa avere solo un bambino, Giovanni Lucchese con il suo “Un bambino sbagliato” , ci fa vivere momenti di cruda realtà e tenera schiettezza attraverso l’innocenza genuina che tutti noi abbiamo avuto in un momento preciso della nostra vita, quel momento quando da bambini non sapevamo ancora ingannarci, illuderci, giudicarci, quel momento quando esprimere un sogno impossibile non ci spaventava affatto, piuttosto lo sentivamo un nostro diritto.
Ogni personaggio, ogni mirabolante avventura simboleggiano un insegnamento da accogliere ed imparare, come il non vergognarsi e il non avere paura di ciò che si è, di ciò che si desidera e sogna.
“Un bambino sbagliato” è un meraviglioso, commovente e spassoso racconto di vita, un romanzo biografico di formazione che tutti dovremmo leggere, lo consiglio di cuore.
Lié Larousse
Il link alla recensione su Libroarbitrio: https://bitly.ws/38QC9
Consigli di lettura e di scrittura di fine anno – Annachiara Biancardino
Siamo felici e onorati di ospitare nel nostro blog un articolo di Annachiara Biancardino. Spesso ci ha consigliato numerose letture interessanti e questa volta abbiamo pensato di chiederle se potevamo lasciarle il palco tutto per lei. Ma presentiamola. Foggiana di nascita e barese d’adozione, ha sempre amato troppo i libri, infatti si è laureata in Lettere. È editor e consulente editoriale freelance, direttrice editoriale di Les Flâneurs Edizioni, insegna Lingua italiana in una SSML e Scrittura creativa in diverse realtà di formazione. Fa parte del direttivo dell’associazione culturale Lessico e nuvole ed è membro della Società italiana delle letterate. I suoi articoli sono apparsi su varie riviste specializzate e blog online. Ma soprattutto è una persona meravigliosa! Daje.
Tutti stanno proponendo le loro liste di libri imperdibili del 2023 e sono stata contagiata dall’atmosfera e quindi vorrei comunque provare a dare qualche consiglio utile, anzi provare a darne dodici, in particolare a chi si accinge ad avvicinarsi alla scrittura (ho un debole per gli esordienti, per gli studenti… insomma, per i ragazzi).
A chi vuole scrivere di Storia consiglierei assolutamente “Resta con me, sorella” di Emanuela Canepa (Einaudi). Ogni pagina di questo testo mostra la monumentalità del lavoro di ricerca necessario per scrivere un buon romanzo storico, ma a mio avviso non è nemmeno la sua accuratezza questo libro speciale nel suo genere: è che Canepa riesce a mostrare la Storia da un’angolazione tutta sua, diversa, nuova, autentica. E sì, ci riesce anche perché non tratta le solite pagine di storia ampiamente già note del Novecento, ma soprattutto perché, benché la focalizzazione sia tendenzialmente fissa sulla protagonista, l’autrice riesce a creare una storia corale, a offrire della storia una visione multiprospettica. Credo non si possa comprendere come faccia senza leggerlo.
Per chi vuole raccontare una generazione credo sia imperdibile “La ricreazione è finita” di Dario Ferrari (Sellerio). Lo sanno ormai anche i muri che ho molto amato questo romanzo e lo consiglierei a chiunque voglia leggere un gran bel libro, ma in particolare lo suggerirei caldamente a chi desidera scrivere la generazione degli “sdraiati”, quelli che si sono ritrovati non più ragazzi senza mai essere diventati adulti. Sottolineando che il libro affronta anche, con intelligenza di acume raro, l’aspetto di quella generazione che è forse il più difficile da indagare: il rapporto con la politica.
A chi combatte con le scene di sesso suggerirei una full immersion in “Affamata” di Melissa Broder (NN editore). Per imparare quanto duro lavoro costa arrivare all’essenza della parola. Perché occorre non censurarsi per essere sovversivi. Perché il sesso non va buttato lì, magari a sproposito, va in primis significato: e in questo romanzo ogni scena (e ogni ripetizione e ogni ripresa) trova un senso, come il tassello di un puzzle che ricostruisce il legame della protagonista col corpo (e quindi col sesso, col cibo ecc.).
A chi vuole scrivere racconti consiglierei “Un posto difficile da raggiungere” di Gianluigi Bodi (Arkadia). Gli autori di racconti, è noto, vivono una vita ancora più dura di quella già dura dello scrittore medio, quindi darsi alla narrativa breve è un’operazione che consiglierei solo agli affini di von Masoch. E solo se almeno ne vale la pena, se serve a trovare la propria voce: e nella dimensione del racconto viene fuori la forma che Gianluigi ha saputo dare alla sua poetica. Ho idea che possa compiere la magia di preservarla anche nei lavori un po’ più lunghi.
Per chi desidera scrivere una biografia: “Il mistero di Anna” di Simona Lo Iacono (Neri Pozza). L’escamotage narrativo per disegnare il ritratto di Anna Maria Ortese è già una trovata efficace, ma non è solo per questo che lo consiglierei a chi si appresta a scrivere “roba biografica” di vario tipo. Che si trasformi il soggetto che si desidera raccontare in un personaggio o che ne si prenda in prestito la voce narrando in prima, comunque da una biografia dovrebbe venir fuori l’essenza di un’anima. Qui quella di Ortese viene fuori nitida e luminosa, su molti piani e a più strati.
A chi vuole esercitare la lingua tramite la lettura suggerirei “La casa del mago” di Emanuele Trevi (Ponte delle Grazie). Trevi ha un modo tutto suo di intersecare generi letterari e scampoli di memoria, citazioni nitide e ricordi sbiaditi. Ma al di là della struttura delle sue trame, che mi pare irripetibile, Trevi è a mio parere – gusto personalissimo – una delle migliori penne in circolazione proprio quanto alla raffinatezza della parola, un modello di stile.
Per chi vuole addentrarsi negli abissi dei sentimenti mi viene subito in mente “Chiedi se vive o se muore” di Gaia Giovagnoli (Nottetempo). Gaia è una giovane maga della scrittura e ne aveva già dato prova col primo romanzo. Stavolta ci offre un’opera completamente diversa dalla prima: c’è molta meno trama nel suo nuovo lavoro e questo le consente di portare alle estreme conseguenze una tendenza all’introspezione che l’autrice già possedeva e che è necessaria per indagare le relazioni umane, tossiche o meno. Direi di leggerla per imparare a scavare nei rapporti interpersonali, a vivere la scrittura come un’operazione archeologica, anche senza il supporto dei tarocchi.
Per chi vuole creare un inferno (e in letteratura, come nella vita, ce ne sono moltissimi: prigionie di vario tipo, dipendenze ecc) credo sia imprescindibile la lettura di Jesmine Ward, e mi riferisco in questo caso a “Giù nel cieco mondo” (NN editore). Confesso subito di avere un debole per le riprese dantesche, in particolare al femminile. Comunque ho tentato di consigliare (quasi) solo autori italiani perché è chiaro che per entrare in campo con gli avversari bisognerebbe prima conoscere la propria, di squadra. Gli aspiranti scrittori italiani che ignorano gli scrittori italiani mi fanno molto sorridere. Tuttavia, qualche eccezione va pur fatta e la faccio di nuovo per il catalogo di NN editore: chi vuole raccontare “avventure infernali” non può non confrontarsi anche con questo lavoro di Ward. In particolare lo consiglierei a chi sta creando lavori in cui è necessario confrontarsi con la fisicità del dolore.
Per chi ha la tentazione di esplorare il mondo del retelling mitologico può essere un valido esempio “Di quella materia che non dura“, romanzo d’esordio di Leonardo Floriani (Besa). È necessario appartenere a una minoranza per riscrivere la cultura dominante? Sembrerebbe di no, stando a questo esperimento; ma bisogna saper mischiare una vivida intelligenza a una buona dose di incoscienza per avvicinarsi alle grandi narrazioni con la leggerezza pensosa dei fanciulli che, pur rendendosi conto della sacralità della materia narrata, non si privano del piacere di usarla come oggetto di divertimento e ambito di esplorazione. In sintesi, un libro che può insegnare come guardare alla tradizione; può trasmettere per osmosi un equilibrato mix di reverenza e ironia verso il mito e in generale verso i modelli che ci sembrano troppo alti per essere letterariamente sostenibili.
A chi si sta cimentando con una storia che implichi lo scrivere la vecchiaia, o anche semplicemente l’ordinarietà della vita, quella materia esperienziale che parrebbe priva di appeal narrativo, consiglierei “Il bisogno e la necessità” di Demetrio Paolin (Tetra). A differenza di almeno altri due romanzi, splendidi, che mi vengono in mente dello stesso autore, stavolta abbiamo un tema più universale, che si trasforma in un racconto forse meno di nicchia ma ugualmente raffinatissimo. Probabilmente perché ritroviamo la consueta disperazione silente che viene fuori da una scrittura tagliente, che tratta con la stessa chirurgica freddezza corpo e anima, sentimenti ed eventi. La lettura può aiutare a comprendere come raccontare lo scivolamento nella senilità, ma io direi che più in generale può aiutare a introiettare lo sguardo del narratore davanti alle questioni sporche e scomode, ai terremoti che si preparano sotto la superficie piatta dell’esistenza borghese.
Per chi vuole scrivere l’adolescenza. Qui mi gioco gli ultimi due consigli, rivolgendo lo sguardo in particolare all’adolescenza femminile e citando due romanzi diversissimi: “Stati di desiderio” di Marilena Votta (D editore) e “La strada dei pini d’inchiostro” di Bianca Versienti (Radici future). Due autrici entrambe al romanzo d’esordio, molto distanti tra loro per biografia e formazione, ma che hanno vinto la stessa sfida: immergersi nello sguardo di una protagonista adolescente. Che è poi l’unica strada per raccontare in modo credibile una fase delicata della vita.
Ogni anno per me è un anno in cui ho da ringraziare libri. I libri mi nutrono in diversi sensi. Ma se mi chiedete per cosa sono grata in particolare quest’anno, lo sono soprattutto per lui, la nostra creatura: “La tela di Svevo” di Alessio Rega. Si merita un 2024 di fuoco almeno quanto lo è stato il 2023.
Annachiara Biancardino
Il link alla segnalazione su Bokononisti: https://bitly.ws/38cCJ
I LIBRI CHE HO RECENSITO NEL 2023, RESOCONTO DI FINE ANNO DI DANIELA DOMENICI
Incipit necessario: come sa chi mi segue da tempo scelgo di recensire, gratuitamente e solo per passione, solo i libri che hanno incontrato il mio gradimento altrimenti evito per non demolirli con una recensione negativa, il motivo più comune di non apprezzamento è la non conoscenza della sintassi, della concordanza temporale e dei sinonimi (sono da anni anche correttrice di bozze ed editor…)
Per il secondo anno consecutivo ho voluto elencare in dettaglio i titoli di tutti i libri da me recensiti perché possa essere un input, uno stimolo a leggerli…
Al Salone del Libro di Torino a maggio e al Book Pride qui a Genova ho conosciuto nuove case editrici che mi hanno poi fatto dono di loro opere, cartacee o in pdf, ne ho ritrovata qualcuna del passato e ne ho persa qualche altra per strada senza sapere perché…ognuna di loro ha un suo angolo nel mio sito, eccole:
https://danielaedintorni.com/category/arkadia-editore/
https://danielaedintorni.com/category/edizioni-le-assassine/
https://danielaedintorni.com/category/edizioni-leima/
https://danielaedintorni.com/category/fratelli-frilli-editori/
https://danielaedintorni.com/category/golem-edizioni/
https://danielaedintorni.com/category/graphofeel-edizioni/
https://danielaedintorni.com/category/iacobelli-editore/
https://danielaedintorni.com/category/mon-edizioni/
https://danielaedintorni.com/category/morellini-editore/
Moltissime/i autrice e autori, ormai fidelizzate/i come amo definirle/i, mi hanno proposto, nel corso di questo anno che sta per concludersi, le loro nuove opere perché hanno apprezzato le mie recensioni precedenti e ne desideravano un’altra, sempre grazie per la fiducia…
Come potete vedere dalla tabella sottostante da gennaio a dicembre 2023 ho recensito 140 libri, che fa una media di 1 recensione ogni 2,6 giorni; 91 di autrici, 43 di autori, 2 antologie e 4 scritti a due mani.
Il mese in cui ho recensito più libri e ebook è stato gennaio (ero ancora in convalescenza per l’operazione alla schiena…) con 17 recensioni e poi giugno, luglio, ottobre e novembre con 13.
Il mese in cui ho recensito più autori è stato giugno con 7, quello in cui ho recensito più autrici è stato gennaio con 14.
Quest’anno, su suggerimento di un’autrice, ho ricominciato a pubblicare le mie recensioni su Goodreads oltre che sul mio sito e su Amazon; purtroppo non sempre il libro da me recensito è presente su quella piattaforma.
mese
autrice
autore
antologia
Scritti a due mani
Numero di recensioni nel mese e media
Gennaio
1. La spada di ghiaccio, di Romina Resto
2. Annabella Abbondante, di Barbara Perna
3. La violenza, di Marise Ferro
4. la governante di Madame de Lempicka, di Clara Zennaro
5. Il mistero di Anna, di Simona Lo Iacono
6. La ragazza in giardino, di Marise Ferro
7. le colpe di Maria, di Silvana Meloni
8. la tigre di Noto, di Simona Lo Iacono
9. donne musulmane, di Giuliana Cacciapuoti
10. mondi à la carte, di Gabriella Vergari
11. sono coniglio, partigiano, di Elisabetta Violani
12. la tasca sul cuore, di Chiara Forlani
13. Le Romantiche, di Marise Ferro
14. Il procuratore muore, di Luisa Valenzuela
1. Gentilupo, fiaba di Simone Morini
2. Il ritorno di Virgilio, di Hermann Broch
3. io che da mio padre ho preso solo gli occhi chiari, di Massimo D’Aquino
17 recensioni in 31 giorni, una recensione ogni 1,8 giorni
Febbraio
1. vasi di alabastro, tappeti di Bukara, di Angelica Gorodischer
2. verso una nuova vita, di Silvana Sanna
3. il secondo piano, di Ritanna Armeni
4. la scrittrice obesa, di Maria Salabelle
5. la mentalità della sardina, di Olivia Crosio
1. Caruggi di piombo, di Marvin Menini
2. il grande Hans, di Daniele Grillo
3. favole per Irene, di Enrico Zoi
4. lo zampacchione giallo, di Enrico Zoi
9 recensioni in 28 giorni, 1 recensione ogni 3,1 giorni
Marzo
1. Trenta giorni e cento lire, di Ester Rizzo
2. Streuse, di Marinella Fiume
3. La portalettere, di Francesca Giannone
4. Versi mortali a Camogli, di Adelaide Barigozzi
5. il campo delle ossa, di Chiara Forlani
1. né il fiore né il baratro, di Giovanni Rossi
2. la banda delle figurine, di Mario Barale
3. il tesoro di Hitler, di Achille Maccapani
4. sotto le stelle di Genova, di Marco Di Tillo
5. aperitivo all’arsenico a Roma, di Dario Falleti
10 recensioni in 31 giorni, 1 recensione ogni 3,1 giorni
Aprile
1. ballata per galline vecchie, di Elisa Genghini
2. la donna emancipata, di Jenny d’Hèricourt
3. Indagine su Alda Merini, di Margherita Caravello
1. favole ciniche, di Han Ryner
2. longevità fatale, di Attilio De Pascalis
1. Morgana, di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri
6 recensioni in 30 giorni, 1 recensione ogni 5 giorni
Maggio
2. Ogni cosa torna, di Patrizia Gariffo
3. E’ madre chi…di Cinzia Pennati
4. Mi limitavo ad amare te, di Rosella Postorino
5. Stai zitta, di Judy Brown
6. qualcosa di me, di Isabella Nicora
7. la tela di cloto, di Monica Vanni
1. i due volti della verità, di Rocco Ballacchino
2. in viaggio con la zia Colomba, di Renzo Bistolfi
1. pioniere, di Pina Caporaso e Giulia Mirandola
10 recensioni in 31 giorni, 1 recensione ogni 3,4 giorni
Giugno
1. l’enigma svedese, di K. G. Silisso
2. l’hotel, di Dana Maria Stifren
3. un diamante rosso sangue, di Clara Negro
4. anime sperse, di Pina Ligas
5. la mia itaca, di Anna Valeria Frigerio
6. la prof Aglietti non era Robert Capa, di Gabriella Vergari
1. delitti al buio, di Emiliano Bezzon
2. c’era una volta all’Asinara, di Giampaolo Cassitta
3. la pagina più bella, di Luc Dietrich
4. Bacci Pagano, una storia da carruggi, di Bruno Morchio
5. Ghost Medical Team, di Vincenzo Carrozza
6. L’uomo che portava a spasso i libri, di Carston Henn
7. il professore di Kabul, di Mario Grasso
13 recensioni in 30 giorni, 1 recensione ogni 2,3 giorni
Luglio
1. la miniera maledetta, di Tyline Perry
2. melodia perfetta per note stonate, di Nora Brant
3. Ouessant, l’isola delle donne, di Annalisa Comes
4. giallo siciliano, di Nuccia Isgrò
5. la barbiera, di Antonietta Muscas Podda
6. la trama di Elena, di Francesca Sensini
7. la bellezza rimasta, di Roberta Zanzonico
8. la banda dei colpevoli, di Sarah Savioli
9. la carrozza della santa, di Cristina Cassar Scalia
10. il suono del vento, di Cristina Origone
11. il sussurro della pioggia, di Cristina Origone
1. i silenzi della Bassa, di Massimo Fagnoni
2. il rumeno di Porta Venezia, di Mauro Biagini
13 recensioni in 31 giorni, 1 recensione ogni giorni
Agosto
1. i delitti di Varese, di Laura Veroni
2. il silenzio della terra, di Cristina Origone
3. Una felicità semplice, di Sara Rattaro
4. la ragazza dei colori, di Cristina Caboni
5. Umor Vitreo, d Paola Musa
6. la ragazza dell’Opera, di Adriana Valenti Sabouret
7. Il delitto di via Etnea, di Roberta Castelli
8. la traccia del pescatore, di Roberta Castelli
9. la bambina di cera, di Roberta Castelli
10. Pasticci di famiglia, di Daniela Graglia
1. perché la minestra si fredda, di Santiago Pumarola
2. Nero come la neve, di Marco Della Croce
12 recensioni in 31 giorni, 1 recensione ogni giorni
Settembre
1. Folisca, di Miriam D’Ambrosio
2. Il tuo silenzio è di stella, di Alessandra Corrà
3. Soli tra le stelle, di Elena Biondo
4. telefona, qualche volta, di Maria Concetta Distefano
5. Nulla d’importante tranne i sogni, di Rosalia Messina
6. Il calzolaio di Milano, di Claudia Maria Bertola
7. sui tuoi fianchi, di Arianna Ciancaleoni
8. nove giorni e mezzo, di Sandra Bonzi
9. Nelle loro mani, di Hilda Lawrence
1. il mare delle illusioni, di Sebastiano Martini
2. Vino rosso sangue, di Fabrizio Borgio
3. il maresciallo Bonanno, di Roberto Mistretta
12 recensioni in 30 giorni, 1 recensione ogni giorni
Ottobre
1. l’incastro perfetto, di Lavinia Brilli
2. Tunnel, di Maria Masella
3. I salmoni aspettano agosto, di Elena Panzera
4. Come pezzi di carta sull’acqua, di Sara Morchio
5. Verde mare, blu profondo, di Daniela Mencarelli Hofmann
6. La regina dei colori, di Valeria Corciolani
7. Bonnie Parker, di Arianna Destito Maffeo
8. Stella Benson, di Francesca Cosentino
9. Il dubbio dell’avvocato, di Laura P. Cavallo
10. Sono stata nella giungla, di Francesca Piazza
1. Nomi, cose, musiche e città, di Giovanni Granatelli
2. Vite senza gloria, di Giovanni Cacciatore e Giuseppe Pizzo
3. A Salina il vento cambia, di Giovanni Cacciatore e Raffaella Catalano
13 recensioni in 31 giorni, 1 recensione ogni 3,8 giorni
Novembre
1. Con te non ho paura, di Sara Rattaro
2. La stagione dei papaveri, di Flaminia Festuccia
3. Tonto, di Silvana Sanna
4. Ristretti nell’indifferenza, di Emma Zordan
5. L’anno dei destini incrociati, di Bea Buozzi
6. Tutte le cose che ho perso, di Katya Maugeri
7. Il fiore di Fahranaz, di YAPRAK ÖZ
1. Vite sbagliate, di Marco G. Dibenedetto
2. Il levarsi della luna, di Gian Luca Paganelli
3. Modus in rebus, di Riccardo Ferrazzi
4. Le ombre della sera, di Bruno Morchio
5. Bradipismi, di Stefano Serri
6. Due racconti, di Maurice Maeterlinck
13 recensioni in 30 giorni, 1 recensione ogni 2,5 giorni
Dicembre
1. Io sono Nannarella, di Carla Cucchiarelli
2. Come d’aria, di Ada D’Adamo
3. Scrivere per non morire, di Tommasina Soraci
4. La numismatica detective, di Linda Scaffidi
1. I delitti di Manfreda, di Roberto Mistretta
2. Avrai sempre una casa, di Piero Malagoli
3. Il canto dell’upupa, di Roberto Mistretta
4. Il babbo di Pinocchio, di Paolo Ciampi
5. Nel rimorso che proveremo, di Piero Malagoli
6. Rosario Livatino, di Roberto Mistretta
1. Accùra, antologia a cura di Roberto Mistretta
2. Natale a Genova, a cura di Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso
12 recensioni su 31 giorni, 1 recensione ogni 2,6 giorni
91 autrici
43 autori
2 antologie
4 libri scritti a due mani
140 su 365 giorni, 1 recensione ogni 2,6 giorni
Daniela Domenici
Il link alla segnalazione su Daniela e Dintorni: https://bitly.ws/385hQ
Disegnare il mondo
In una nota parabola di Jorge Luis Borges, inserita dallo scrittore argentino nella raccolta di racconti e poesie intitolata L’Artefice (1960), si legge: «Un uomo si propone il compito di disegnare il mondo. Trascorrendo gli anni, popola uno spazio con immagini di province, di regni, di montagne, di baie, di navi, d’isole, di pesci, di dimore, di strumenti, di astri, di cavalli e di persone. Poco prima di morire, scopre che quel paziente labirinto di linee traccia l’immagine del suo volto». La citazione, significativamente posta da Claudio Magris quale epigrafe dei suoi Microcosmi (1997), a sottolineare il senso di un’identità che si delinea nell’incontro con i piccoli universi umani e naturali, riassume l’ispirazione del volume di prose e racconti Nomi, cose, musiche e città, ultimo lavoro dello scrittore e poeta Giovanni Granatelli (Arkadia editore, pp.113, € 14.00). Paesaggi, riflessioni, ricordi, epifanie e piccoli e grandi vagabondaggi quotidiani tornano nell’opera di Granatelli dopo i precedenti Spostamenti (Nardini editore, 2020) e Resoconto. Poesie 2002-2022 (Scalpendi, 2023), per fondersi adesso in prose e racconti brevi di schietta e lineare intensità, attraverso una narrazione randagia e mai narcisistica, consapevole di sé e del potere evocativo e memoriale della parola che l’autore padroneggia con grande maestria e sicurezza. Sono i nomi, infatti, che troviamo come primo elemento di un titolo composito, in cui l’accumulo onomastico definisce l’orizzonte ontologico della narrazione, a sancire il potere evocativo e memoriale della parola: Granatelli abita le parole che ripercorre come tante linee di una carta geografica effettiva e memoriale, con i nomi che si riappropriano del proprio ruolo morfosintattico per definire identità e verità. Prende corpo così la parabola di una esistenza che si infarcisce di recuperi verbali come memoriali, delineandosi tra le direttive di rotte nuove e mete perdute in una compenetrazione di passato e presente, tra il suono di vecchie canzoni e desueti lettori di audiocassette, tra cose e musiche e città, epifanie sensoriali, riflessioni e nuove scoperte e verità. Il senso del viaggio, fisico come della scrittura, di cui l’autore si fa portavoce come moderno viaggiatore urbano, risiede dunque nel camminare («camminare è una delle attività più connaturate negli esseri umani, una maniera appropriata di stare al mondo», p. 12), divenendo presupposto indispensabile dunque della narrazione e della conoscenza, dello stupore e della condivisione, della indignazione e della scoperta. Così, «questa maniera appropriata di stare al mondo», non può non richiamare i passi del tempo e della storia. Se Milano è il teatro principale delle peregrinazioni cittadine di Granatelli, la città metropolitana per eccellenza ricca di servizi efficienti nell’ambito dei collegamenti e dei trasporti, dove coesistono gli sguardi tristi di una profuga siriana e s’affastellano i passi confusi e veloci dei viaggiatori alla Stazione centrale, è allo stesso tempo la città del rumore luminoso, capace di un peregrinaggio tutto umano che tuttavia non preclude la vista delle stelle. Tanti passi compie il viaggiatore, a pochi metri come a migliaia di chilometri da casa, alla scoperta di sé e del mondo, passi infiniti, come i giorni, quantificabili adesso grazie ai contapassi degli ultimi modelli di smartphone; passi infiniti che segnano il ricordo di una gita a Pompei e finiscono per arrestarsi nel sito degli scavi archeologici, dove anche la storia sembra fermarsi, in una «prolungata lezione di morte e sulla ferocia del tempo che passa e consuma tutto» (p. 11). Attraverso una continua relazione con l’alterità, quella dei luoghi, e quella più intima dell’identità personale chiamata a confrontarsi continuamente con la mutevolezza della vita e delle stagioni, Granatelli descrive un affresco sull’esistenza che con lirismo discreto da privato sa farsi universale. Lo status viatoris, condizione già ampiamente affrontata dal poeta nelle precedenti opere poetiche e prosastiche, non è soltanto una chiave interpretativa (in senso biologico) dell’esistenza ma anche la condizione intima ed esistenziale del viaggiatore: quella del poeta e dello scrittore assorto nei piccoli grandi vagabondaggi quotidiani, all’insegna di una esplorazione che s’immerge nella propria storia con un senso dell’effimero e insieme dell’eterno, alla ricerca di un’Itaca che è insieme meta del viaggio e specchio di se stessi, approdo e appassionante ritorno.
Laura D’Angelo
Il link alla recensione su Insula europea: https://bitly.ws/384×4
LIBRI PER L’INVERNO (E NON SOLO) 2023
Anche quest’inverno una serie di consigli di lettura da parte di alcune persone della redazione. Buone letture!
Francesco Ricapito
Witold Szablowski, Come sfamare un dittatore, traduzione di Marzena Borejczuk, Keller editore
Una raccolta di storie intorno ai cuochi di alcuni dei più famosi dittatori del secolo scorso. Un’interessante collezione di ricette, aneddoti ed episodi dietro le quinte che in un modo o nell’altro hanno probabilmente influenzato le decisioni di queste figure controverse.
Silas House, L’Ascesa Di Lark, traduzione di Gianluca Testani, Jimenez Edizioni
Romanzo di formazione ambientato in un futuro distopico, non troppo lontano, dove cambiamento climatico ed estremismi hanno reso la vita una lotta per la sopravvivenza. Il giovane Lark affronta un viaggio dagli Stati Uniti fino in Irlanda, verso il villaggio di Glendalough, dove spera di trovare una comunità che lo accolga e che gli permetta di vivere serenamente.
Gianluca Massimini
Gianluigi Bodi, Un posto difficile da raggiungere, Arkadia.
C’è un forte filo conduttore che unisce i racconti che compongono questa raccolta. I protagonisti sono persone che cercano un proprio posto nel mondo senza comprendere fino in fondo quale sia la strada da percorrere. A volte sono in cerca di un lavoro che dia senso a una vita di sacrifici, come in Limonium vulgare, altre volte invece stanno cercando un luogo che li isoli dal resto del mondo e gli permetta di rinforzare legami che si erano allentati come nel racconto Il vecchio in bicicletta. Alcuni hanno perso la luce della ragione, altri sanno che una scelta può salvarli dalla prigionia che si sono autoimposti. Ciò che li spinge ad andare avanti è la consapevolezza, spesso anche solo la speranza, che a pochi passi ci sia qualcosa che porti equilibrio nelle loro vite e le faccia risplendere, qualcosa che tolga loro di dosso la sensazione di essere gli unici a camminare con un passo lento mentre tutti gli altri stanno correndo.
Thomas Bernhard, Il soccombente, traduzione di Renata Colorni, Adelphi
A un corso di Horowitz, a Salisburgo, si incontrano tre giovani pianisti. Due sono brillanti, promettenti. Ma il terzo è Glenn Gould: qualcuno che non brilla, non promettente, perché è. Una magistrale variazione romanzesca sul tema della grazia e dell’invidia, di Mozart e Salieri, ma ancor più sul tema terribile del “non riuscire a essere”.
Julio Cortázar, I racconti, a cura di E. Franco, Einaudi
Che la letteratura argentina abbia dato nuovo spazio vitale a un glorioso genere narrativo quale il racconto fantastico, è cosa nota. Dopo Borges, Julio Cortázar ha avuto, in questo, un ruolo preminente. La caratteristica del suo modo di narrare è la precisione realistica in cui la trasfigurazione visionaria affonda le radici, dando vita a una galleria quasi metafisica di personaggi invisibili, dove il misterioso e l’irrazionale prendono corpo tra atmosfere popolari e ambienti altolocati, sullo sfondo di una Buenos Aires multiforme. A cent’anni dalla nascita del grande scrittore argentino, una raccolta completa dei suoi racconti: un’introduzione all’opera di Cortázar, un “bestiario” di ossessioni, figure immaginarie, nate da una fantasia attica, eppure descritte con dolorosa determinazione.
Daniele Gigli, T. S. Eliot nel fuoco del conoscere, Ares
A oltre cinquant’anni dalla morte, il nome di T.S. Eliot e della sua Terra desolata, il poema metamorfico sulla caduta dell’Occidente, risuonano ancora alti e chiari. Ma che cosa c’è dietro le quinte della poesia eliotiana? Che cosa lo rende così capace di trascenderne la natura artistica e di farne una forma-pensiero? Con una messe di documenti inediti in Italia e nuove traduzioni che ne ravvivano i testi già editi, il libro di Daniele Gigli ricostruisce con rigore ed essenzialità la biografia intellettuale di Eliot, disvelando la potenza conoscitiva e il vigore ancora inesausto dei suoi versi e della sua critica sociale.
Giuliano Gramigna, Marcel ritrovato, Il ramo e la foglia edizioni
Scritto negli anni Sessanta, “Marcel ritrovato” è considerato il romanzo più bello di Giuliano Gramigna. Attraverso una raffinata struttura meta-narrativa, l’autore sviluppa un’ampia riflessione sulla scrittura letteraria (e sul senso ultimo del “fare il romanzo”), intrecciandola a una storia d’amore che si snoda tra Milano e Parigi: Bruno, scrittore dilettante, afflitto da una nevrosi di cui è pienamente cosciente, riceve dall’amata Roberta una strana richiesta: andare a Parigi alla ricerca del marito scomparso. Riuscirà il nostro eroe a trovare Marcello? Che china prenderà questa singolare inchiesta? Di particolare interesse è il fatto che, nel corso della narrazione, l’autore confessi via via – grazie ad accorgimenti paratestuali e grafici di grande originalità – di non riuscire a restare fuori dalla materia narrata, cosicché la distanza di sicurezza dal protagonista finirà col venir meno; tanto che si assisterà spesso, nella scrittura, a slittamenti dalla terza persona alla prima. Non viene mai a mancare tuttavia l’elemento ironico, che in qualche modo mitiga, anche al lettore, la sofferenza spesso causata dai ricordi del protagonista-autore. Con una nota di Ezio Sinigaglia.
Ezio Sinigaglia, L’amore al fiume (e altri amori corti), Wojtek
Un campo militare estivo fra i boschi, il fiume e un paesello di poche anime: in una situazione di solitudine collettiva e di eccitante reclusione all’aperto si muovono i giovani bersaglieri protagonisti di questi sei racconti. Il vento di un desiderio irresistibile e vago ad un tempo muove ciascuno di loro verso una meta confusa, che occasionalmente può trovarsi a coincidere con la meta di un altro, chiarendosi allora ad un tratto nelle parole o nei gesti prima ancora che nei progetti, piuttosto imprecisi. È sabato, la disciplina già blanda del campo gode di ulteriori indulgenze, la sensualità dell’aria di giugno, la complicità delle ombre, i sussurri della natura spingono a passi inattesi. La misteriosa bellezza del paesaggio avvolge quella ancor più misteriosa dei corpi, e niente più della guerra è lontano dai cuori.
Alessio Rega, La tela di Svevo, Les Flâneurs
Svevo ha settantatré anni e vive nel suo buen retiro a Molfetta, in Puglia: qui si dedica alla pittura, anche se è costretto ad accontentarsi di commissioni di arte sacra che provengono da politicanti che disprezza. In occasione della presentazione della sua nuova Madonna, Svevo incontra per la prima volta dal vivo Anna, talentuosa giovane arpista utilizzata come modella inconsapevole per il suo quadro. Nei dodici mesi in cui si frequentano, Svevo si lascia sconvolgere dalla freschezza e dall’ambizione della ragazza, dando il via a un viaggio sentimentale fra l’Italia e la Corsica (dove i due andranno alla ricerca del figlio di Svevo, da lui mai conosciuto e riconosciuto), che costringerà entrambi a guardarsi dentro guardando nell’altro. Cosa sceglierà Svevo quando si renderà conto di essere d’ostacolo alle ambizioni di Anna, e di aver ricoperto la sua giovane esistenza di un velo di malinconia? E Anna sarà all’altezza di raccogliere la lezione del suo troppo amato maestro, dedicandosi all’anticonformismo e alla ricerca della libertà?
Ettore Fobo
Alessandro “Kresta” Pedretta, Milano di merda – Cronache di una città tossica, Agenzia X
Ritratto impietoso di quella che una volta era la “capitale morale” d’Italia, “Milano di merda- Cronache di una città tossica”, scritto da Alessandro ”Kresta” Pedretta e edito da Agenzia X nell’ottobre del 2023, è un romanzo stratificato, dalla scrittura lucida e proteiforme che racconta il capoluogo lombardo nella sua versione più oscura, quella dello spaccio e del consumo di eroina, negli anni novanta. Pedretta tratteggia una “toponomastica del dolore”, ricordando tutti i luoghi del degrado tossico, da Rogoredo a Piazza Vetra, luoghi in cui si è consumata la discesa agli inferi di una generazione maledetta. Il tema è forte, la narrazione non fa sconti al lettore, i rimandi letterari sono molteplici dall’inevitabile Burroughs all’apocalittico Testori.
Non manca un sottile humor nero che sembra galleggiare sul mare della disperazione più atroce. Così Milano si sgretola e dietro la facciata di città perbene appare una città allucinata, folle, perversa, “cannibale” .
Lodovica San Guedoro, Le memorie di una gatta, Felix Krull editore
Con il titolo “Le memorie di una gatta” Felix Krull Editore pubblica nell’ottobre del 2018 questo romanzo di Lodovica San Guedoro, in cui l’autrice dissemina, in una prosa rotonda, piacevole e limpida, alcune intuizioni circa la natura profonda del reale, visto attraverso gli occhi – all’inizio ingenui e trasognati, poi progressivamente più maturi – di una gatta che racconta la sua storia sin da cucciola. Tuttavia, nel corso della lettura l’aspetto favolistico va in secondo piano ed emerge come un altro romanzo. È l’effetto matrioska: un romanzo dentro un altro romanzo. Scopriamo così che il testo si traveste via via, da favola a serrata critica al mondo culturale italiano asfittico, capace solo di strangolare ogni anelito realmente creativo, da biografia sui generis ad apologo contro la civiltà delle macchine e altro ancora, in una sintesi magistrale.
Guglielmo Aprile, Il talento dell’equilibrista, Ladolfi editore
Questa silloge di Guglielmo Aprile è una dura, necessaria, a tratti sconfortante, fotografia filosofica della nostra civiltà declinante. L’orizzonte è quello della perdita di senso e di centro di un intero mondo, ormai condannato a una sempre più veloce entropia di significati. La vita che viviamo è una mistificazione futile: la faccia che ci costruiamo anno dopo anno “assume i connotati/ di un gigantesco errore irreparabile”. Tutto scorre inesorabilmente ma a mostrarlo non è più il fiume eracliteo ma un più banale rubinetto, il poeta non ha per fratelli che ”i lampioni impassibili”, le strade sono “furibonde”; ogni felicità è una caricatura, è solo un momento, spesso risibile, prima dell’inevitabile annientamento. La visione di Guglielmo Aprile s’innesca, a tratti ferocemente disincantata, a partire della leopardiana “strage delle illusioni; così questa silloge è preziosa testimonianza del nostro quotidiano naufragare in un mare d’insensatezza.
Luca Menichetti
Boris e Arkadij Strugagkij, È difficile essere un dio, a cura di Paolo Nori, traduzione di Diletta Bacci, Marcos Y Marcos
Racconto di fantascienza, pubblicato nel 1964, ambientato in un lontano pianeta abitato da umani alternativi e in una società simile al nostro medioevo, ma in condizioni ancor più crudeli. Una sorta di grande metafora delle condizioni degli intellettuali alle prese con un regime totalitario; che provocò qualche grana agli autori. Almeno da parte di chi aveva colto il loro messaggio.
James Yorkston, Il libro dei Gaeli, traduzione di Gianluca Testani, Jimenez
Una sorta di racconto picaresco anni ’70 ambientato in Irlanda. Una lettura fluida, ma soprattutto il racconto, tra mille vicissitudini, di una ricostruzione e di un consolidamento di affetti familiari.
Paolo Zardi, La meccanica dei corpi, Neo
5 racconti lunghi, che prendono spunto dal rapporto tra mente e corpo, o viceversa, nonchè dall’autentico mistero che incorre nelle relazioni dei nostri corpi con gli altri corpi. Comunque sempre con una scrittura “che comunica precisione, profondità e semplicità” (cit.).
James Lee Burke, New Iberia Blues, traduzione di Gianluca Testani, Jimenez
Un lungo romanzo in cui, per le strade di New Orleans, ricompare il detective Dave Robicheaux. Molti dialoghi, ben strutturati e tipici del genere noir, per una vicenda che, molto tenebrosa e ovviamente ricca di mistero, ci racconta una realtà, tutt’ora attualissima, fatta di razzismi e prevaricazioni.
Andrea Brancolini
Ginevra Ballati, Chiara Daino, Dea culpa. Breviario per l’anima stanca, Ursa Maior.
Un libro d’arte, piccolo e denso, pubblicato da una piccola casa editrice pistoiese, in cui le autrici dialogano con linee, forme, colori, parole. Composto da “sette immagini, sette preghiere, sette pittogrammi, sette prediche” esplora il senso di colpa, evoca e invoca la Dea culpa, dea che scarnifica e consuma, una dea artificiale che tortura con la sua corona di spine dalla casa fino alle ossa assetata di sangue. Sette i giorni della settimana e ventotto (7×4) quelli del ciclo lunare, e sette gli anni di ogni ciclo vitale. Un breviario per l’anima stanca che osservando e leggendo trova sguardi amici e nuova forza.
Emanuela Cocco, Trofeo, Zona 42.
Una novella, un racconto lungo che fa parte della collana Nodi diretta da Elena Giorgiana Mirabelli. Cocco si diverte nella messa in scena dei trofei di un serial killer, oggetti delle vittime che l’assassino porta con sé. Cose che nascono nel momento in cui sono strappate alle persone cui appartenevano, cose che imparano a parlare, cose che scoprono di poter, forse, provare sentimenti, cose che hanno ognuna caratteristiche diverse, cose che possono ripercorrere quelle vite, assaporarne le sensazioni, e cose che cominciano a. Un racconto con una scrittura musicale, con temi che ricorrono, parole che passano di capitolo in capitolo, fino a quando non c’è altro che.
Simone Ghelli, La vita moltiplicata, Miraggi.
Una raccolta di racconti che si muove tra sogno e realtà. Muse irraggiungibili e lavori da tre euro l’ora, professori che parlano con gli studenti e quindi malvisti, piccole librerie che chiudono, giovani che lavorano in case editrici col compito di leggere i manoscritti, postini che si sentono male, e così via, tutti i protagonisti sognano, maneggiano i propri sogni e/o gli altrui, moltiplicano le proprie vite a occhi aperti, a occhi chiusi, e poi? “Si fa sempre tutt’altro nella vita”. Sono quasi cortometraggi, più che racconti, con il libro che diventa un film a episodi.
Elena Panzera, I salmoni aspettano agosto, Giulio Perrone Editore.
Un diario. Anzi, il diario di Michele, che scrive per parlare a sua sorella gemella Francesca. Pagine che risalgono il fiume della memoria come fanno i salmoni quando tornano ai fiumi che li hanno visti nascere. Pagine che seguono la musica vitale per entrambi, che suonano il pianoforte a quattro mani; pagine come spartiti, scritte quando a Michele “sembra di non esistere”, come gli ha detto di fare la madre quando gli ha donato il diario. Scrivere per tornare a esistere, quindi, scrivere per vedersi esistere, scrivere per ricordarsi che, se non si esiste ora, si è esistiti. I due vivono a Viareggio, cittadina segnata dalla strage ferroviaria del 2009, strage che coinvolge seppure indirettamente anche la loro famiglia; cittadina che se fosse il personaggio di un film sarebbe il caratterista dalle poche battute cui ti affezioni e a cui è affidato un compito che va quasi oltre le sue possibilità.
Jarvis Cocker, Good pop, bad pop, traduzione di Ludovica Marani, Jimenez.
Jarvis Cocker deve svuotare la soffitta della casa londinese e decide di tirare fuori tutte le cose accumulate, fotografarle, e decidere cosa farne, se tenere o buttare. È un viaggio nella vita musicale di questo grande songwriter, dove tra cose improbabili ecco saltare fuori il suo quaderno di 15enne, in cui già il nome Pulp è presente e dove, come primo aspetto della futura band, c’è il guardaroba, con tanto di disegni. Scritto con mano lieve e ironica, corredato delle foto, è una vera chicca.
Andrea Brancolini
Il link alla segnalazione su Lankenauta: rb.gy/hi40ib