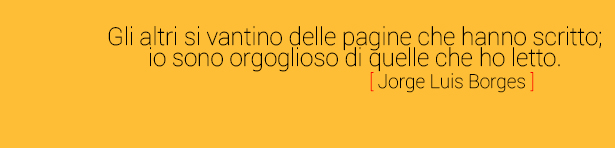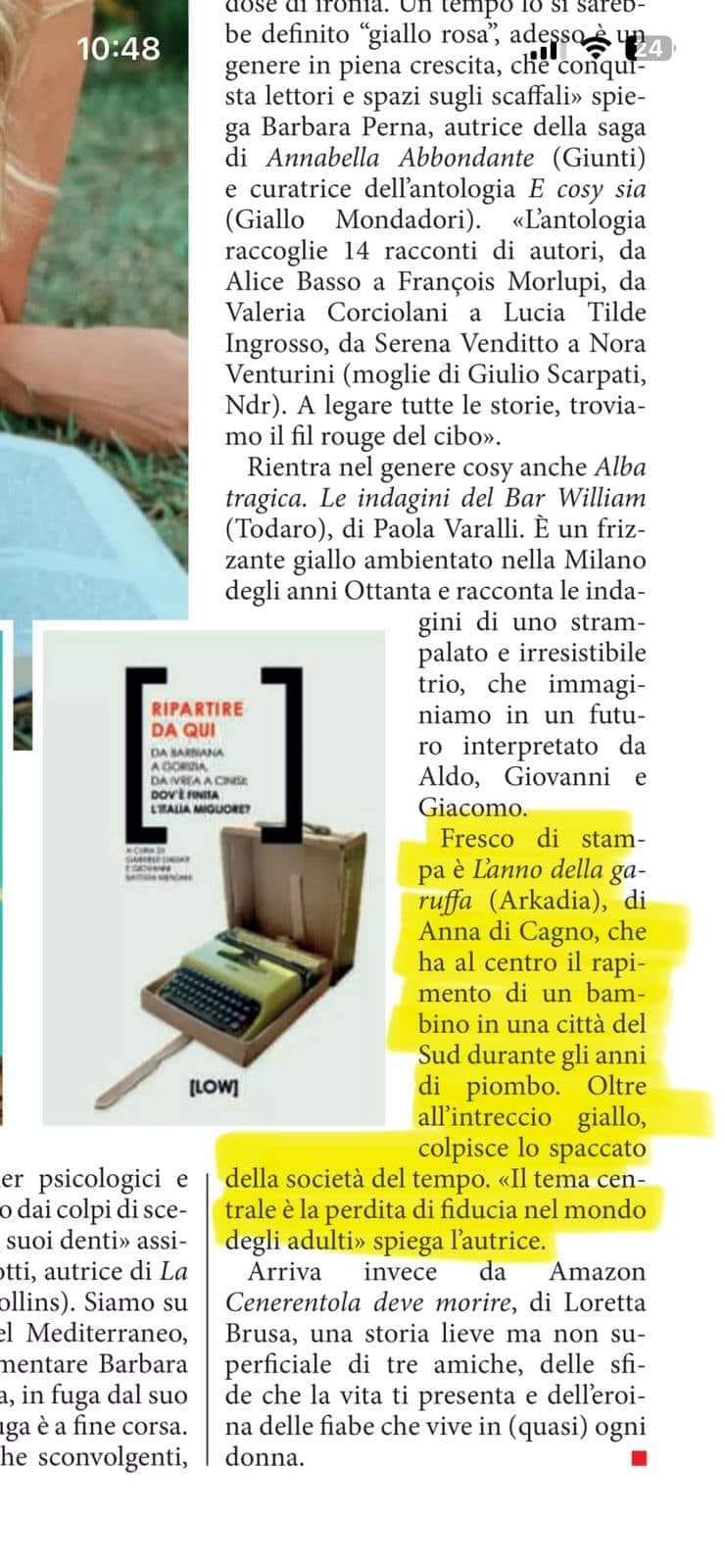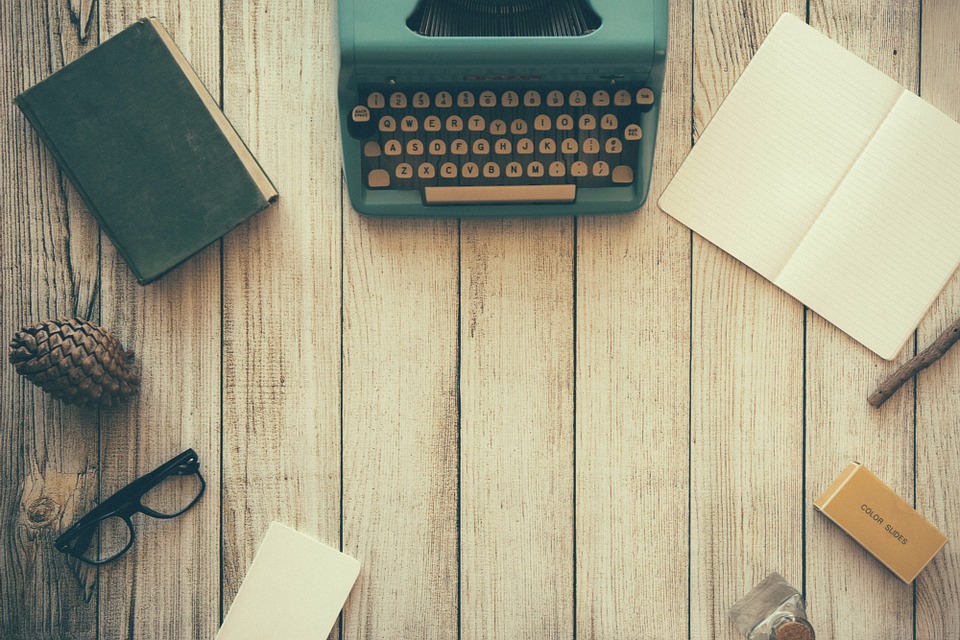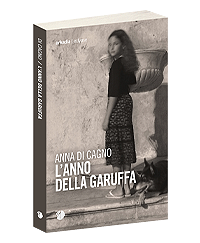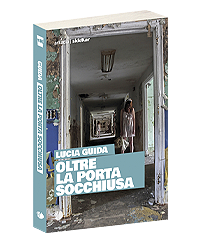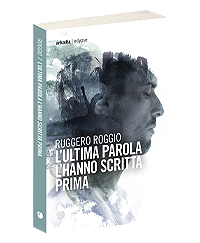I consigli per l’estate 2024! Una carrellata tra gialli, mondi specchio, scrittrici misteriose, rabbia, mostri e fanciulle sarde
Torno di sorpresa sorpresissima con un post di consigli per l’estate che poi alla fine è diventato anche un piccole recensioni tra amici.
Incredibili miracoli che accadono in una torrida serata di luglio!
Non mi dilungo troppo e vi lascio con le recensioni prima che questo post esca in tempo per la prossima estate!
DOPPIO. IL MIO VIAGGIO NEL MONDO SPECCHIO di Naomi Klein ed. La nave di Teseo:
Stranissimo che si sia parlato così poco di questo saggio di Naomi Klein, un saggio che sicuramente come è stato fatto notare non brilla per la traduzione sin dal titolo (l’originale era “Doppelganger”, incomprensibile perché sia stato cambiato), eppure tocca in modo inquietante praticamente tutti i punti delle derive politiche distopiche a cui stiamo assistendo da qualche anno a questa parte.
Naomi Klein, autrice di “No logo”, parte da un suo diciamo problema personale: la gente la confonde con Naomi Wolf.
E voi direte, e vabbeh, sai quante volte capita a me di essere confusa a caso (tipo, a me sbagliano regolarmente il cognome in Mangano, forse perché è più comune)?
E beh, nel suo caso è un problema bello grosso perché Naomi Wolf è il suo esatto opposto: è nata come studiosa del femminismo (suo il famoso “Il mito della bellezza”) e poi ha preso una strana deriva.
In un rapido giro di walzer, condito anche da libri piuttosto dubbi, ha sposato tesi novax, ha iniziato a condurre ricerche universitarie in modo controverso e poco scientifico, e si è trasformata in filobannoniana, trumpiana, complottara e insomma è assurta sorta ad amata intellettuale di questa destra che flirta con la fantascienza facendo credere a molti che è la realtà.
Da questo problema (perché lo è visto che la gente le fonde in un’unica entità attribuendole affermazioni e scritti che non le appartengono e sono anzi la cosa più lontana da sé), la Klein fa una lunga e dettagliata e inquietante serie di considerazioni che vi faranno dire a più riprese: ma allora non sono pazza, DAVVERO c’è qualcosa che non va.
Sostanzialmente Klein spiega per filo e per segno come l’attuale destra eversiva abbia creato, per usare le loro parole, “un mondo al contrario” che lei definisce “mondo specchio”.
Ossia una sorta di realtà parallela dove complotti sanitari e politici si mischiano a fanatismo ed eversione spacciata per tradizione, ritorno ai valori di una volta, disciplina e ordine (per gli altri ovviamente, per i “nemici”, agli amici è concessa ogni libertà, spacciandola per rivoluzione contro poteri misteriosi).
Tutto, letteralmente tutto, compreso lo sconcerto che prova lei nel non capacitarsi di come la gente creda praticamente agli asini che volano, sembrerà uscito dalla vostra testa.
In più, Klein fa una serie di considerazioni interessantissime su come, volenti o nolenti, internet sia diventato un luogo in cui siamo costretti a stare.
E’ stata infatti la scarsa cura della sua immagine in internet che ha permesso che il suo “brand” (fa un’analisi anche su come TUTTI adesso siamo dei brand anche se non vogliamo vendere nulla perché brand e identità personale si stanno fondendo ANCHE se non vogliamo) si confondesse con quello della sua omonima. Klein ha voluto rimanere ai margini del gioco e il gioco ha deciso per lei.
Riappropriarsi della propria identità quando qualcuno, il suo doppelganger in questo caso, te l’ha rubata, è davvero difficile.
Mi fermo qui perché questo libro ha dentro davvero tante tante cose e avrebbe meritato una diffusione e un dibattito degno di “No logo” (e sì, lo so, una traduzione migliore).
Cercatelo, leggetelo e davvero vi sentirete meno soli, meno pazzi e, se non altro, avrete nuove chiavi di lettura per leggere tanti fenomeni del nostro tempo.
LA SERIE DEL VICEQUESTORE NIGRA di Paolacci e Ronco:
Ogni anno cerco qualche nuova serie di gialli a cui appassionarmi e, devo dire, ho collezionato ormai una lunga serie di buchi nell’acqua anche quando i migliori presupposti sembravano esserci tutti (Ilaria Tuti sigh, grandissima per me delusione).
Questo luglio un’inattesa sorpresa è giunta per assoluto caso. Dolcemetà mi aveva chiesto un giallo da leggere e io avevo tipo 10 minuti di tempo per fare un giro all’usato (praticamente io ormai leggo grazie al mio fornitissimo negozio dell’usato di fiducia).
Presa dall’ansia, ho afferrato un libro dalla sezione dei gialli quasi a caso e ho visto che il protagonista era un vicequestore gay dichiarato che indagava su un delitto di matrice omofoba alla vigilia dell’approvazione delle unioni civili.
Prima mi sono chiesta perché non ne avessi mai sentito parlare, poi l’ho comprato e infine in neanche 2 pomeriggi l’ho letto.
Allora, mi è piaciuto TANTISSIMO. L’indagine non è particolarmente complessa (io devo dire che amo avere il trick del capire chi è l’assassino, ma non amo le trame talmente contorte che a un certo punto non ti ricordi manco più chi ha parlato con chi), ma non è quello l’importante.
L’importante, come anche nei gialli di De Giovanni, è tutto il resto: ambientazione, personaggi, dialoghi, gusto del racconto e della lettura.
Il protagonista è fantastico. Un personaggio originale, poliziotto gay dichiarato in un ambiente non proprio friendly che mena come un fabbro, affronta il pregiudizio, lo rigira verso chi lo sbandiera. Io mi sono rivista in praticamente tutti i dialoghi, nella stanchezza di dover ripetere le stesse cose, nell’assurdità di vivere in un mondo dove ogni 3 secondi o devi fare il wikipedia lgbt di etero pigri o devi adattarti a un contesto che non è nato per prevedere chi non fa parte dello standard.
E la narrazione è arguta, intelligente, vispa. L’orientamento sessuale di Nigra è trattato in modo credibilissimo ed è al contempo fondamentale EPPURE non viene usato in modo furbo e pigro.
Ossia Nigra è una persona gay non è il personaggio gay la cui unica peculiarità è quella.
C’è una differenza fondamentale che in troppi, se non in tutti, faticano a capire. Leggetela in questo libro gustosissimo e intelligente. Voglio trovare al più presto tutti gli altri della serie, purtroppo solo 3 (e spero all’usato).
CINQUECENTO ANNI DI RABBIA di Francesco Filippi ed. Bollati Boringhieri:
Ci sono tutta una serie di argomenti (è uno dei post che vorrei fare da mesi, ma rimane lì nel mondo delle idee) che incomprensibilmente vengono ignorati dall’editoria. O meglio, non so se vengano ignorati dall’editoria o non si producano saggi interessanti al riguardo, ma comunque si tratta di lacune nel dibattito pubblico piuttosto vistose.
L’analisi approfondita dei processi comunicativi alla base di internet e/o dei social è una di queste. Da brava laureata in archivistica e biblioteconomia non ho mai capito perché non venga fatto un parallelismo approfondito tra l’invenzione della stampa a caratteri mobili e internet.
È di recente uscita questo saggio che non sposa la mia tesi, ma almeno un po’ ci si avvicina o sembra tentare un’analisi di ciò che sta alla base della propagazione incontrollata delle informazioni.
L’autore vede un parallelismo tra stampa e social basandosi sul sentimento della rabbia che io sarei meno propensa ad avallare, ma è comunque interessante e comunque è un inizio.
Non proprio una lettura da ombrellone, ma non si sa mai.
LA MIA COSA PREFERITA SONO I MOSTRI 2 di Emil Ferris ed. Bao Publishing:
Non esattamente un libro da spiaggia data la mole, ma sicuramente un libro da estate data la mole.
Finalmente dopo anni esce il seguito di questa storia prodotta da Emil Ferris interamente con penne bic (o non so se bic, comunque penne).
Una storia di fantasmi della storia e fantasmi reali in cui una ragazzina orfana di padre (e presto anche di madre), appassionata di horror di serie z e innamorata di altre ragazzine, indaga sull’omicidio vicina di casa che forse era una vittima del nazismo o forse ne era complice e carnefice.
Siamo nel 1963, in un sobborgo americano e la ragazzina, come suo fratello maggiore, è di origine anche messicana e non è quindi in cima alla lista dei cittadini di serie A.
Tutti nascondono molti segreti e lei si aggira con le sue fattezze di piccolo mostro in un mondo più spaventoso dei suoi amati film. Finalmente in questa seconda parte scopriremo la verità?
Sì e no. Nel senso che si scoprono molte cose e appaiono molti altri bei personaggi, ma i fili, se posso dirlo, non vengono tirati insieme a dovere.
Si poteva disperdere meno e si poteva rendere il tutto più epico. Più che altro perché visivamente il libro è talmente incredibile, sontuoso, fantastico ed enorme, che i cedimenti della storia spiccano vistosamente.
Lato positivissimo: il queer accennato nella prima parte qui esce fuori in modo chiaro e gioca una parte importante.
In ogni caso un libro stupefacente: da comprare.
LA SCRITTRICE NEL BUIO di Marco Malvestio ed. Voland:
Segnatevi bene questo titolo per due motivi:
1) Ne riparleremo approfonditamente a ottobre, nei pressi di Halloween.
2) È, secondo me, uno dei romanzi italiani migliori degli ultimi anni.
Non esagero, nessuno mi ha pagato, nessuno mi ha spedito il libro, l’autore non è amico mio (anche se l’ho riconosciuto e inseguito alla Fiera del Libro per congratularmi del romanzo), e io, come sapete, non grido al genio ogni volta che una casa editrice mi invita a un aperitivo e mi invia un gadget carino (cosa che comunque non accade).
Siamo di fronte a un libro gotico letterario in piena regola, scritto benissimo e con un’idea originale e tradizionale al tempo stesso.
Un giovane ricercatore universitario di letteratura italiana, Marco, vive una competizione/attrazione con Federico, un collega più bello, ricco e capace di lui.
Un giorno il collega/rivale/papabile oggetto del desiderio svanisce nel nulla e decide di indagare.
Tutte le piste portano a una misteriosa scrittrice italiana degli anni ’60, tale Maria Zanca, che era stata attiva tra il veneto e Roma per poi sparire dai radar letterari e mondani alla misteriosa morte del compagno, anch’egli scrittore e deceduto in circostanze misteriose.
Ma chi è davvero Maria Zanca?
Attorno a questo interrogativo, più perturbante e inquietante di quel che può sembrare in principio, gira un romanzo raffinato e tenebroso che costruisce e inserisce all’interno del panorama italiano una figura letteraria in modo talmente convincente che è impossibile (ve lo dico) non controllare se essa sia esistita realmente e la storia abbia un fondo di verità.
Leggetelo, inquietatevi e poi a ottobre se ne riparla.
LE NOBILI SORELLE ANGIOY di Adriana Valenti Sabouret ed. Arkadia:
Ah, quanto mi manca la Sardegna!
In estate mi sento sempre un Cavalcanti qualunque che pensa “Poiché non spero di tornar giammai, ballatetta mia, in Sardegna!”.
Certo, tecnicamente, e conto in banca permettendo, posso tornarci quanto voglio, ma la Sardegna della mia infanzia e gioventù non esiste più perché siamo cambiate entrambe, nostro malgrado.
Questo però non impedisce all’estate di farmi venire ogni santo anno una nostalgia acutissima, difficile da tenere a bada.
I libri possono venire in aiuto. Ecco quindi individuato questo romanzo storico su tre sorelle nobili cagliaritane, figlie di un rivoluzionario in esilio a Parigi, in una Sardegna settecentesca.
Il padre le ha abbandonate e loro, orfane di madre, sono divise tra i fervori rivoluzionari del genitore e lo status quo sardo.
Consiglio sulla fiducia e sulla nostalgia per la Sardegna. Spero sia all’altezza delle aspettative.
Buone letture!
Il link alla segnalazione su I dolori della giovane libraia: https://tinyurl.com/2z5x8csy