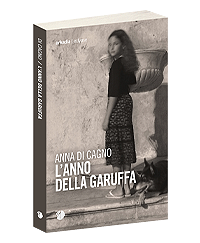“L’anno che Bartolo decise di morire” su Pulp Libri
Valentina Di Cesare e la tragicomicità di Bartolo il puro
Esistono narrazioni brevi, siano essi categorizzati romanzi come Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway, o L’amante di Marguerite Duras, siano essi racconti lunghi come La Metamorfosi di Franz Kafka o Lo zen e il tiro con l’arco di Eugen Herrigel (e così tanti altri, ognuno ben conosce i suoi), che possono sembrare esigui tra le mani, ma rimanere poi come pietre miliari simboliche nella mente di un lettore per molti anni, dopo averne capovolto o ricentrato alcune direzioni di pensiero. È quello che può capitare con L’anno che Bartolo decise di morire, breve romanzo di Valentina Di Cesare, uscito per Arkadia, facendo seguito alle precedenti prove narrative del romanzo d’esordio Marta la sarta (Tabula Fati, 2014) e del racconto lungo Le strane combinazioni che fa il tempo (Urban Apnea, 2018). La storia è semplice: un gruppo di amici di vecchia data trascina la propria esistenza tra progetti e ripensamenti in un piccolo paesino di provincia. Sono Roberto l’edicolante, Renzo il barista, Lucio che lavora all’ufficio tecnico di una nota azienda del luogo; e poi Vito, Giovanni, Roberto; e infine Bartolo, custode del museo del paese. La vita scorre tranquilla e apatica, fino a quando al licenziamento di Lucio fa seguito la sua progressiva discesa nel dispiacere e nello sconforto, in una depressione che esita nel suicidio. Bartolo appare il più coinvolto dalla vicenda, e si confida spesso con un anziano vicino di casa, ex maestro di scuola, che con riflessioni amare accompagna il suo sentire in molte cose. Già da prima che Lucio si togliesse la vita, con il passare degli anni una progressiva lontananza emotiva era intervenuta a raffreddare le amicizie all’interno del gruppo, e Bartolo in molte occasioni aveva cercato di risvegliare le coscienze su quanto stesse accadendo all’amico e su quanto avrebbero potuto e dovuto fare per lui, ma senza alcun esito. Una insana apatia sembra regnare sui pensieri e le azioni degli abitanti del piccolo paese senza nome, e nelle storie di vita degli amici di Bartolo le decisioni sembrano essersi prese da sé, nella ricerca del minor dispendio di energia possibile, come immergendosi nella corrente di un fiume dove scorre solo l’ovvio e il prevedibile. Anche quando in passato Fabrizio, un comune conoscente, si era dimostrato sempre più sleale e inaffidabile nei confronti di tutti, solo Lucio e Bartolo gli avevano parlato con durezza e sincerità, esprimendogli il loro biasimo per il suo continuo mentire e ingannare. Ma, a fronte di un apparente plauso da parte degli altri amici del gruppo, tutti avevano continuato a frequentarlo per comodità, opportunismo e quieto vivere. L’anno che Bartolo decise di morire è un romanzo che parla dello sbiadire dell’amicizia, e di come la purezza e il rigore possano divenire un handicap nella palude farisea di una società sempre più pigra e insoddisfatta, dove prosperano il subdolo e l’astuto, mentre l’individuo sincero appare sbagliato, ridicolo e tragico: “…ho capito con tenerezza che tu sei sempre stato tragico, e questa cosa mi faceva sorridere, non per prenderti in giro, lo sai, è il cuore che mi rideva con te, e succede anche adesso, perché è nella tragicità che si vede la tua intelligenza. Tu ti preoccupi, sei un osservatore incontentabile, uno preciso nei sentimenti, rigoroso nelle cose che non si vedono. Bartolo tu sei un drammatico, un macina-vita, e più sei tragico più a volte diventi comico…” Un libro che ha il coraggio di mettere in evidenza come ascolto, attenzione e precisione nei rapporti umani logorino, ma siano l’essenza stessa dell’amore e dell’amicizia: “Lucio, che si consumava dietro ai mutamenti del suo irrefrenabile umore, intanto si perdeva appresso a quelli del suo amico e lo faceva con un’attenzione sorprendente, con una precisione mai vista”; e ancora: “Il dolore degli altri non si ascolta, si sente […] e sentirlo vuol dire che riesci a percorrerlo con esattezza, pur senza conoscerne i contorni e le forme”. Dalle vicende narrate si evince bene come l’inerzia possa impadronirsi delle nostre azioni, delle nostre vite, portandoci dove non vorremmo: “Che Marzia e Giovanni finissero per sposarsi non c’era da aspettarselo, ma nemmeno da sorprendersi. Certe notizie somigliano alle onde residue, quelle che si intravedono sulla superficie dell’acqua anche in assenza di vento: chi le ascolta e le osserva nel loro propagarsi, sobbalza appena, perché sa che si tratta solo di conferme a un noto meccanismo”; e come essere fedeli a se stessi, rimanere aperti all’ascolto, essere umani fino in fondo richieda uno sforzo gravoso, duro, esasperato a volte, un rigore finanche penoso nel rimanere puri, nel continuare a fidarsi degli altri fino al limite della sventatezza:
“Uno che diffida non è mai completamente buono, vuol dire che si è già spostato dalla linea bianca, che usa il bilancino delle azioni, che si muove piano e accorto, che sa quando non parlare, che conosce il momento di andarsene e quello di restare, ecco quella non è già più bontà è qualcos’altro che non so come si chiama […] a me verrebbe da chiamarla disfatta questo sconfinamento dall’altra parte […] un tentativo goffo di allontanarsi dall’umano, una manovra assurda, ridicola, una virata per dimenticare la morte, credere di esserne esenti”. L’unica emozione rimasta vera ormai, rimane forse la rabbia, purché non declassata a rancore, o ancor peggio a invidia, ma la pura rabbia, con il suo valore salvifico e tagliente, la sua onestà: “La rabbia è la vita, la rabbia è il diritto, la rabbia è la dignità, la rabbia è quella che si sente quando vi dicono che state esagerando, che state inventando, che siete pesanti, che siete volgari con le vostre collere, che siete infantili, che non vale la pena prendersela, perché è così, è sempre stato così”. La prosa della Di Cesare è limpida, essenziale, le descrizioni sono pennellate ad acquerello. Metafore e similitudini si susseguono con ingenuità apparente, con una freschezza che entra sottopelle, e diviene irrinunciabile man mano che si procede nella lettura; la voce narrante è un sussurro cortese, neutro nei toni, che procede implacabile; e, nel suo accostarsi alle debolezze di ognuno senza giudizio, diviene maestosa. Una storia minuta, fatta di piccoli gesti e dialoghi, il senso del quotidiano di un Anton Čechov, di una Natalia Ginzburg, gli stessi toni pacati, familiari, dietro ai quali rimbombano pesanti verità. L’anno che Bartolo decise di morire è un romanzo che sa parlare di morte come perdita e dolore, ma anche come opportunità che implode in se stessa, se sopraffatta dall’immobilità e dall’indifferenza di chi è accanto: il cratere che rimane attorno a una sparizione, a una inclusione in profondità, rivela pareti troppo ripide perché qualcuno le voglia davvero scalare, cercando di comprendere. Nel romanzo c’è il dolore muto: “Dove si nasconde il dolore che non si può narrare? In che direzione va la morte? Tutt’altra cosa è osservare chi soffre. Chi respira in affanno, chi si rigira su se stesso, chi dice non è niente, sto bene, chi ripete no, non posso, la prossima volta, chi divora lo spasimo che come una tarma lo rosicchia dentro, chi guarda un fiore, una macchina, una pozzanghera con lo sguardo d’ombra, chi se ne va sempre troppo tardi o troppo presto, chi abita e veglia il sepolcro perché solo lì sa stare”; ma anche un avvicinarsi alle cose ultime con grazia possente, che richiama le pagine indimenticabili di La morte di Ivan Il’ic di Lev Tolstoj, traendo dalla fine una luce che dà dolore agli occhi, ma che mentre acceca, rivela: “Quando si accenna alla fine, lo si fa sempre con sgomento, come se si trattasse di qualcosa di impossibile, di proibito, interdetto, eppure lo dobbiamo capire da subito che la morte non è una presenza estranea. È un visitatore regolare, un uccello solitario che ogni sera torna al nido, senza il capriccio della compagnia, è il debito antico che la vita ha con se stessa”. Se la morte di Lucio perde la sua occasione di divenire riflessione e cambiamento, esita pur sempre in una piccola fiamma di dolore che retro illumina gli errori con la sua luce pallida, che può essere – almeno per Bartolo – presa di coscienza e di posizione. La morte che deflagra inaspettata, che è decisione consapevole di andarsene, può continuare a vibrare nella coscienza di chi resta e a disseminare il proprio monito. Ecco la delicatezza, la sospensione di giudizio, il garbo di Valentina Di Cesare: “Decidere di separarsi dall’esistenza a quel modo non avrebbe dovuto dare a nessuno, si disse Bartolo mentre fuggiva con lo sguardo oltre i vetri, la presunzione di misurare la sua scelta”. L’apertura di ogni capitolo riprende il tema della rinuncia e dell’abbandono di Bartolo, e le stesse parole ritornano, musicali, declinate come un verso poetico o come un mantra che ricentra il lettore sul tema principale. Che si tratti di un abbandono fisico o morale, reale o metaforico non è dato sapere e ben poco interessa, perché nel momento in cui ciò dovrebbe essere svelato in realtà il significato più profondo del testo si è già radicato. In questo breve romanzo c’è intensità, c’è il realismo degli umili di Ignazio Silone, a tratti il meditabondo favoleggiare di Dino Buzzati. Il racconto è ambientato in un piccolo paese della provincia abruzzese, sono le terre di Fontamara (Ignazio Silone) di L’arminuta (Donatella Di Pietrantonio), ma si tratta di un evidente luogo letterario, che potrebbe essere accolto in qualsiasi regione ai margini, nella pietrosa Sardegna di Grazia Deledda, nelle Langhe di Nico Orengo. Nel dare pochi riferimenti geografici, poche descrizioni fisiche ai personaggi, la storia acquista un che di indefinito, di universale, è sospesa in un non-luogo d’ovatta, assediato dalla modernità, dalla crisi economica, dalla disoccupazione, ma chiuso in un bozzolo di indolenza, di nebulosa eternità, di conformismo sociale che per contrappasso scivola nell’isolamento. L’anno che Bartolo decise di morire non è però un romanzo disperato, ma piuttosto consapevole, accorato, che riesce a parlare di bontà e di lealtà senza apparire ingenuo né vacuo; e forse il segreto di tutto questo si chiama ancora una volta delicatezza, e rispetto: “Ricordati che quando una parola è abusata, vuol dire che chi la pronuncia non ci fa più attenzione. […] E questa leggerezza vedi, questa facilità nell’enunciarla la svilisce, sembra un maglione indossato da troppe persone, c’è chi lo allarga, chi lo stringe, chi lo accorcia, chi lo macchia, chi lo ricuce. […] Le parole sono contenitori e, a seconda del concetto che contengono, devono farsi resistenti e forti…” Si rimane stupiti di fronte ai riverberi morbidi e prolungati che questo racconto dolceamaro diffonde a lungo nei pensieri del lettore, riaffacciandosi alla coscienza con la stessa educazione di Bartolo nel fare presente le sue verità, timido, educato, quasi a chiedere scusa, ma implacabile. Un romanzo che, per dimensioni e postura, vuole convincerci di essere qualcosa di piccolo, ma che riesce nell’impresa più grande: farsi amare con semplicità, rivelare per gradi la sua ricchezza di contenuto, far rallentare gesti e pensieri, farci riflettere su noi stessi.
Isabella Bignozzi
Il link alla recensione su Pulp Libri: https://bit.ly/3l6c2pA