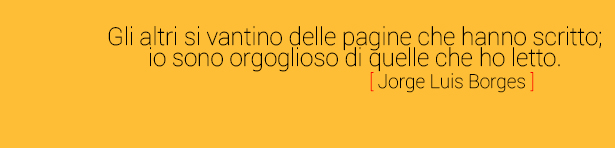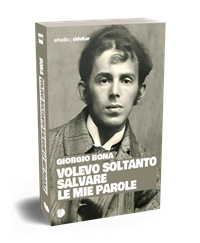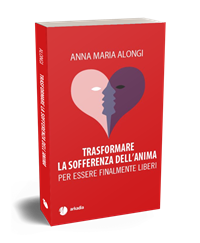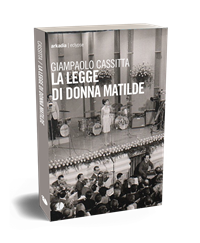“I giorni pari” su Satisfiction
Maria Caterina Prezioso. I giorni pari
Sinossi
Nel cuore di un’Italia lacerata dalla guerra e dalle leggi razziali, due adolescenti, Sara e Silvana, affrontano il proprio destino con coraggio e ostinazione. Un’ebrea costretta alla fuga e una ragazza fragile, reclusa in un sanatorio, si muovono in parallelo tra persecuzioni, malattia, abbandono e desiderio di riscatto. Attraverso le loro storie, “I giorni pari” racconta la Resistenza non solo come lotta armata, ma come gesto quotidiano di umanità, come cura, amore, memoria. Con una scrittura tesa e musicale, Maria Caterina Prezioso dà voce a personaggi indimenticabili e ci ricorda che anche nei tempi più oscuri si può scegliere di restare vivi.
Recensione
Con “I giorni pari”, Maria Caterina Prezioso ci consegna un romanzo che pulsa. Non è solo la storia di due adolescenti, ma un inno alla vita, alla lotta, alla memoria. Ambientato tra la Seconda guerra mondiale e il primo dopoguerra, dal 1940 al 1955, attraversa un’Italia dilaniata dal fascismo e dalle sue conseguenze. Due protagoniste, Sara e Silvana, due voci che si intrecciano in un racconto corale dove la scrittura si fa ritmo, eco, resistenza. Prezioso scava nell’animo umano, riflettendo la durezza del tempo come il battito di una farfalla che non si ferma. Con frasi brevi, ostinate, cariche di senso e musicalità, l’autrice racconta l’esistenza di chi – nonostante tutto – continua a vivere. Sara, giovane ebrea romana, vede crollare il mondo che conosce con l’emanazione delle leggi razziali: «Nel 1938, Mussolini aveva emanato le leggi razziali fasciste e per noi era cambiato tutto. Dall’oggi al domani.» Costretta a separarsi dalla sua famiglia per mettersi in salvo, parte per Sperlonga: «L’8 dicembre del 1940, nel primo pomeriggio, prendemmo il treno che ci portò a Fondi. Una valigia piccola per non dare all’occhio.» La sua esperienza in provincia è tutt’altro che un rifugio: ospitata da quello che diventerà suo marito, Giuseppe, scopre di essere stata oppressa e controllata. I suoceri – mantenuti dai suoi – la sfruttano e la ricattano minacciando di denunciarla come ebrea. Ma Sara non cede. Si fa guida anche per Giuseppe, che da uomo ignorante e meschino inizia un lento percorso di riscatto, grazie all’aiuto della compagna che gli insegna a leggere, scrivere, e a trovare dignità. Sara rappresenta un’etica della verità e della dignità, la forza di scegliere anche quando fa male. E nel cuore della sua storia, la figura intensa e tragica di Leone: l’amore giovanile che torna solo per ripartire. «Me ne vado, Sara. Ho conosciuto persone che la pensano come te. […] Libereremo l’Italia a costo della vita.» Con queste parole Leone si separa per sempre. Sara scoprirà poco dopo di essere incinta: il figlio è il futuro che nasce da una scelta consapevole, non da una fuga. Silvana, l’altra protagonista, si muove tra la freddezza glaciale della madre Caterina e la malattia che la consuma. La tubercolosi è per lei una condizione fisica e simbolica: una fragilità che dà corpo a un dolore emotivo. Ricoverata al Forlanini, incontra Orlando, un ragazzo che – come lei – è ai margini ma vivo, sorprendente, sincero. La loro storia d’amore è dolce, imperfetta, piena di attese e desideri semplici. Orlando la ama con pazienza e senza promesse grandiose. «Vorrei vivere con te e quindi presuppongo che occorra sposarsi.» La spontaneità disarmante di questa frase racchiude il cuore del personaggio: malato, impulsivo, ironico, visionario, ma capace di proteggere. Orlando incarna anche una forma di resistenza alternativa: non armata, ma umana, poetica. In una delle pagine più intense del romanzo, salva l’intero ospedale da un possibile rastrellamento. Il suo gesto impulsivo – prendere una pistola e affrontare il pericolo – non nasce da una strategia militare, ma da un istinto etico, radicale. «Orlando ci aveva salvato. Tutto l’ospedale era salvo.» Accanto a lui, la figura del professor Fegiz, pneumologo ebreo, è un ritratto dolente della fragilità intellettuale: uomo razionale, non eroe, ma testimone. Trema, ride, si commuove. E infine lascia che i ragazzi vadano a vedere Roma liberata. La sua paura non lo squalifica, lo umanizza. Il parallelismo tra Sara e Silvana si fa simbolico: entrambe partono con una piccola valigia. Non importa se la meta è Sperlonga o il Forlanini, ciò che conta è che partono per salvarsi. È il rito di passaggio che le trasforma. Ed è nel loro incontro che il romanzo tocca uno dei suoi vertici. «Continuavamo semplicemente a guardarci… uno specchio l’una dell’altra.» La frase è una cesura. Le due donne si riconoscono, si riflettono, si comprendono senza bisogno di parole. Sara si prende cura di Silvana, alzandosi presto per lei. Silvana le restituisce attenzione e affetto, riconoscendone la forza: «Gentile è un bambino speciale. E lei una donna particolare.» Nel loro silenzio si nasconde una sorellanza, una comprensione reciproca fatta di ferite e piccole gioie. La domanda «Riesce a capirmi? A leggermi?» è rivolta anche al lettore: siamo in grado di comprendere davvero chi abbiamo di fronte? Il romanzo si chiude con una tenerezza matura. Silvana vive un momento di sospensione, e chiede al dottor Fegiz: «Posso permettermi questo dono?» La domanda è profonda: si può davvero permettere la felicità dopo tanta sofferenza? E poi c’è Gentile, il figlio di Sara. Non è solo un nome, è un’eredità spirituale. Nato da una volontà ostinata, è figlio della giustizia, dell’amore che non si arrende. È il simbolo di ciò che resta, di ciò che fiorisce dopo il disastro. «Io resto, io cresco, io amo.» Gentile è un altare di senso, un bambino forte non perché ignaro del dolore, ma perché nato da esso. In lui si riflette tutto il romanzo: memoria e futuro, dolore e possibilità. La sua esistenza è un atto di riparazione, una carezza a ciò che è stato negato, dimenticato, distrutto. In ogni gesto tra lui e Sara – uno sguardo, una carezza – c’è un modo nuovo di essere madre, non protettiva ma complice. Gentile è la risposta alla violenza: esserci, ancora. “I giorni pari” è un romanzo necessario. Brucia sotto la pelle, attraversa il cuore e lascia un segno. Maria Caterina Prezioso intreccia sapientemente storie individuali e vicende collettive, con una scrittura asciutta ma poetica, semplice e profonda. Ogni scelta personale diventa atto politico, ogni sopravvivenza una forma di resistenza. In questo romanzo, la memoria non è solo peso: è forza.
Francesca Mezzadri
La recensione su Satisfiction